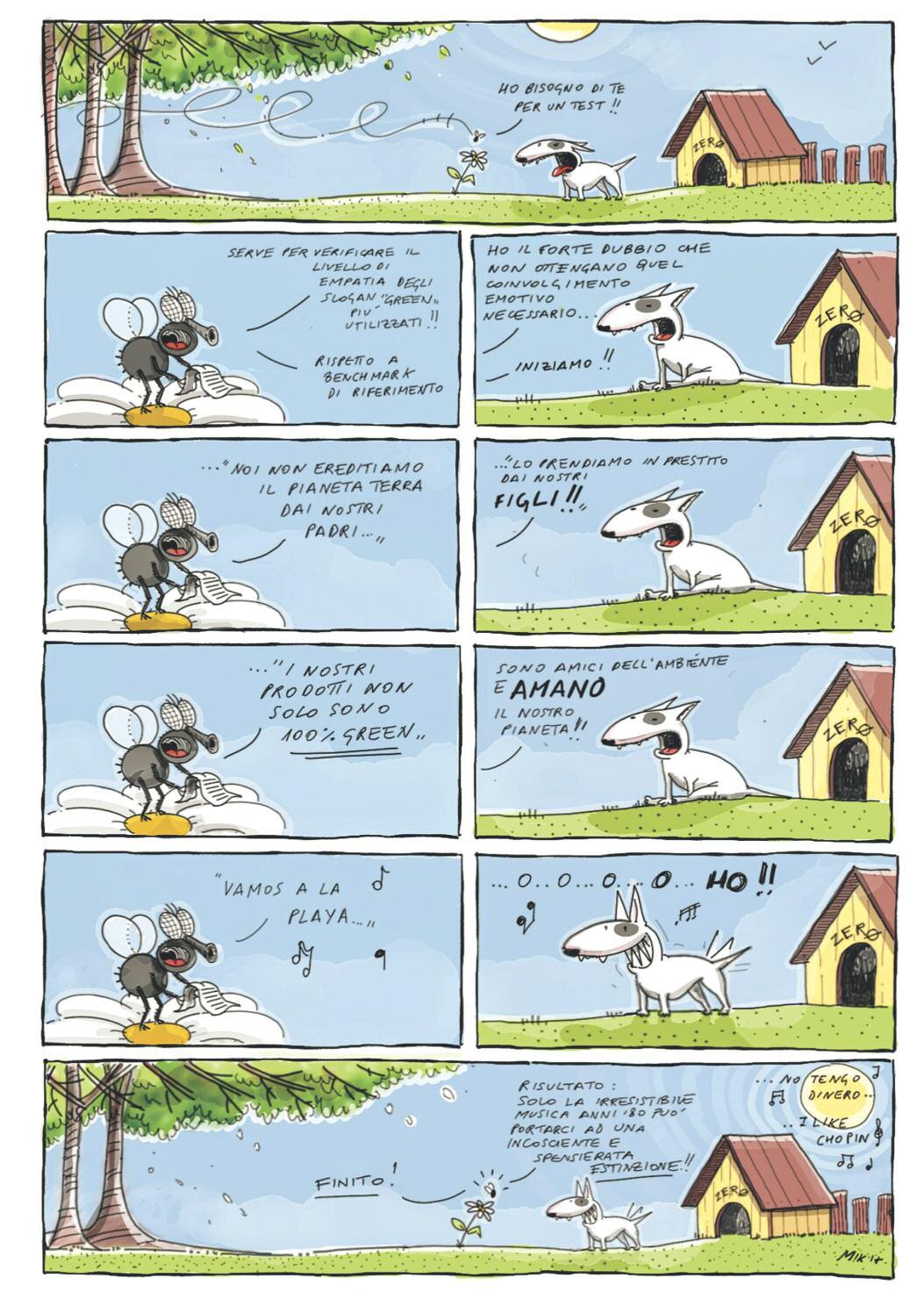FIERA INTERNAZIONALE PER IL RISANAMENTO E L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
24 - 27 GENNAIO 2018 / BOLZANO
Mer-Sab: 9.00-18.00
CONVEGNO
QUANTO È ATTUALE LA SOSTENIBILITÀ?
ENERTOUR VISITE GUIDATE A CASECLIMA
8
STARTUP AWARDS NUOVE IDEE ED INNOVAZIONE
www.klimahouse.it
ESPOSIZIONE

argomenti
dipende tutto dalla progettazione!
intervista al dr Wolfgang Feist, direttore del Passivhaus
Institut di Darmstadt, in occasione del 25° anniversario della costruzione della prima casa passiva certificata

12 26 38
progetti
Un ufficio eccezionalmente verde
Uffici della Geelen Counterflow, Haelen (NL)
Architecten en Bouwmeesters, Herten-Roermond (NL)
Mediterraneo sostenibile
Villa, Monopoli (BA)
arch Francesco Longano con geom Antonella De Marco, Monopoli (BA)
Il risparmio energetico salverà il mondo
Padiglione del Tempio Zen Tochoji, Tokyo (J)
KEY ARCHITECTS, Tokyo (J)
azero
rivista trimestrale – anno 7 n 25, dicembre 2017
Registrazione Tribunale Gorizia n. 03/2011 del 29.7.2011
Numero di iscrizione al ROC: 8147
ISSN 2239-9445
Direttore responsabile
Ferdinando Gottard
Redazione
Lara Bassi, Lara Gariup, Gaia Bollini
Editore
EdicomEdizioni – Monfalcone (GO)

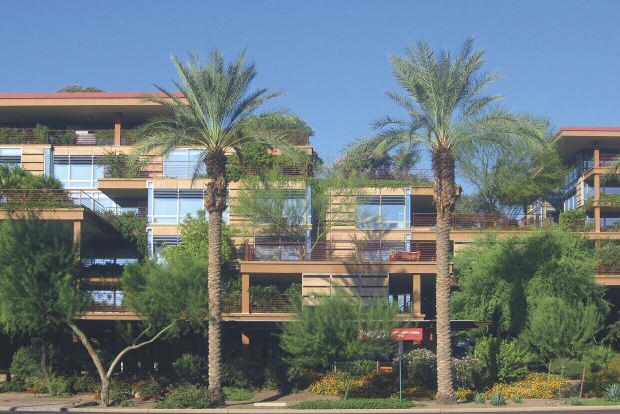
focus
Alla ricerca del Sole
Passive House, Cork City (IE)
Wain Morehead Architects Ltd , Cork (IE)
Sostenibilità energetica
Villa unifamiliare, Rovello Porro (CO)
Angus Fiori architects, Milano
Ca’ d’Oro
Bifamiliare, Udine
geom Paolo Paviotti, Udine
Processi e strumenti BIM a supporto della progettazione sostenibile
Giacomo Bergonzoni
innovazione
Biophilic Quality Index: come rendere “rigenerativo” l’edificio nZE
Rita Berto, Giuseppe Barbiero
back page
Michele De Beni
Redazione e amministrazione
via 1° Maggio 117 – 34074 Monfalcone (GO) tel 0481 484488 – fax 0481 485721 redazione@edicomedizioni.com www azeroweb com
Stampa
Grafiche Manzanesi – Manzano (UD)
Stampato su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate
Prezzo di copertina
15,00 euro
Abbonamento
Italia (4 numeri): 50,00 euro
Estero (4 numeri): 100,00 euro
Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno
Distribuzione in libreria
Joo Distribuzione via F Argelati 35 – Milano
È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore
Copertina
Villa, Monopoli (BA); foto: Antonio Tartaglione

A 25 anni di distanza dalla costruzione della prima Passivhaus certificata, sono state poste alcune domande a Wolfgang Feist, direttore del Passivhaus Institut di Darmstadt, in merito al processo che ha portato alla progettazione prima e alla realizzazione poi di quella che è tutt’oggi la residenza della sua famiglia.
Nonostante ci fossero all’epoca alcuni detrattori delle sue idee, il direttore del PHI ha dimostrato che rendere un edificio più efficiente dal punto di vista energetico è un processo possibile e duraturo.


Due immagini delle 4 case a schiera di Kranichstein, il sobborgo di Darmstadt che ha visto la costruzione del primo edificio certificato Passivhaus, all’inizio degli anni ‘90.
A sinistra, in primo piano, i coniugi Feist, davanti al fronte nord
In questa immagine, una parte del fronte sud
Lei è stato un vero pioniere 25 anni fa, con la costruzione della prima casa passiva al mondo, a Darmstadt. Si ricorda ancora lo spirito pionieristico di quel momento?
Certo che mi ricordo! Erano tempi movimentati. E, come generalmente succede, le persone si occupavano di cose diverse dal futuro del pianeta. Era il periodo del collasso delle cosiddette dittature del “socialismo reale”, quando la politica energetica era quasi sinonimo di politica nucleare.
Ad ogni modo, c’era un piccolo gruppo di persone che si occupavano della domanda fondamentale del perché abbiamo bisogno di così tanta energia: William Shurcliff, Arthur Rosenfeld, e Amorin Lovins negli USA, Harold Orr in Canada, Vagn Korsgaard e Joergen Noergard in Danimarca, Bo Adamson e Arne Elmroth in Svezia – una tale lista è sempre incompleta. La maggior parte di questi pionieri arrivava da discipline scientifi-
che anche molto diverse tra di loro ed erano impegnati nel diffondere l’utilità della scienza tra la gente.
Che cosa l’ha motivata a promuovere la Passivhaus nonché concetti di costruzione alternativi?
Già negli anni ‘70 era chiaro che l’era dell’energia fossile stesse finendo e che il problema principale di questa – allora economica – forma di energia era la produzione di biossido di carbonio. Comunque sia, in quel periodo ci si focalizzò sulla sostituzione dei combustibili fossili con quelli dell’era nucleare. Solo pochi scienziati, come ad es. il mio amico Klaus Traube, avevano attraversato l’arduo processo del valutare correttamente i rischi energetici derivanti dalla fissione nucleare.
Considerando la questione in modo obiettivo, era chiaro che fosse necessaria un’altra strategia risolutiva della questione legata all’energia fossile. Di conse-
guenza, affrontammo il problema alle sue radici: analizzammo per che cosa questo elevato quantitativo di energia, che veniva pompata dal terreno e i cui prodotti di scarto venivano rilasciati nell’atmosfera dopo i processi di combustione, venisse usato effettivamente Il risultato fu scioccante: la più grande quota singola di consumo energetico moderno veniva usata per riscaldare gli edifici, cosa che corrispondeva a circa 1/3! Fu immediatamente chiaro agli esperti di fisica che ciò si sarebbe potuto fare in modo più efficiente; era solo una questione di conversione A quel punto ci siamo dedicati ai problemi pratici legati ai sistemi di riscaldamento, della distribuzione del calore, delle finestre, dei tetti e dei sistemi di ventilazione
Che cosa aveva detto, quella volta, la sua famiglia riguardo al fatto che lei volesse costruire una casa in modo ‘alternativo’? Erano anche loro entusiasti come lei? Costruire una casa è già di per sé snervante e richiede molto impegno. Un progetto pionieristico ancora di più… Entrambi i nostri figli erano ancora piccoli ed eccitati riguardo a tutto ciò che accadeva intorno a loro Mia moglie Witta è stata un’attrice attiva del progetto fin dall’inizio; in fin dei conti, abbiamo completato assieme la maggior parte del nostro processo conoscitivo I nonni erano in effetti un po’ scettici ma ben disposti verso questa ‘idea balzana’ e ci hanno supportati per quanto hanno potuto E questo è giusto: dovevamo passare attraverso lo sforzo e lo stress assolutamente ‘normali’ di un processo costruttivo. E il fatto che volessimo costruire in un modo che era ‘diverso’ dal solito metodo non ce l’ha reso più facile. Ma abbiamo anche avuto dei supporti: gli architetti prof. Bott, Ridder e Westermeyer hanno dato forma praticamente a tutti i nostri desideri (solo verso la fine ci hanno preso un po’ in giro per i principi osservati in modo tanto rigoroso). L’IWU (Institut Wohnen und Umwelt - Istituto tedesco per l’Abitare e l’Ambiente) ha condotto una ricerca associata che accompagnasse il processo e che è stata finanziata dal Ministero dell’Economia del Bundesland dell’Assia.
Abbiamo nascosto centinaia di sensori nelle parti edilizie dell’edificio. Anche ciò, quella volta, è stato più impegnativo di quanto non possa essere oggi; poiché non esisteva ancora il ‘wireless’, si dovette cablare e posare correttamente centinaia di cavi.
Lei era uno dei quattro proprietari degli edifici che si erano impegnati nella costruzione di una Passivhaus come iniziativa privata. Chi erano gli altri?
Una zona edificabile era stata conferita dalla città di Darmstadt e c’era una lunga lista di candidati per i lunghi lotti che dovevano essere assegnati Coloro che soddisfacevano i criteri richiesti dall’amministrazione cittadina potevano richiedere questi lotti: doveva trattarsi di famiglie con un basso reddito E anche così, inizialmente, si è rivelata difficile la ricerca di co-proprietari È solo quando finalmente noi stessi abbiamo trovato il coraggio di costruire che sono state superate le inibizioni e sono arrivate tre famiglie, pronte a partecipare a questo progetto Tutti avevano professioni completamente diverse e non conoscevamo nessuno di loro in precedenza
Come siete riusciti a raggiungere un accordo per quanto riguarda l’edificio? O ci sono stati, a volte, for ti conflitti durante la fase di costruzione?
Un ruolo importante in questo senso è stato svolto dal reparto del supporto clienti di “Rasch und Partner” e dagli architetti, riuscendo a girare elegantemente intorno a qualunque ostacolo Questi partner erano a noi noti da progetti precedenti nei quali erano sempre riusciti a controbilanciare le forze centrifughe che sorgevano durante i progetti di costruzione assieme ad altre persone
Nel caso di questa prima casa prototipo, dovevamo convincere gli altri della razionalità delle soluzioni; ov viamente anche qui alcune scelte sono state derise (sia in segreto che apertamente) ma tutti erano anche curiosi di vedere se una casa che non necessitava di alcuna forma di energia per il riscaldamento avrebbe funzionato.
Avete semplicemente diviso i costi di costruzione tra le quattro famiglie?
Per la versione standard c’era un criterio di ripartizione. Era possibile ordinare degli “extra”, come una cucina separata o un particolare tipo di rivestimento di pavimenti che poi veniva pagato dalla rispettiva famiglia. In generale, però, le quattro case sono organizzate in modo identico, almeno per quanto riguarda la loro qualità strutturale. Tutte sono Passivhaus, anche in base ai criteri attuali.
Per i costi aggiuntivi di investimento (che erano ancora
rilevanti a quel tempo), pari a circa 90 000 marchi tedeschi per unità abitativa, un aiuto del 50% è stato offerto dal Ministero dell’Economia del Bundesland dell’Assia A quel tempo l’energia era molto più economica di oggi Tuttavia, per un tale progetto di ricerca, l’efficacia economica diretta del prototipo non era un punto chiave Si doveva, piuttosto, verificare che il concetto funzionasse Anche se la riduzione dei costi per i componenti era già stata presa in considerazione durante la selezione delle soluzioni, essa doveva essere garantita anche per gli edifici del futuro È stato lo stesso con altri sviluppi tecnici: i primi calcolatori tascabili costavano circa 2000 marchi tedeschi, ma dopo che è diventato chiaro come funzionavano e che funzionavano, è stato possibile ridurre drasticamente i costi
La composizione delle famiglie nella sua casa a schiera è ancora oggi la stessa? Vi capite ancora bene l’un l’altro?
Una delle famiglie proprietarie ha ceduto la propria unità Le altre hanno figli e vivono fasi diverse, come in tutte le parti del mondo
Come di consueto oggi, i co-proprietari hanno formato una partnership basata sulla reciproca convenienza Nel progetto pilota c’è stato il tentativo di offrire un uso comune di alcuni spazi, come quelli della lavanderia e della stanza per stendere la biancheria, laddove ciò po-
teva risultare vantaggioso Questa idea arrivava dalla Svezia dove certe facilities sono abbastanza comuni Tuttavia, per essere onesti, questo tentativo non ha avuto molto successo nel nostro caso, probabilmente perché le nostre tendenze sociali si stanno muovendo in direzione di una maggiore individualizzazione
Oggi è più probabile andare e comprare un trapano elettrico piuttosto che prenderne in prestito uno dai vicini Tali tendenze hanno un impatto anche su questi tipi di joint venture costruttive
Il vostro complesso residenziale a schiera è spesso aper to al pubblico e ancora oggi è oggetto di molte indagini tecniche. Com’è vivere in una tale ‘casa da esibizione’ e ‘oggetto di prova’?
Beh, all’inizio è stato divertente – nei primi due anni abbiamo avuto circa 5 000 visitatori nelle nostre case
A un certo punto, però, mia moglie e io abbiamo notato che tutte queste visite ci causavano molto stress e le abbiamo limitate
La tecnologia e le misurazioni non sono affatto state percepite dagli inquilini Abbiamo prestato molta attenzione a questo, oltre che a salvaguardare la privacy; tutti i dati erano anonimi
Avevate un modello di riferimento? In Scandinavia le case a basso consumo energetico erano rela-
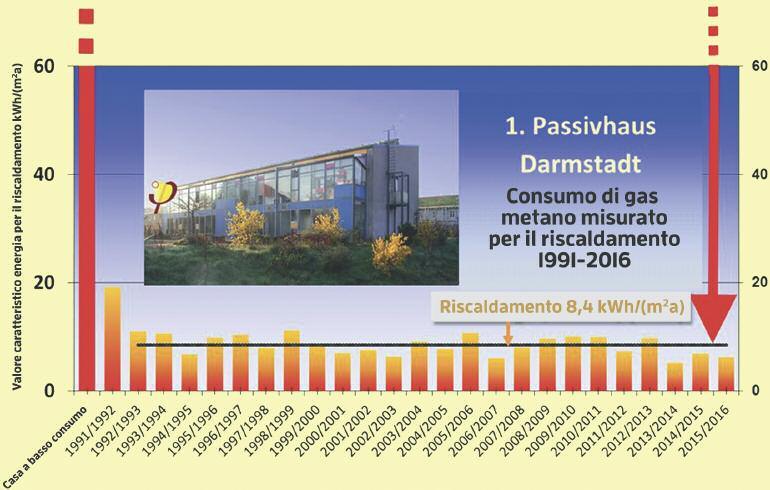
La Passivhaus è più che “solo” una casa a basso consumo energetico Una casa passiva, infatti, consuma il 90% in meno di calore per riscaldamento di un edificio convenzionale esistente
E anche rispetto a una nuova costruzione ordinaria, è possibile risparmiare più del 75%
Il consumo di energia per il riscaldamento di una casa passiva è molto più basso di quello di una casa a basso consumo energetico ed equivale a 1,5 litri di olio combustibile per m2 di superficie abitabile per anno
Il riscaldamento rimane quindi sostenibile economicamente, anche in tempi di crisi.
tivamente comuni già quella volta …
La Passivhaus si inserisce in una tradizione che si è evoluta nei secoli Ad esempio, se si guardano i valori specifici relativi alla perdita di calore dei componenti esterni degli edifici, si nota che essi stanno diminuendo gradualmente negli ultimi cento anni Hanno cominciato con circa 1,5 e ora hanno raggiunto circa i 0,15 (W/m2K) con la casa passiva, cioè 1/10 del valore iniziale
Abbiamo seguito molto attentamente gli sviluppi scandinavi e nordamericani La Svezia, infatti, già nel 1980 aveva un regolamento sull’edilizia che corrispondeva alla nostra attuale “efficiente” EnEV (7 litri di olio combustibile equivalente per m2 e anno) Abbiamo avuto stretti contatti con gli scienziati in Svezia e negli Stati Uniti Bo Adamson, per esempio, mio collega in Svezia, ha lavorato con me al progetto
Perché la prima Passivhaus si trova proprio a Darmstadt?
Ciò è dovuto a una serie di coincidenze ma anche al desiderio espresso dell’allora sindaco della città, Günther
Metzger La città aveva già un terreno riservato alla “costruzione di alloggi sperimentali”, la maggior parte dei quali già urbanizzata Responsabile per la parte innovativa è stato l’ “Institut Wohnen und Umwelt”, di cui ho detto prima Era lì che lavoravamo e, proprio per
questo, avevamo lì contatti a livello internazionale in cui si discutevano queste idee La Passivhaus è un conseguente, ulteriore sviluppo della casa a basso consumo energetico Le perdite di calore inutili attraverso muri, tetti e finestre sono stati ridotti nella misura in cui un sistema di riscaldamento è diventato completamente irrilevante; è richiesto l’equivalente di soli 1,5 litri di olio combustibile per m2 e anno
Come reagirono altri esper ti e altri fisici edili ai suoi progetti relativi alla Casa Passiva?
In modo completamente diverso – il mio supervisore PhD era riservato ma ben disposto e seguì da vicino gli sviluppi Altri – i cui nomi non menzionerò qui –hanno pubblicato trattati teorici che spiegavano che un tale concetto non avrebbe mai funzionato, nello stesso anno in cui questo complesso residenziale a schiera è stato messo in funzione
Quanto ci ha messo a progettare il concetto di casa passiva nella sua mente e fino alla decisione nel senso di “ok, lo stiamo finalmente facendo”?
L’idea fondamentale è nata da un discorso con Bo Adamson che si svolse nel 1987 circa a Lund, in Svezia Era appena tornato da un viaggio di ricerca dalla Cina meridionale, dove era stato coinvolto nel miglioramento del comfort nelle case non riscaldate, che egli


definiva, appunto, “case passive”
Questo termine (Casa Passiva, ndt) deriva dal fatto che questi edifici funzionano come un sistema passivo in termini termici – e lì tutto diventa molto più semplice, anche l’analisi scientifica del sistema stesso Decidemmo dunque di cercare un progetto di ricerca per valutare se questo sistema avrebbe potuto funzionare anche in Europa, con i suoi inverni molto più freddi
Siamo stati in grado di creare un ‘progetto di ricerca pre-costruzione per le case passive’ in cui erano state considerate tutte le varianti concepite che, in teoria, sembravano veramente funzionare Innanzitutto era di importanza decisiva sviluppare una procedura affidabile con la quale potesse essere rappresentato il comportamento termico degli edifici
Quanto è durata la pianificazione architettonica e tecnica finché non è iniziato a muoversi il primo escavatore?
La pianificazione architettonica portò via lo stesso tempo che era solito per quel periodo – poco meno di un anno – e il lavoro iniziò nell’ottobre 1990 Sapevamo che un concetto promettente in termini generali non poteva comunque andare troppo lontano dai metodi costruttivi tradizionali; gli esperimenti “esotici” sono stati una fase di passaggio nel settore dell’edilizia, caratterizzata da piccole e medie imprese Abbiamo

quindi cercato di semplificare le cose piuttosto che complicarle E, per quanto possibile, abbiamo fatto ricorso a componenti disponibili, come le pareti in blocchi di cls, il tetto di ardesia, le finestre in legno
I componenti che oggi caratterizzano una casa passiva non erano ancora disponibili sul mercato. Prendiamo, per esempio, i tripli vetri bassoemissivi: effettivamente non esistevano sul mercato Ricordo ancora con precisione la conversazione che ebbi con l’allora ricercatore dell’azienda di grandi lastre di vetro "Vegla" (oggi Saint Gobain), il Dr Ortmanns: “Tre lastre di vetro con rivestimento su 3 e 5 - bene, possiamo fornirle per un tale progetto”
Ma non è stato sempre così facile e di successo Per esempio, non abbiamo potuto ottenere i distanziatori termicamente separati in modo altrettanto rapido; sono passati anni prima che l’industria pertinente a questi elementi riconoscesse le opportunità in questo campo – ov viamente ora li abbiamo Altre volte abbiamo dovuto fare noi stessi le componenti necessarie, per così dire in laboratorio Questo è stato il caso, ad esempio, della modifica delle quattro unità di ventilazione centrali, tutte dotate di ventilatori a corrente continua sviluppati appositamente per il progetto (che pure oggi sono dati per scontati) e una unità di controllo per la qualità dell’aria
Qui a fianco, un’immagine del fronte ovest effettuata nel 2001
Nella pagina a fianco, la termografia dello stesso fronte ovest, effettuata in data 01 01 2016
A parte alcune variazioni (nel frattempo è cresciuto un albero, è venuto meno l’elemento oscurante coibentato della porta che conduce sul tetto, parte del fotovoltaico in copertura è stato ampliato con ulteriori pannelli un paio di anni fa), la facciata mostra una temperatura assolutamente omogenea: non vi sono indicazioni di ponti termici (cedimenti, rotture o simili) o alterazioni delle proprietà del materiale L’isolamento della prima casa passiva è ancora completamente intatto dopo 25 anni
Gli unici punti che spiccano nella termografia sono rappresentati dalla vetrata della porta-finestra che conduce alla copertura e dalla bocchetta d’uscita dell’aria interna esausta (il punto rosso sulla destra)
Come reagì il falegname quando gli chiedeste di creare finestre con tre vetri? È stato cooperativo? Ebbene, si rifiutò di accettare la responsabilità – era proprio come oggi con le innovazioni Che la maggior parte degli artigiani coinvolti non sia d’accordo con le innovazioni è semplicemente una storia già sentita Tuttavia, durante del processo di costruzione, ho sperimentato personalmente il fatto di lavorare assieme con gli operai e di installare lo strato di tenuta all’aria secondo i principi Passivhaus che si applicano ancora oggi La membrana è stata applicata ordinatamente ovunque senza pieghe, era solo un po’ sgualcita laddove ci ero passato sopra con i piedi L’artigianato ha una lunga tradizione in Germania ed è un’enorme opportunità per questo paese avere così tante piccole e medie imprese altamente competenti sul mercato I falegnami, soprattutto, hanno risposto molto rapidamente al nuovo sviluppo, hanno ampliato le loro competenze e hanno fornito soluzioni notevolmente migliorate
Cosa farebbe di diverso oggi, per quanto riguarda la costruzione della sua casa passiva?
Oggi avrei orientato leggermente il tetto in direzione sud, perché sono stati fatti enormi progressi nel campo della tecnologia fotovoltaica E avrei, ov viamente, utilizzato i componenti certificati Passivhaus oggi disponibili, che sono per quasi il 50% migliori delle soluzioni che abbiamo costruito noi stessi, ad esempio le finestre.
Semplificherei ulteriormente il sistema di ventilazione, anche se la soluzione usata è risultata abbastanza efficace e utilizzerei pompe di calore per il riscaldamento.
Ma sarebbe sicuramente di nuovo una Casa Passiva. Questo è ciò che si è dimostrato di maggior successo: aria fresca costante, un clima indoor sempre confortevole e costi di riscaldamento trascurabili.
Quali consigli darebbe oggi ai proprietari di abitazioni private, interessati a costruire una casa passiva?
Ciò che conta è la progettazione! È necessario eseguire un calcolo completo secondo il PHPP e il progetto dovrebbe essere certificato; non costa molto e assicurerà che, dopo, tutto funzioni come dovrebbe.
Non fatevi accollare extra costi! Tutti i componenti della casa passiva sono disponibili oggi a prezzi equi.
Investire in una casa passiva ben progettata non è molto più costoso che investire in una casa ordinaria Assicuratevi che il sistema di ventilazione sia semplice e che si utilizzi un’unità di ventilazione certificata e insistete su filtri d’aria fresca di alta qualità, per questioni di salute Prestate attenzione anche alla determinazione del comfort estivo nel PHPP Le estati future saranno ancora più calde: una casa passiva può essere pianificata in modo che rimanga confortevole anche nei periodi più caldi dell’anno
Lei è stato un pioniere della casa passiva. Oggi insegna ‘costruzione di edifici efficienti’ all’Università di Innsbruck. Ne è passata di acqua sotto i ponti... Il mio lavoro di insegnante include un corso di fisica di base, tra le altre cose - dopotutto, sono un fisico! Ed è per me un grande divertimento avere a che fare con gli studenti Oggi la scienza costituisce la base della nostra civiltà, che si basa molto sulla tecnologia; ma la scienza ha anche un dovere culturale: comprendere dove noi, come esseri umani, ci inseriamo nell’immagine complessiva nel cosmo Come l’astrofisico Carl Sagan ha formulato in maniera meravigliosa: “Noi siamo un modo per il cosmo di conoscere se stesso” Abbiamo una responsabilità per questo grande sviluppo ed è nostro dovere trattare con rispetto il pianeta e i nostri simili
Lei viaggia in tutto il mondo per promuovere la Passivhaus ed è costantemente in movimento. Sta progettando una piccola casa passiva ai margini di un bel lago da qualche par te dove stabilirsi un giorno?
“Se dirò all’attimo: fermati dunque! Sei così bello...”
Johann Wolfgang Goethe ha riconosciuto e descritto con queste parole la natura contraddittoria dell’animo umano: per me, la piena realizzazione non si trova nel rilassamento passivo, non al momento; il piacere proviene da una conoscenza sempre crescente, vorrei avere più tempo per quest. Vorrei solo essere meno consumato dalla routine quotidiana. Quindi no, non ho ancora intenzione di ritirarmi dal caos e dalla frenesia della vita.
Qual è il suo desiderio per il futuro?
Continuare il processo di autorealizzazione come
viene descritto così accuratamente da Ernst Bloch nel suo “Principio della speranza”: “[Io sono Ma non mi possiedo ] Per questo innanzitutto diveniamo”
L’uomo ha appena iniziato questo processo di scoperta di sé Abbiamo fatto progressi sostanziali fin dai nostri primi tentativi di utilizzare il fuoco, non solo in termini tecnici ma anche culturali
Abbiamo capito che siamo un’unica specie – solo con piccole differenze dal Capo di Buona Speranza fino all’Alaska Abbiamo trionfato in gran parte sulla fame e sulle malattie e dovremmo vedere come nostro compito primario continuare a migliorare
Siamo stati in grado di portare – in larga misura – la pace nella nostra vita quotidiana, ma non abbiamo ancora superato le guerre Tuttavia, un’umanità che ha ancora bisogno di migliaia di anni per il suo processo cognitivo dipende dagli accordi internazionali di pace
La comprensione delle preoccupazioni e delle motivazioni della gente è la chiave di questo Dobbiamo distruggere le armi nucleari rimanenti o metterle sotto controllo internazionale Le generazioni presenti devono porre fine alla dipendenza dalle fonti energetiche fossili Solo allora potremo far progredire il processo cognitivo, prolungare la nostra durata di vita con dignità, moltiplicare le nostre possibilità di comunicazione, sfruttare il sistema solare e persino viaggiare verso stelle lontane sarà a portata di mano per le
generazioni future
Sono sufficienti questi desideri per il futuro? Beh, alcune cose non possono essere comprese al momento; Ernst Bloch aveva ragione quando disse “ per questo innanzitutto diveniamo”
L’intervista è stata condotta da Katrin Krämer, addetta al servizio stampa del Passivhaus Institut di Darmstadt
La prima Passivhaus del mondo è stata oggetto di numerosi studi, sin dalla sua costruzione 25 anni fa Nel 2016, anno dell’anniversario, gli esperti hanno esaminato quest ’edificio pionieristico fino all’ultimo dettaglio
Di seguito, alcuni dei risultati più importanti emersi dallo studio “Dauerhaftigkeit von Effizienzmaßnahmen” (“Durata delle misure di efficientamento”) e presentato in occasione della fiera BAU 2017 di Monaco di Baviera:
• L’isolamento termico è completamente intatto dopo 25 anni
• I valori dei consumi energetici rimangono costantemente bassi In una media a lungo termine, viene risparmiato il 94% dell’energia di riscaldamento rispetto alla media statistica
• La prima casa passiva al mondo è ancora a tenuta d’aria nel 2016, secondo lo standard Passivhaus
• Il sistema di ventilazione funziona ancora perfettamente L’efficienza del recupero di calore è rimasta invariata a oltre l’80%.
• I valori delle sostanze chimiche e l’esame microbiologico della qualità dell’aria non rivelano alcun carico dal punto di vista dell’inquinamento indoor

Una delle 4 unità abitative di cui si compone la Passivhaus di Kranichstein ha ampliato l’impianto FV aggiungendo alcuni pannelli orientati a sud

Uffici della Geelen Counterflow, Haelen (NL)
Outstanding è infatti la valutazione ricevuta dallo standard BREEAM, con il punteggio di 99,94%, per i nuovi uffici della ditta Geelen Counterflow, produttrice di essiccatori e refrigeratori per l’industria alimentare. I motivi di tale valutazione? Innanzitutto una struttura in legno massiccio proveniente da boschi gestiti in modo sostenibile della Foresta Nera ma anche un’impiantistica all’avanguardia che sfrutta solo risorse rinnovabili. Scelte progettuali che hanno consentito, inoltre, alla ditta olandese di vincere l’edizione 2017 dei BREEAM Award nella categoria Nuovi Uffici.


Geelen Counterflow, un’azienda a conduzione famigliare fondata nel 1980 a Haelen, nei Paesi bassi, è nota per produrre essiccatori e refrigeratori per l’industria alimentare, sia umana che animale; tutti i reparti della ditta, dalla Ricerca&Sviluppo, all’ingegnerizzazione dei prodotti, alla produzione e assemblaggio degli stessi hanno luogo a Haelen e molti dei macchinari qui prodotti vengono esportati, soprattutto fuori Europa. Gli essiccatori e i refrigeratori controcorrente della Geelen Counterflow risultano, infatti, essere energeticamente più efficienti rispetto ad altre tecnologie attualmente utilizzate oltre a essere noti per i loro design ‘igienici’, facili da pulire e da ispezionare.
Questa premessa sulla tipologia dei prodotti della Geelen non è stata fatta a caso, perché proprio il loro impegno nel realizzare essiccatori e refrigeratori di qualità ha portato l’azienda stessa ad ampliare la propria produzione costruendo, da un lato, la sede che oggi può vantare il più alto punteggio mai raggiunto dello standard BREEAM nella categoria Nuovi Uffici, dall’altro a impegnarsi ulteriormente nello sviluppo dei prodotti, affinché siano sempre più prestanti e più
indipendenti da energie fossili
Il sito originale consisteva di oltre 10 000 m2 di officine produttive e circa 650 m2 di uffici Avendo visto negli anni una crescita costante, si decise di costruire un nuovo edificio per gli uffici che fosse altamente efficiente e contemporaneamente organizzato verso l’aumento che ci si aspetta della forza lavoro nei prossimi 10 anni. Il nuovo edificio ospita oggi 50 postazioni di lavoro e include facilities per i 90 lavoratori del reparto amministrativo della Geelen. Si tratta di un edificio che ospita in maniera efficiente i processi di lavoro, cercando, inoltre, di massimizzare l’interazione tra i dipendenti, comprendendo funzioni come reception, sale riunioni, sale per la stampa, lavanderie e un patio coperto accessibile dalla caffetteria, ripostiglio e spogliatoio per il personale del laboratorio. Le collocazioni in pianta di queste diverse funzioni sono state decise sulla base della logistica del flusso di lavoro, prendendo in considerazione il traffico del personale da e verso le officine di produzione adiacenti.
La nuova sede della Geelen Counterflow è considerato, a oggi, l’ufficio più sostenibile del mondo,

Progetto e certificazione BREEAM
Architecten en Bouwmeesters, Herten-Roermond (NL)
Struttura in legno, statica Rombach Bauholz und Abbund GmbH, Oberharmersbach (D)
Direzione dei lavori
Wagemans Bouwadviezen & Bouwmanagement BV, Sittard (NL)
Impiantistica
Dubourgraaf, Goes (NL)
Ecologia Laneco, Ede (NL)
Lavori 2014-2015
Superficie lorda 2 800 m2
Superficie verde 1 800 m2
Certificazione
BREEAM Outstanding; punteggio: 99,94%
avendo ottenuto un punteggio del 99,94% e il rating di outstandig (eccellente) secondo il sistema internazionale BREEAM, in grado di rendere misurabili le prestazioni di sostenibilità e assicurare che l’edificio sia valutato oggettivamente
Applicando il sistema BREEAM, il team di progetto ha potuto utilizzare uno strumento che ha contribuito al processo decisionale delle varie fasi, con la garanzia di avere creato un ambiente di lavoro confortevole e sano per i dipendenti
A sinistra, la facciata sud dei nuovi uffici della Geelen Counterflow, con le grandi vetrate che affacciano sul giardino.
Sotto, uno scorcio degli ambienti interni di collegamento e la grande parete verde che purifica l’aria indoor

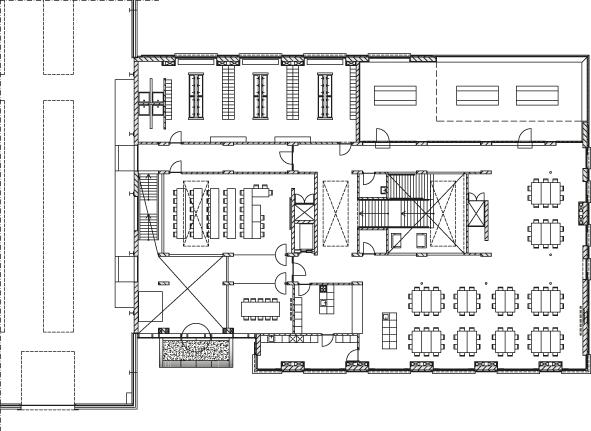
piano primo
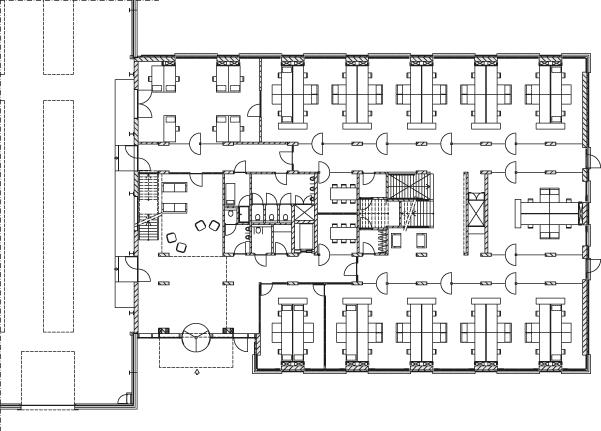
piano terra

È stata condotta un’analisi costi-benefici per i vari elementi rilevanti della costruzione (costi di costruzione, di manutenzione ed energia) Un aspetto importante emerso riguarda gli effetti “indiretti” dei benefici, come la riduzione dell’assenza di malattia dovuta a un più sano ambiente di lavoro grazie a un clima indoor ideale Per ottenere i migliori risultati possibili, tutti i componenti dell’edificio sono stati valutati sulla base dell’analisi del costo del ciclo di vita (LCA)
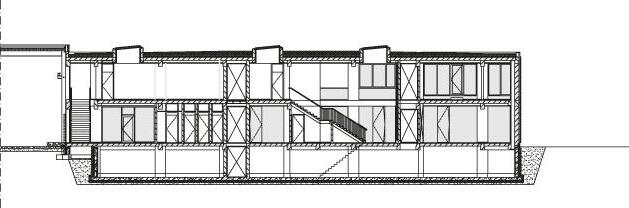
sezione longitudinale
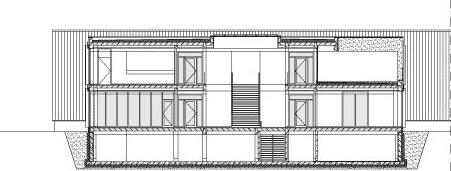
sezione trasversale
Consumo energetico per riscaldamento 14 kWh/m2a
Tenuta all’aria
n50 = 0,46 h-1
Energia primaria
63 kWh/m2a
Emissioni evitate di CO2
2 400 kg/anno
Parete esterna
U = 0,25 W/m2K
Copertura
U = 0,09 W/m2K
Superfici trasparenti
Uw = 0,90 W/m2K

La struttura portante degli uffici è costituita da elementi in legno massiccio costituiti da travi e tavole di legno di conifera, collegate tra di loro in forma trasversale (orizzontale e diagonale) con viti di legno di faggio da 20 mm (circa 15 per m2), senza colla. Tutto il legname impiegato proviene dalla Foresta Nera (D). Tutti gli elementi sono posati sulla struttura del seminterrato, costituito da elementi in calcestruzzo prefabbricati in cui è stata utilizzata una percentuale (almeno il 20%) di granuli di cemento riciclato. Nel processo di produzione degli elementi portanti, le tavole di legno che compongono gli strati sono disposte in modo trasversale e diagonale sul tavolo di montaggio. Vengono quindi fresate le filettature interne nelle tavole, in cui vengono successivamente av vitate le viti di faggio. Le diverse umidità dei due legni (quello di conifera e quello di faggio) forniscono un importante fattore di stabilizzazione. Infatti, mentre le viti in legno massic-
cio hanno un contenuto di umidità del 6-8%, gli elementi della parete hanno un contenuto residuo di umidità del 12-13%, pertanto, a causa del bilanciamento dell’umidità, la vite – più dura – assorbe umidità dalla parete, allargandosi. Questo crea un’adesione stabile nell’elemento in legno massiccio, impedendo che si creino fessure di restringimento. L’intero involucro del nuovo edificio è composto in totale da 229 elementi parietali e 265 elementi di solaio, con altezze di 2,60 m al piano terra terreno e al primo piano.
La dimensione dell’elemento di parete più grande è di 7,63x0,35x2,85 m, con un peso di 3,2 tonnellate, mentre il più grande elemento di solaio misura
5,18x0,25x2,85 m e pesa 1,7 tonnellate. Il collegamento degli elementi a parete e di quelli a solaio l’uno con l’altro è stato eseguito con viti filettate delle dimensioni di max. 8x330 mm (soffitti) e max. 10x480 mm (pareti), av vitate trasversalmente e in coppia..
Piano interrato/solaio piano terra:
1 triplo vetro
2 controparete per passaggio tubi e canali di installazioni
3 pannello in legno di chiusura laterale
4 zoccolo in legno (12x55 mm)
5 finitura del pavimento
6 pannello in gessofibra sottopavimento
7 nastro adesivo sigillante
8 serramento in legno
9 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x47x8 mm)
10 isolamento in lana minerale
11 pannello sandwich coibente, con lamina d’acciaio (3 mm) anteriore rivestita, incollato (93 mm)
12 membrana EPDM
13 parete esterna continua cava in cemento
14 solaio in legno massiccio
15 trave di banchina
16 trave di legno a supporto del solaio
17 isolamento (200 mm)
18 riempimento in cls
19 pilastro in legno
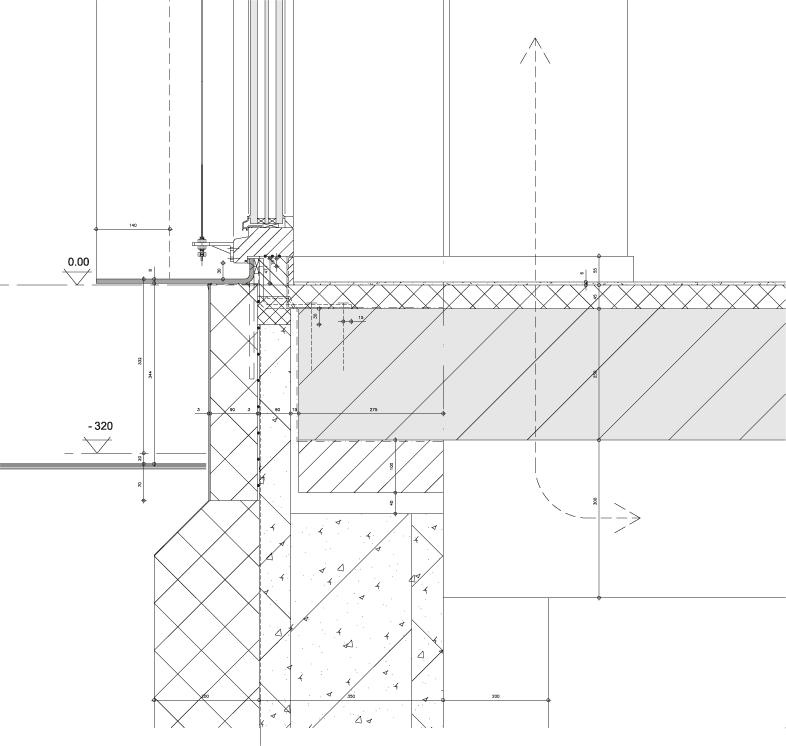

pareti esterne
Le finestre e le aperture delle porte, così come i fori e gli alloggiamenti per il montaggio delle installazioni impiantistiche, vengono eseguiti già in fabbrica In questa immagine, la posa di una parete interna, di spessore minore rispetto a quelle
Copertura:
1 copertura
2 barriera al vapore
3 rivestimento del tetto in alluminio verniciato
4 elemento di compensato impermeabile (18 mm)
6 lamiera d’acciaio rivestita (365x80x6 mm)
7 membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore
8 cordolo di copertura in legno massiccio
9 isolamento in pendenza (min 250 mm)
10 montanti in legno (90x50 mm)
11 elementi verticali in legno aperti della facciata (ca. 60x35 mm)
12 listelli orizzontali di legno (60x35 mm)
14 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x80x8 mm)
15 protezione solare: veneziane orizzontali regolabili
16 trave in legno massiccio
17 elemento d’acciaio rivestito, a protezione delle veneziane, saldato nel telaio
19 serramento in legno
21 triplo vetro
22 pannello in legno di chiusura laterale
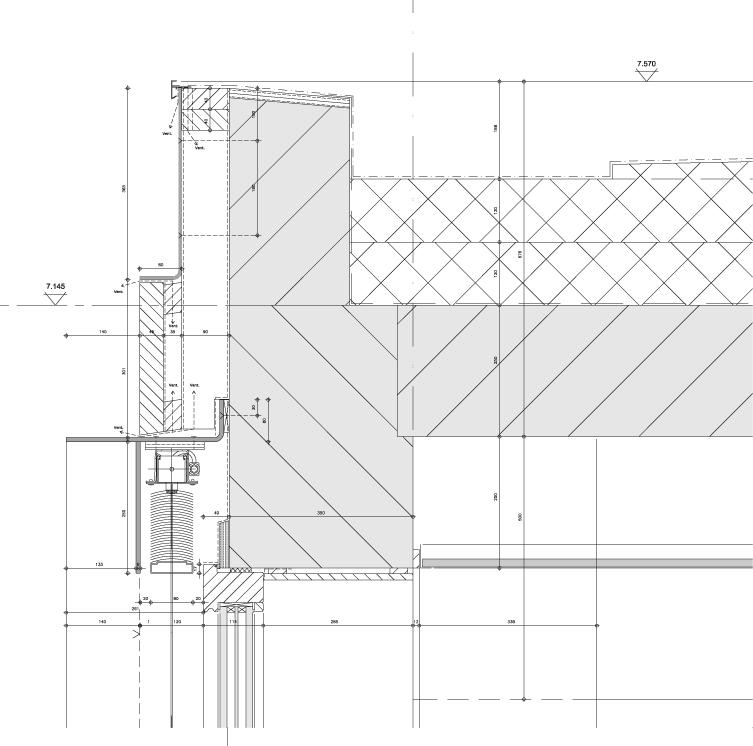
Solaio 1° P
2 triplo vetro
3 controparete per passaggio tubi e canali di installazioni
4 pannello in legno di chiusura laterale
5 zoccolo in legno 12x55 mm
6 finitura del pavimento
7 pannello in gessofibra sottopavimento
9 serramento in legno
10 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x47x8 mm)
11 membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore
13 elementi verticali in legno aperti della facciata (ca 60x35 mm)
14 listelli orizzontali di legno (60x35 mm)
15 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x80x8 mm)
16 protezione solare: veneziane orizzontali regolabili
17 trave in legno massiccio
18 elemento d’acciaio rivestito, a protezione delle veneziane


I pannelli utilizzati per le pareti esterne sono resistenti agli eventi atmosferici grazie a un rivestimento in legno Accoya, mentre le pareti e le colonne all’interno dell’edificio sono protette dalle radiazioni UV con olio di lino. Le zone umide dell’edificio, come cucina e servizi igienici, sono rivestite con piastrelle.
La parete tipo esterna, dello spessore di 35 cm, presenta già da sola un elevato valore di isolamento termico tanto che non si è reso necessario un ulteriore isolamento, presente solo sulla copertura.
Gli elementi prefabbricati sono stati assemblati sul sito, con tutti i vantaggi che questa metodologia costruttiva comporta: effetti positivi sui costi, sulla qualità e sulla flessibilità futura degli ambienti.
All’intradosso di gran parte dei solai è stato posato un
controsoffitto, al di sotto del quale sono stati integrati l’illuminazione, le tubature della ventilazione e altre cablature impiantistiche, nascondendole dunque alla vista. Il controsoffitto offre anche un buon assorbimento acustico.
Per garantire la flessibilità degli spazi, la struttura in legno contiene il minor numero possibile di componenti. Le colonne impiantistiche sono incluse in apposite contropareti aderenti alle pareti esterne mentre i due vani impiantistici principali si trovano nella zona centrale dell’edificio. I condotti dei cavi sono collocati, oltre che nei controsoffitti sospesi, anche nei pavimenti in legno. Tutti gli elementi non strutturali, come le pareti interne e le facciate, sono state assemblate separatamente dagli elementi di legno portanti.
1 striscia in neoprene
2 telaio della finestra: lamiera d’acciaio rivestita (300x47x8 mm)
3 serramento in legno
4 triplo vetro
6 nastro adesivo sigillante
7 pannello in legno di chiusura laterale
sezione orizzontale della parete
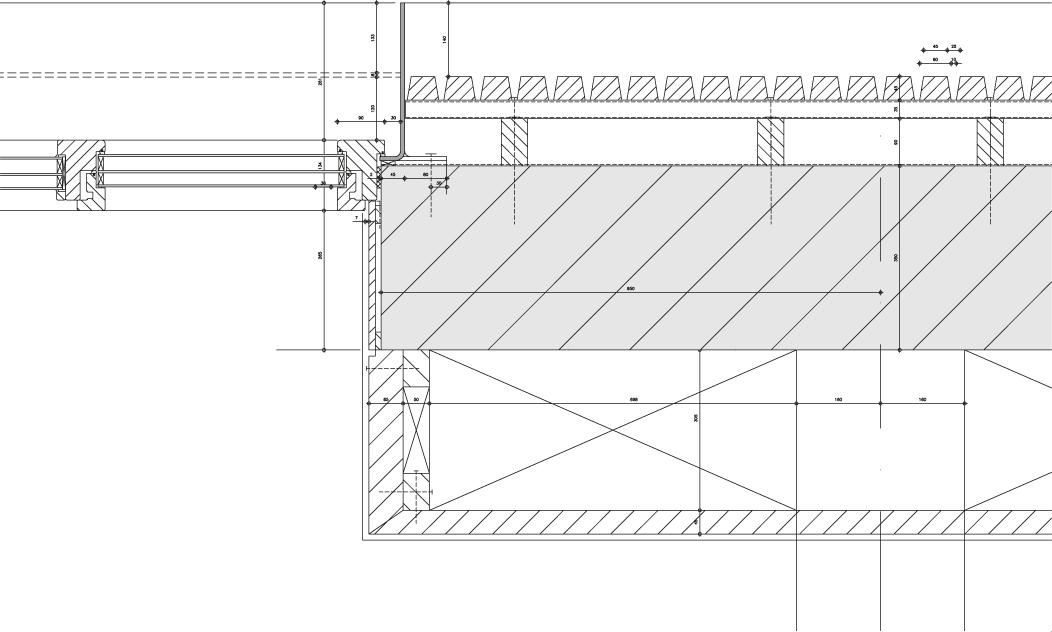
Parete esterna, dall’esterno:
Nella pagina a sinistra, un dettaglio della zona più interna degli uffici Il legno è rimasto sempre a vista ed è stato trattato con il solo olio di lino
Per assicurare un ambiente di lavoro piacevole, il nuovo edificio offre sufficiente luce naturale, viste piacevoli e comfort acustico
Inoltre, il fatto che le tavole che compongono pareti e solai siano collegate tra di loro con chiodi in legno di faggio, senza impiego di colla o metallo, evita ai dipendenti di essere esposti a emissioni chimiche nocive provenienti da componenti adesivi volatili
- elementi verticali in legno aperti della facciata (ca 60x35 mm)
- membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore
- listelli orizzontali di legno (60x35 mm)
- membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore
- montanti in legno (90x50 mm)
- membrana impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore
- parete in legno massiccio (350 mm)
- controparete per passaggio di tubi e canali per installazioni
- pannelli in legno a chiusura della controparete
- struttura portante/pannello in legno a vista

In questa immagine sono ben evidenti le pareti portanti esterne da 35 cm
Gli obiettivi di sostenibilità che si era prefissata la committenza per il nuovo edificio erano molto alti e includevano elevati valori di isolamento termico, una costruzione a tenuta d’aria e un design privo di ponti termici a fronte però della presenza di grandi aperture che consentissero alla luce diurna di raggiungere anche gli ambienti più interni dell’edificio A questo scopo, 3 lucernari sul tetto offrono illuminazione naturale al centro dell’edificio, riducendo al minimo la necessità di luce artificiale benché questa sia totalmente a LED e controllata da sensori di presenza e diurni
Poiché i sistemi di riscaldamento e di ventilazione
sono guidati dalla domanda, non viene sprecata energia che viene comunque generata in loco sfruttando l’energia solare senza alcun ricorso a fonti combustibili fossili
I materiali utilizzati nella costruzione, da quelli strutturali a quelli di finitura, si basano, ove possibile, sul principio “Cradle to Cradle”; essi sono dunque costituiti da materie prime non dannose per l’ambiente e
sono riciclabili alla fine della loro vita
Il sistema di costruzione in legno massiccio è stato decisivo in termini di prestazioni di sostenibilità dell’intero edificio Gli alberi utilizzati per realizzare pareti e solai sono stati raccolti in modo sostenibile, certificati PEFC, e hanno assorbito la CO2 attraverso la fotosintesi fino a quando non sono stati convertiti nei pannelli di legno con una conseguente, notevole impronta di CO2 negativa Nello specifico, i 1 200 m3 di legno utilizzato rappresentano un’impronta negativa di CO2 di 2400 tonnellate
Per limitare eventuali, potenziali danni agli ecosistemi durante la costruzione, è stato condotto un ‘sondaggio ecologico’ attorno alla sede dell’edificio con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività costruttive e ridurle ove necessario In base a tale sondaggio sono state adottate varie misure ecologiche che includono box per pipistrelli, box per i nidi degli uccelli, hotel per insetti (insect hotels), piscine naturali e flora vegetale autoctona integrata nel paesaggio

La “parete verde” al centro del nuovo edifici produce ossigeno, purificando gli interni, e funge da simbolo dell’ecologicità dell’intera costruzione

1. Costruzione passiva con un involucro in legno massiccio.
- pareti, solai e colonne in legno massiccio senza colla ma collegati con viti di legno
- 1 200 m3 di legno di abete rosso;
CO2 footprint: - 2.400 ton; certificato PEFC
- massa termica 120 Wh/Km2
- valore dell’isolamento della parete: Rc = 4,4 m2K/W (35 cm di spessore); Rc tetto = 10,8 m2K/W
2. Grandi aperture e lucernari
- ridotto consumo energetico per illuminazione
- riscaldamento passivo
- telai dei serramenti costruiti con legno sostenibile FSC di Accoya con triplo vetro Uw = 0,90 W/m2K
- brise-soleil automatici, regolati attraverso il sistema di aria condizionata
3 Materiali riciclabili:
- coperture vegetali, biodegradabili
- moquette, pavimenti in gomma, piastrelle, soffitti e vetro cradle-to-cradle riciclabili
4 Sistema di condizionamento dell’aria:
- totalmente controllato in base al carico di CO2, a seconda della domanda di riscaldamento e di raffrescamento per ogni stanza
- tecnologia BOT (Bauer Optimising Technology) crea un ambiente indoor senza fastidiose correnti e assicura un’efficienza energetica ottimale
- scambiatore di calore rotativo per recuperare calore e umidità
- 5,200 m2/h capacità di ventilazione
- rifornimento di aria fresca basata su 445 ppm di CO2 esterni e < 800 ppm negli uffici
- efficienza termica del 78%
5 Illuminazione:
- LED, tramite sensori di movimento e di luce diurna
6 Parete verde:
- converte la CO2 degli impiegati in ossigeno
7 Calore geotermico:
- 8 sonde geotermiche profonde 112 m forniscono riscaldamento e raffrescamento passivi
- pompe di calore da 17,3 + 9,6 kW forniscono riscaldamento e raffrescamento attivo
8 Collettori solari:
- 23 m2 per ACS e riscaldamento durante la primavera e l’autunno
9 Pannelli solari FV:
- posizionati sul tetto con orientamento est-ovest
- 334 pannelli x 327 Wp; 90 000 kWh all’anno
10 Giardino “ecologico”:
- stagno naturale per anfibi
- box per pipistrelli, hotel per insetti e box per nidi di uccelli in un ambiente naturale
ACQUA:
- 10 000 l di acqua piovana sono raccolti per gli sciacquoni dei wc e per la parete verde
- gabinetti senz’acqua
- misurazioni dell’acqua con rilevazione delle perdite e valvole di zona regolate dalla presenza


Per stimolare l’interazione tra personale amministrativo e personale della produzione, la distinzione tra ufficio e officina viene ridotta al minimo nella progettazione dell’edificio
Tutto il personale e gli ospiti accedono all’edificio tramite il suo ingresso principale

La progettazione del nuovo edificio è stata sviluppata e seguita internamente senza un appaltatore principale La Geelen Counterflow ha selezionato e gestito un team di progettazione composto da diversi esperti nei settori dell’architettura, degli impianti tecnici e della gestione dei progetti Gli architetti dello studio Architecten en Bouwmeesters erano anche BREEAM Expert Nella fase concettuale, gli architetti hanno iniziato con un programma funzionale e spaziale in accordo con i requisiti richiesti dalla committenza, che ha indicato gli obiettivi e i punti di partenza In una seconda fase, questi requisiti preliminari sono stati convertiti in “requisiti dettagliati di prestazioni” che sono serviti come base per il successivo processo di progettazione, durante il quale è stato seguito un approccio basato sul concetto “Trias Energetica”, sostenuto dalla convinzione che, per ragioni ecologiche ed economiche, sia necessario ridurre al minimo l’utilizzo dell’energia e quindi venga si fornisca per prima cosa energia da fonti rinnovabili
L’attenzione particolare all’isolamento, alla massa termica, ai ponti termici, alla tenuta all’aria e alla luce naturale hanno, quindi, contribuito a ridurre ulteriormente l’uso dell’energia necessaria per il funzionamento dell’edificio
Il processo di progettazione è durato 3 anni e le attività di tutti i subappaltatori, ingaggiati in maniera diretta, sono state coordinate da un responsabile di costruzione, assunto specificamente per questo progetto. Ciò ha facilitato il miglioramento continuo durante tutto il processo per massimizzare l’utilizzo del know-how e dell’esperienza dei vari subfornitori. Questo tipo di approccio ha prodotto risultati migliori del previsto, come l’eccedenza del 50% di energia pulita, un punteggio di BREEAM del 99,94% e il completamento del progetto entro i limiti di tempo e di budget, con un costo finale pari a quello delle pratiche costruttive tradizionali.
Il principio del Cradle-to-Cradle – C2C
Spiegato e approfondito per la prima volta nel 2002 dall’architetto William McDonough e dal chimico Michael Braungart nel loro libro intitolato Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, il principio ‘dalla-culla-alla-culla’ rappresenta la visione di un ciclo continuo di utilizzo e riutilizzo di materiali senza produzione di rifiuti Tale principio è diventato ormai parte integrante di un’economia che voglia definirsi circolare ed è, in generale, un criterio per valutare l’impatto ambientale, ed eventualmente riprogettare, l’intero ciclo di vita di prodotti e sistemi. Si tratta di un modello che non è limitato all’ambito industriale e/o manifatturiero ma che può essere applicato a diversi aspetti della civiltà umana, dagli ambienti urbani agli edifici, dall’economia ai sistemi sociali McDonough e Braungart sono anche i fondatori di un istituto che certifica prodotti e sistemi in base al principio da loro delineato
I Paesi Bassi, in effetti, non sono avulsi da questo concetto poiché è stata proprio una cittadina olandese, Venlo, nella regione del Limburgo, per prima al mondo ad applicare i principi del Cradle-to-Cradle nella sua gestione




Villa, Monopoli (BA)
Costruire per l’uomo e per l’ambiente è l’obiettivo cardine che ha guidato i progettisti nella pianificazione di questa villa al fine di raggiungere elevati livelli di comfort abitativo e di risparmio energetico. La sinergia progettuale tra tutte le figure professionali ha portato alla realizzazione di un edificio altamente sostenibile in un contesto – quello mediterraneo – che richiede più energia per raffrescare che per riscaldare.
La necessità di accompagnare con un’azione concreta un più corretto ed equilibrato costruire sul territorio in funzione dell’uomo e dell’ambiente è stato lo spunto per realizzare una villa che garantisse un elevato comfort, senza tuttavia consumare grandi quantità di energia, e che si adattasse alle condizioni climatiche tipiche dell’area mediterranea, rispondendo al contempo agli standard di Casa Passiva e ai requisiti del Protocollo Itaca della Regione Puglia L’edificio scaturisce da una vecchia volumetria fatiscente interamente demolita, ricostruita e delocalizzata su un lotto semiperiferico dalla forma regolare già lottizzato, caratteristica quest’ultima che ha consentito di evitare impatti ambientali dovuti alla realizzazione di nuovi allacciamenti Il volume, il cui rapporto S/ V è abbastanza favorevole (0,84) è stato allineato secondo l’asse nord-sud con le aperture che si aprono in prevalenza a est, sud e ovest al fine di usufruire al meglio della disponibilità della luce naturale, poiché essa influisce notevolmente sul comportamento termico dell’edificio e rappresenta una delle componenti fondamentali per determinare la sensazione di benessere fisico generale Il fabbricato è com-
posto da un piano fuori terra e uno interrato con ampie zone esterne attrezzate con spazio vasca idromassaggio e piscina, oltre alla presenza del giardino, di un frutteto e agrumeto e degli alberi ornamentali opportunamente collocati per schermare o lasciar passare gli apporti solari rispettivamente in estate o in inverno, visti i criteri di efficienza energetica e sostenibilità su cui si basa la progettazione
Dopo aver effettuato dunque un’analisi dettagliata della natura del luogo e del contesto urbano in cui è stato inserito l’edificio e considerando i dati climatici locali, si sono definite tutte quelle tecniche e tecnologie che hanno consentito di ottenere un corpo di fabbrica a basso consumo energetico certificato Tale obiettivo è stato reso possibile essenzialmente in virtù dell’utilizzo di attenti accorgimenti progettuali come la coibentazione senza ponti termici, la verifica della perfetta tenuta all’aria, l’isolamento acustico, oltre all’impiego di materiali innovativi ecosostenibili, a una impiantistica adeguata e all’utilizzo di infissi altamente termoisolanti Un design lineare ed essenziale della forma architettonica ha collaborato al raggiungimento di un buon risultato finale sia estetico che funzionale

A ovest la villa presenta un porticato caratterizzato ai lati da due frangisole fissi a lamelle

Progetto e DD LL
arch Francesco Longano con geom Antonella De Marco, Monopoli (BA))
Strutture
ing Michele Solfrizzi, Mola di Bari (BA)
Progetto energetico e sostenibilità ambientale arch tti Salvatore Paterno e Antonio Stragapede, Gravina di Puglia (BA)
Progetto impianti
ing Giuseppe Bitetti, Bari
Appaltatore
Impresa Edile ELLEDILIZIA srl, Monopoli (BA); RUBNER Haus spa, Chienes (BZ)
Superficie fondiaria
2 500 m2
Superficie utile
270 m2
Superficie verde
1 500 m2
Certificazioni
Certificazione APE; ClimAbita; Protocollo ITACA Puglia

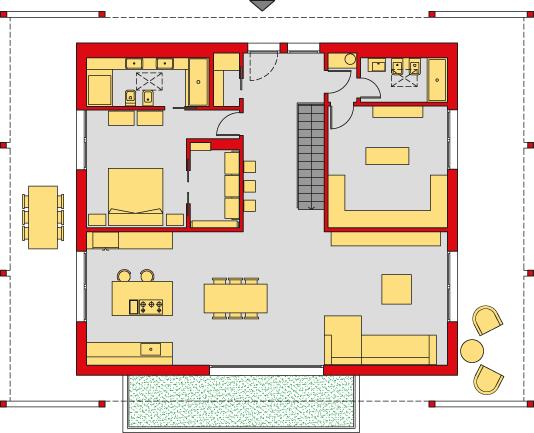


A partire da analisi e valutazioni delle prestazioni energetiche e ambientali sulla base dei dati climatici locali, come ad esempio le temperature esterne durante le varie stagioni e l’irraggiamento solare incidente sull’edificio, è stato possibile ridurre la richiesta energetica e le potenze termiche necessarie per la gestione del fabbricato sia in inverno che in estate, contribuendo concretamente anche al contenimento e alla riduzione delle immissioni in atmosfera di gas clima alteranti. Inoltre, tutte le componenti edilizie sono state valutate secondo i valori imposti dalla normativa e sulla base dei parametri di benessere termoacustico e igrometrico dettati dalla fisica edile. L’edificio, per la parte fuori terra, presenta una struttura portante in pannelli massicci di legno, scelta questa non nuova per i progettisti i quali quasi dieci anni fa, sempre a Monopoli, progettarono e costruirono delle case a schiera con il legno, testandone dunque l’utilizzo in clima mediterraneo. L’innovativa struttura, utilizzata sia per la realizzazione dei solai che delle pareti, i cui spessori ridotti hanno portato a un forte beneficio in termini di superficie netta fruibile, si contraddistingue per il legno proveniente da foreste certificate PEFC, sigillo di qualità che garantisce il rispetto di una serie di criteri ecologici in silvicoltura, per le connessioni a incastro (a coda di rondine e a
pettine) e per la mancanza di giunzioni metalliche o di colle Grazie all’elevata ingegnerizzazione del processo produttivo, i montaggi sono stati rapidi e di grande precisione, diminuendo i tempi di costruzione Pertanto la villa con le sue pareti e la copertura in legno, oltre a essere altamente performante dal punto di vista prestazionale, riduce quotidianamente in modo drastico l’isola di calore
Da sottolineare infine alcune ulteriori caratteristiche dell’intera struttura in legno massello, ov vero la capacità igroscopica di regolazione dell’umidità dell’aria in ambiente, il naturale impedimento dell’accumulo di cariche elettromagnetiche e l’adeguata protezione contro gli effetti dell’elettrosmog ad alta frequenza proveniente dall’esterno.
Vediamo ora in dettaglio alcune caratteristiche salienti dell’involucro.
La stratificazione delle pareti perimetrali, isolate con fibra di legno, ha permesso di raggiungere una trasmittanza termica U di 0,16 W/m2K, mentre la copertura presenta una trasmittanza U pari a 0,13 W/m2K. Le chiusure opache sono state iperisolate e a tenuta d’aria; per assicurare infatti un buon isolamento termico, ai materiali isolanti è stato necessario creare una pelle impermeabile all’aria dall’interno e impermeabile al vento dall’esterno. Allo stesso modo i
L’immagine mette in evidenza la copertura che accoglie l’impianto fotovoltaico, mentre sulle tettoie degli elementi schermanti a est e ovest saranno collocati i collettori solari termici

giunti di tenuta tra i telai delle finestre e la struttura garantiscono la continuità all’involucro poiché anche solo una piccola perdita nello strato di tenuta all’aria e al vento può generare notevoli conseguenze in qualsiasi sistema costruttivo
Gli infissi sono a elevata resistenza termica e acustica e sono dotati di schermature ombreggianti esterne mobili a comando elettrico che consentono di regolare l’ingresso della radiazione solare diretta a seconda della stagione e delle ore diurne. Le aperture
esterne, in gran parte di grandi dimensioni, sono state realizzate con telaio in legno massiccio dello spessore di 92 mm e con conducibilità termica di 0,11 W/mK, sono munite di vetro isolante a tre lastre (spessore 52 mm) il cui coefficiente di trasmittanza termica Ug è pari a 0,5 W/m2K; nel complesso gli infissi ottengono una trasmittanza termica Uw di 0,82 W/m2K Per verificare la perfetta esecuzione da parte dell’impresa esecutrice e degli operatori è stata eseguita la verifica di tenuta all’aria mediante blower-door-test.
sezione nord-sud (verso ovest)
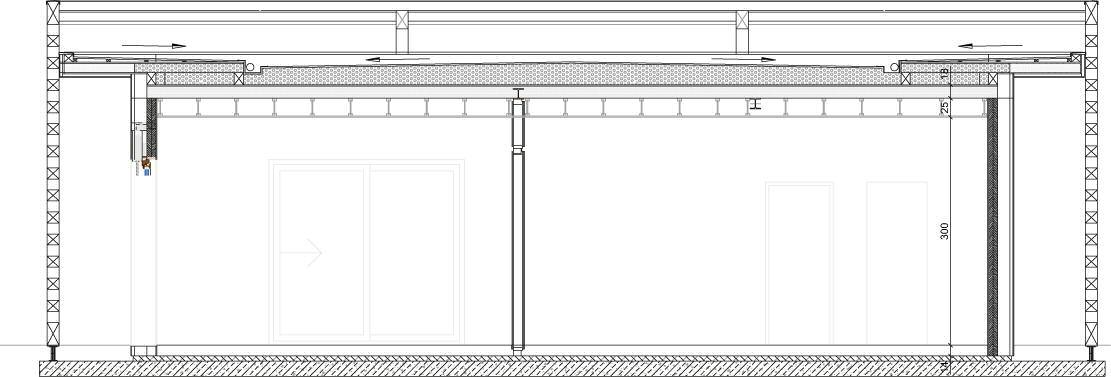
Consumo energetico annuo per riscaldamento
(Standard Case Passive)
4,10 kWh/m2 anno
Consumo energetico annuo per raffrescamento
9,00 kWh/m2 anno
Fabbisogno per ACS
2,10 kWh/m2 anno
CO2 evitata
1,57 kg CO2/m2 anno
Trasmittanza media pareti esterne
U = 0,15 W/m2K
Trasmittanza media solaio contro terra
U = 0,25 W/m2K
Trasmittanza media copertura
U = 0,13 W/m2K
Trasmittanza media serramenti
Uw = 0,90 W/m2K
A destra, la posa dell’isolamento in XPS sul solaio contro terra

Solaio contro terra, dall’estradosso:
- pavimentazione
- massetto (8 cm)
- barriera al vapore
- isolamento in XPS (10 cm)
- manto impermeabile
- massetto strutturale (5 cm)
- igloo ventilato (16 cm)
1 membrana bullettonata
2 ventilazione
3 impermeabilizzazione
4 isolamento in XPS (6 cm)
5 massetto
6 pavimentazione
7 vetro cellulare
8 soglia
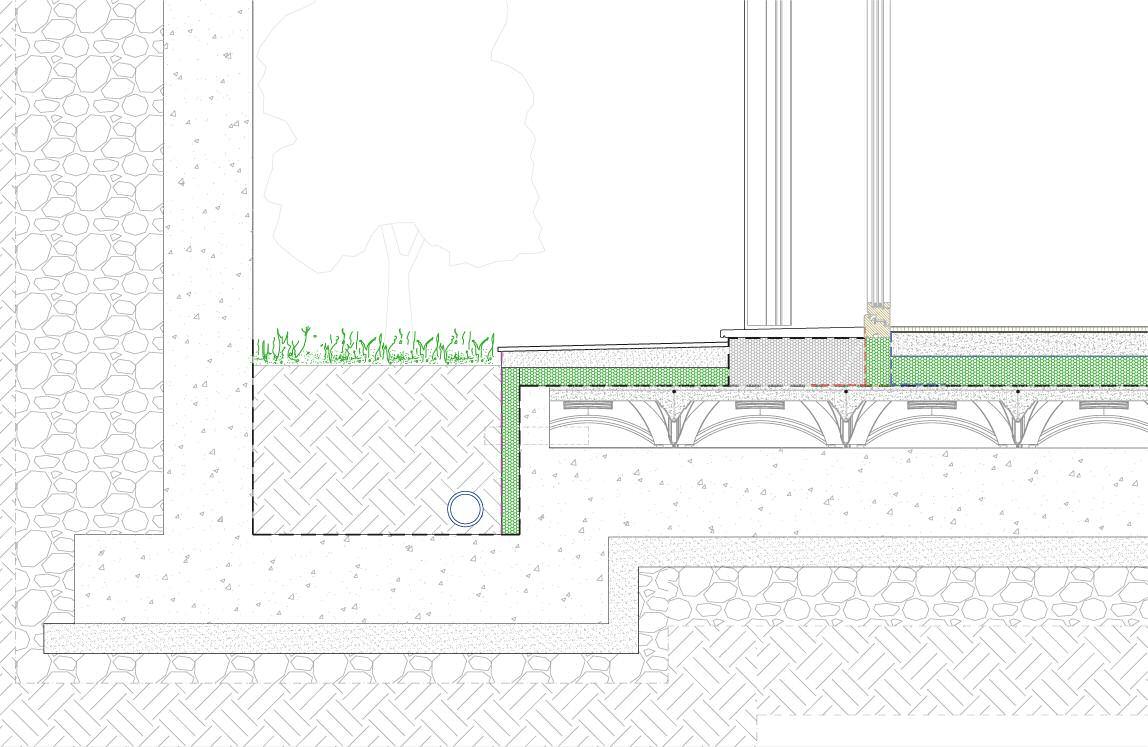
solaio contro terra
Copertura a verde, dall’estradosso:
- terra vegetale
- strato filtrante: geotessile (100/150 g/m2)
- strato drenante: ghiaietto
- membrana impermeabile + strato di desolarizzazione (sabbia)
- OSB + ventilazione (6 cm)
- telo traspirante
- isolamento in fibra di legno (220 kg/m3; 10 cm)
- isolamento in fibra di legno (160 kg/m3; 10 cm)
- telo freno vapore
- elemento portante in X-lam (16 cm)
1 pannello in cartongesso
2 radiante a soffitto
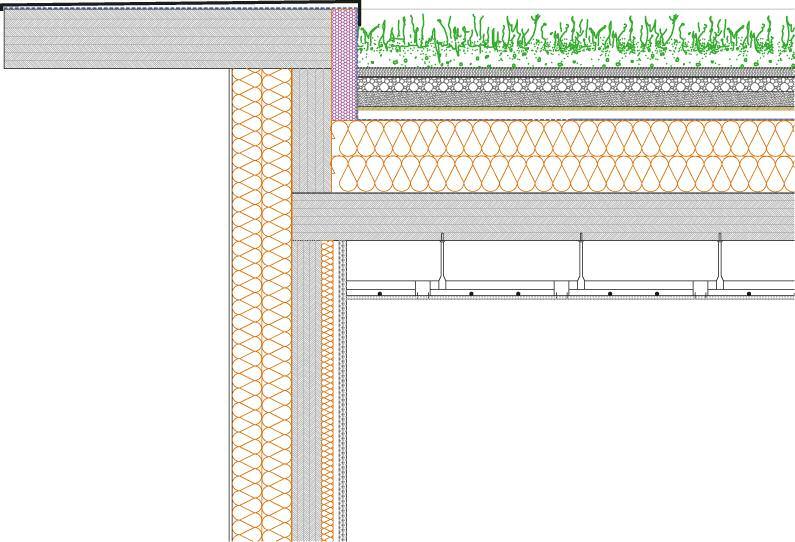
Parete esterna, dall’esterno:
- rasante
- isolamento in fibra di legno (220 kg/m3; 10 cm)
- isolamento in fibra di legno (160 kg/m3; 10 cm)
- elemento portante in X-lam (10 cm)
- materassino in fibra naturale (4 cm)
- pannello in fibrogesso (1,25 cm)
- pannello in cartongesso (1,25 cm)
Sotto, dall’alto, un momento della posa di una delle pareti prefabbricate in legno già dotate di isolamento e pannelli di finitura in cartongesso; sotto, una parte di parete strutturata a telaio ospita, oltre all’isolamento, i passaggi impiantistici


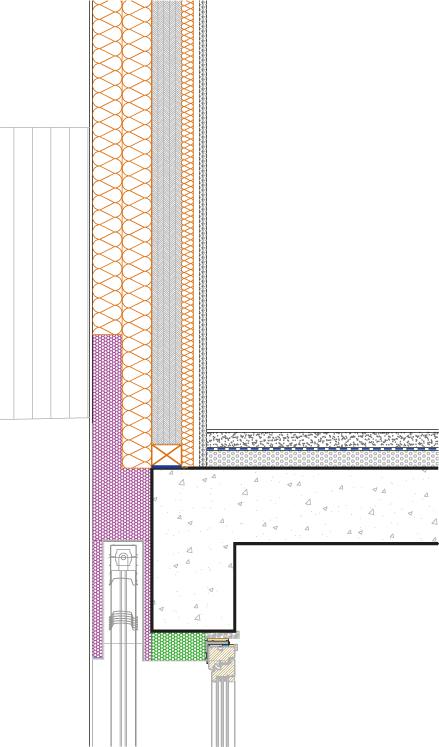
Solaio interpiano, dall’estradosso:
- ecomalta
- massetto
- tappetino acustico
- argilla espansa (6 cm)
- solaio in latero-cemento
- intonaco
La strategia impiantistica si è basata su tecnologie correntemente disponibili sul mercato Per la climatizzazione è stata installata una pompa di calore che garantisce anche la produzione di acqua calda sanitaria La distribuzione del calore e il raffrescamento avvengono mediante un impianto a irraggiamento a soffitto con ventilazione meccanica controllata e deumidificazione automatica, la quale assicura un’alta qualità dell’aria indoor
Le colonne di distribuzione verticali e orizzontali sono ubicate su pareti e soffitti isolati lungo tutto il loro percorso
L’impianto di erogazione e distribuzione dell’energia elettrica è allacciato alla rete elettrica pubblica; l’edificio è inoltre dotato di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile e di un sofisticato impianto di domotica che consente il controllo totale degli impianti anche a distanza tramite collegamenti internet Tutta l’illuminazione, interna ed esterna, utilizza sistemi a led a basso consumo energetico e per la maggior parte dimmerabili per la configurazione di scenari d’uso comandati dallo stesso impianto domotico.
Un altro accorgimento per il risparmio delle risorse è stato l’adozione del recupero delle acque meteoriche, le quali sono convogliate in una grande cisterna e sono utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi e per gli sciacquoni dei bagni; dove non è stato
possibile il recupero in cisterna delle acque, sono stati messi in opera pavimenti esterni altamente drenanti
Per ridurre ulteriormente il consumo di acqua potabile, all’interno dell’abitazione sono stati adoperati sistemi per ridurre il flusso di acqua mediante
l’installazione di riduttori di flusso alle rubinetterie e doppi sciacquoni nei wc

Nell’immagine qui sopra, il controsoffitto con i pannelli radianti già finito con il cartongesso (in rosa) Alla parete sono appoggiati i singoli elementi radianti, ancora da posare
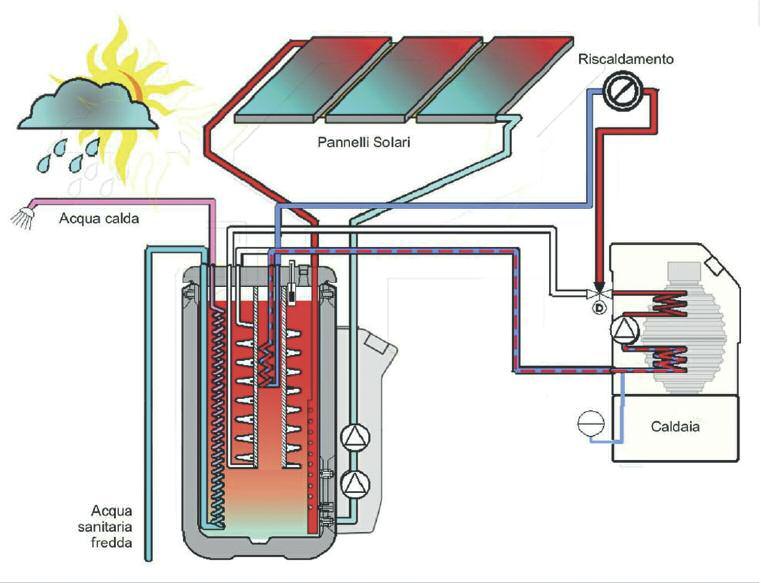
Schema di funzionamento del solare termico che copre quasi totalmente il fabbisogno di ACS

La zona giorno – cucina, pranzo e salotto –è un lungo e luminoso open space che si apre con ampie finestre a tutta altezza verso est, sud e ovest
L’unità abitativa
all’interrato si caratterizza per il grande uso del vetro che consente alla luce naturale di penetrare anche nelle zone più nascoste


In combinazione con tecnologie attive di climatizzazione e di illuminazione, la progettazione ha previsto l’adozione di strategie passive per l’illuminazione e per il raffrescamento naturale in estate della villa, requisiti previsti dal Protocollo Itaca della Regione Puglia”, il cui raggiungimento ha vista applicata una premialità in maggiore superficie costruita Nello specifico, in relazione al raffrescamento naturale, dopo aver collocato geograficamente l’edificio nel sito di progetto, tramite l’analisi della direzione prevalente del vento durante la stagione estiva e la definizione della posizione delle aperture rispetto al lato opposto del vento, si è verificato che era possibile effettuare una ventilazione a lato singolo nelle camere da letto che presentano una sola apertura e che era favorita una ventilazione trasversale nell’ambiente unico soggiorno-pranzo-cucina che dispone di tre aperture su lati opposti

Anche all’interrato la zona living è completamente aperta e prende luce dall’ampia vetrata affacciata sulla piscina e dalla bocca di lupo che ospita un piccolo giardino interno
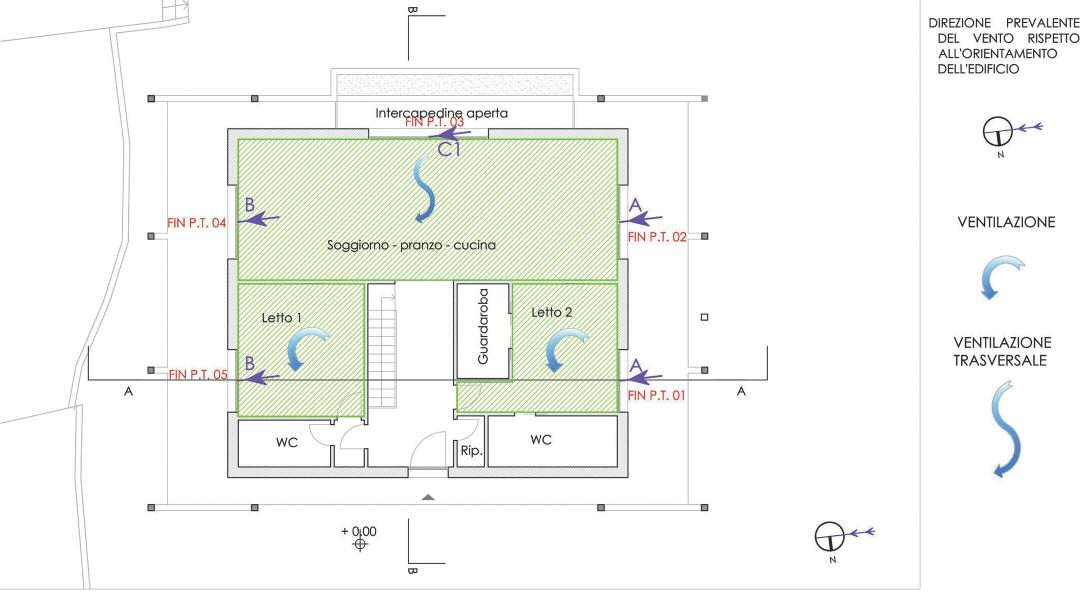

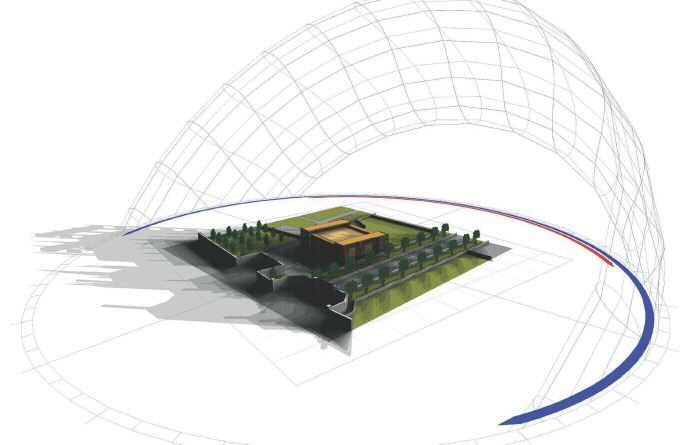
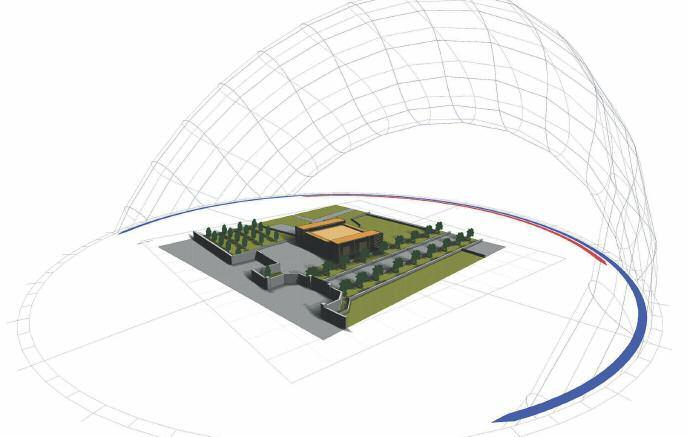


Il padiglione di un tempio buddista nel cuore della capitale giapponese, costruito con l’intenzione di durare nel tempo, per le generazioni future, in un’area che è stata al centro del Grande Terremoto del Giappone Orientale del 2011. Ma, oltre che a resistere alle forti sollecitazioni sismiche, il padiglione riduce anche al limite il consumo energetico necessario per funzionare. Nonostante l’edificio non sia riuscito a raggiungere lo standard Passivhaus, ha tuttavia ricevuto la targhetta di Low Energy Building dall’istituto tedesco di Darmstadt, grazie all’ottimizzazione delle prestazioni isolanti dell’involucro e a un sistema impiantistico che sfrutta la geotermia.
Il Giappone, famoso per i suoi templi buddisti, è oggetto di questo approfondimento progettuale poiché il padiglione Bunyukaku del Tempio di Tochoji a Shinjuku-ku, Tokyo, è il primo edificio religioso buddista al mondo che ha voluto, fin dalla sua progettazione, soddisfare esplicitamente lo standard Passivhaus, pur non riuscendoci fino in fondo
L’intero complesso templare di Tochoji risale all’inizio del XVII secolo, nonostante il sito presenti molti edifici del XX secolo, dei quali la facciata del padiglione Bunyukaku costituisce l’ultima aggiunta contemporanea
L’edificio di 5 piani è stato realizzato con un telaio in acciaio e dotato di quattro sistemi di isolamento sismico – essenziali in un’area soggetta a forti terremoti come quella di Tokyo
La sua progettazione ha seguito lo standard Passivhaus ma, pur non riuscendo a raggiungere i canonici 15 kWh/m2 anno per il fabbisogno energetico, ha soddisfatto il nuovo e meno oneroso standard di “Low Energy Building” dell’istituto tedesco, introdotto proprio per quei progetti che, per svariati motivi, non riescono ad adempiere a tutti i requisiti dell’Istituto
Come è stato possibile che dei monaci buddisti si siano così interessati alle questioni energetiche da commissionare un edificio (quasi) passivo?
Stando a quanto hanno raccontato i progettisti, il capo monaco del tempio chiese al suo architetto di visitare l’ufficio dei Key Architects – esperti certificatori Passivhaus in Giappone – poco dopo il Grande Terremoto del Giappone Orientale del 2011, quello che causò, tra l’altro, il disastro di Fukushima. Secondo i monaci di Tochoji, infatti, il risparmio energetico è una delle chiavi per la pace nel mondo (!); essi hanno dunque spinto, architettonicamente, su questo punto per av vicinarsi di un pezzetto all’ambizioso traguardo.
Poiché l’architettura dei templi ha sempre rappresentato il futuro della gente, in base a quanto espresso dai monaci, la nuova sala delle cerimonie nel padiglione “Bunyukaku” del Tempio di Tochoji avrebbe dovuto mostrare la consapevolezza dell’efficienza energetica.

Progetto architettonico
manifield, Yokohama (J) + Tochoji
Strutture
Arup Japan, Tokyo (J)
Consulenti energetici
arch Miwa Mori - KEY ARCHITECTS, Tokyo (J)
Appaltatore
Matsui Construction, Tokyo (J)
Lavori
2014-2015
Superficie utile
337 m2
Certificazione
Passivhaus Institut Darmstadt (Low Energy Building)


L’intero complesso del tempio di Tochoji risale originariamente all'inizio del XVII secolo, ma sul sito insistono molti edifici del XX secolo, al quale si è aggiunto ora il padiglione certificato dal Passivhaus
A sinistra, la sala delle cerimonie al 4° piano, con la statua del Buddha I materiali utilizzati per le finiture si rifanno alla tradizione giapponese, come il legno duro di quercia giapponese P h o t
Per capire le funzioni dei vari spazi è necessaria una breve premessa sulla liturgia buddista in relazione ai funerali e alle messe in memoriam, che si svolgono nel padiglione Bunyukaku del tempio di Tochoji
Nella tradizione giapponese (buddista) vengono celebrati rituali in ricordo del defunto dopo periodi di tempo stabiliti (7 giorni, 49 giorni, 1 anno, 3 anni ecc ) all’interno del tempio con cui la famiglia del defunto ha un lungo rapporto e nel quale si trova la tomba di famiglia Spesso tale rapporto è consolidato anche dalle donazioni che la famiglia fa nel corso degli anni, assumendo quindi il ruolo di “sponsor”
Pertanto, il piano terra ospita una reception; il 1° piano una sala d’aspetto e una sala da pranzo per la famiglia prima e dopo la cerimonia, i servizi igienici e una mini-cucina; al 2° e al 3° piano, chiamati Ihaido Hall, si trovano le tavolette mortuarie dei vari ‘sponsor’ del tempio; infine, al 4° piano, una sala delle cerimonie con la statua del Buddha Sulla scelta finale dell’acciaio come materiale da costruzione ci fu una lunga discussione con il cliente, cioè i monaci del tempio stesso Questi, infatti, si chiedevano quanto il legno, con il quale tuttavia sono realizzati molti templi secolari giapponesi, fosse veramente sostenibile poiché la maggior parte del legno con cui in Giappone si costruiscono gli edifici non viene trattato correttamente e, dopo aver tagliato gli alberi, spesso non si effettua un rimboschimento efficace ed efficiente, sostanzialmente per motivi economici. I monaci sono dell’opinione che la quantità delle foreste nipponiche stia diminuendo, mentre, dall’altra parte, la quantità totale di acciaio, come materiale da costruzione, è sempre la stessa sul pianeta. Ecco perché i progettisti non sono stati in grado di convincere i monaci a realizzare il padiglione in legno. È stato comunque possibile utilizzare materiali locali e tradizionali per alcune finiture interne ed esterne, come per esempio legno
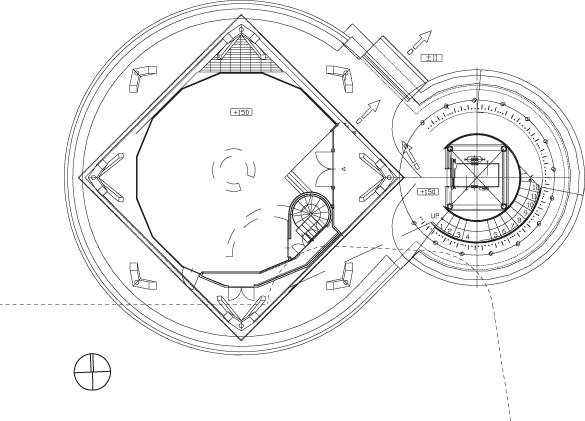
piano terra
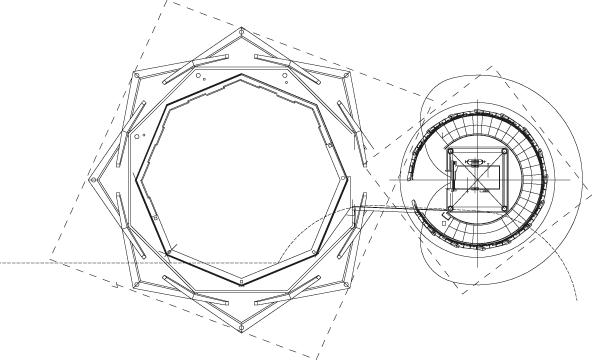
piano quarto
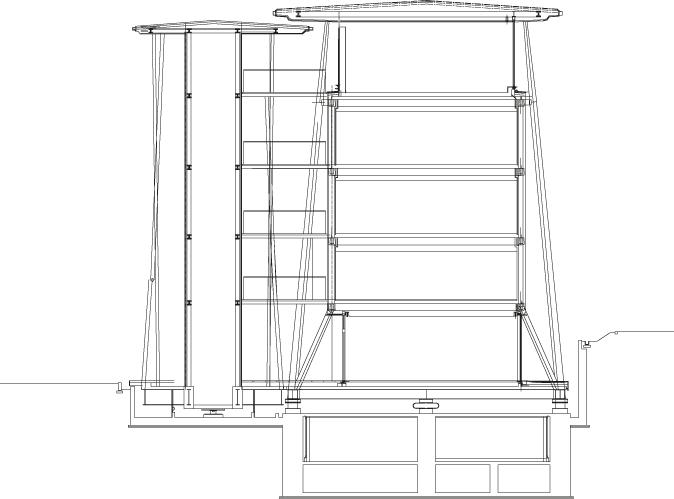
sezione longitudinale
duro locale per la finitura del pavimento, stucco tradizionale giapponese per la finitura di alcune pareti, bambù per il soffitto ecc.
Fabbisogno energetico per riscaldamento
22 kWh/m2a
Fabbisogno energetico per raffrescamento
21 kWh/m2a
Fabbisogno energetico per ACS
3,5 kWh/m2a
Tenuta all’aria
n50 = 0,38 h-1

Energia primaria da fonti non rinnovabili (PE)
132 kWh/m2a
Energia primaria da fonti rinnovabili (PER)
69 kWh/m2a
Emissioni di CO2
9,099 kg/anno
U = 0,15 W/m2K
Trasmittanza media copertura
U = 0,14 W/m2K
Trasmittanza media serramenti
Uw = 1,79 W/m2K


Due immagini di cantiere in cui è messa in evidenza la particolare struttura portante in acciaio: a sinistra, la struttura radiale dei solai; in questa foto, un dettaglio dell’incrocio dei pilastri all’ultimo piano

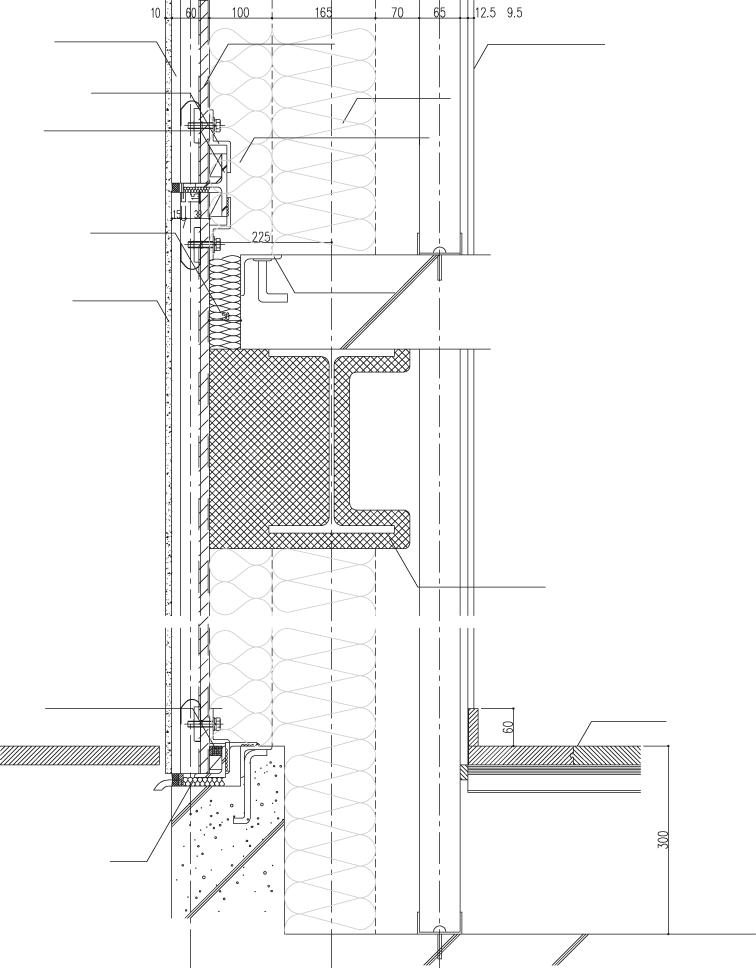
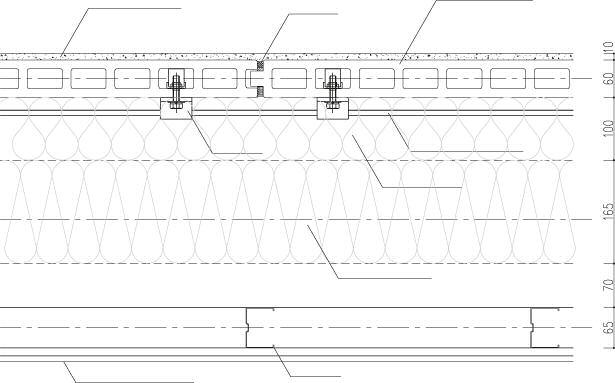
Dettaglio dell’attacco a terra:
2 guarnizione verticale
3 cartongesso
4 isolamento in lana di vetro (resistenza 35K)
5 isolamento in lana di vetro (resistenza 32K)
6 clip a forma di Z
7 angolare in acciaio (a forma di T)
8 elemento tagliafuoco
9 finitura a stucco
10 protezione antincendio
11 trave in acciaio
12 guarnizione orizzontale in gomma
13 isolamento in lana di roccia
14 pavimento in legno massiccio (quercia giapponese)
Accanto ai più noti standard Passivhaus (Classic, Plus, Premium) e EnerPHit (Classic, Plus, Premium), l’istituto di Darmstadt offre un terzo tipo di certificazione per gli edifici a basso consumo di energia, Low Energy Building –Energiespar Haus Il PHI Low Energy Building Standard è pensato per tutti quegli edifici che non soddisfano pienamente i criteri della Passivhaus per vari motivi Tra i criteri richiesti, un consumo annuo di energia per il riscaldamento ≤ ai 30 kWh/m2; un consumo annuo di energia per il raffrescamento ≤ al massimo dei due criteri alternativi di Passivhaus ed EnerPHit per la domanda di raffreddamento; 30 kWh/m2 una tenuta all’aria n50 ≤ a 1 h-1 e una domanda di energia primaria annuale da fonti rinnovabili ≤ 75 kWh/m2
Parete tipo:
1 finitura a stucco
2 sigillatura
3 pannello di cemento espanso
4 clip a forma di Z
5 supporto metallico
6 isolamento in lana di vetro 32K
7 isolamento in lana di vetro 35K
8 cartongesso
9 LGS (Light Gauge Steel) - elemento in acciaio leggero

Pur seguendo le indicazioni progettuali del Passivhaus Institut, il padiglione del tempio Tochoji non è riuscito a ottenere la certificazione dall’istituto tedesco poiché, nonostante un’ottima tenuta all’aria testata di 0,38 h-1, il consumo annuo di energia per il riscaldamento è risultato essere di 22 kWh/m2 Tra le cause che hanno portato alla mancata certificazione Passivhaus, oltre alla presenza di numerosi ponti termici non risolvibili, data l’architettura del manufatto, ce ne sono state alcune, per così dire, contingenti, che hanno impedito il rispetto dei criteri del PHI Una di questi ha riguardato i serramenti. Il produttore giapponese delle finestre, l’unico che, al momento del progetto, realizzava serramenti certificati Passivhaus e che avrebbe dovuto consegnare la facciata continua

composita in legno-alluminio, è andato in bancarotta proprio durante la fase di costruzione A quel punto, i progettisti hanno dovuto trovare in un periodo molto breve un altro produttore che fosse in grado di realizzare un prodotto alternativo con le stesse prestazioni termiche; cosa che, alla fine, non è stata possibile Il nuovo produttore infatti non è stato in grado di mantenere il valore U originale del telaio della finestra, dei vetri e, quindi, del guadagno solare dalla vetratura Inoltre, nel frattempo, un nuovo edificio pluripiano per appartamenti, proprio sul lato sud del sito del tempio di Tochoji, aveva ottenuto il permesso di costruzione; un edificio alto 14 piani che aveva “rubato” il guadagno solare calcolato – e auspicato – dagli architetti.
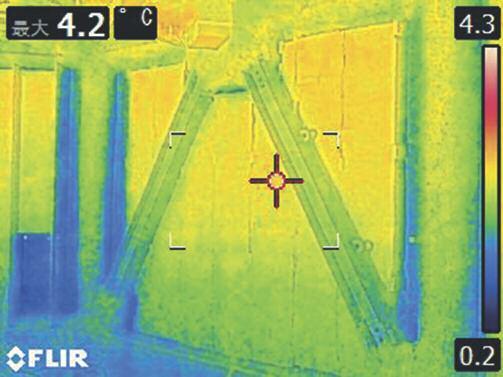
Il comfort indoor del padiglione Bunyukaku è garantito da un sistema di VMC con due unità di ventilazione, dotate di estrazione dell’aria dalle zone delle toilette e recupero di calore L’ACS è fornita da un semplice boiler elettrico mentre la peculiarità impiantistica dell’edificio è rappresentata da una pompa di calore geotermica terra-acqua (glicole etilenico) che garantisce riscaldamento e raffrescamento, distribuendoli attraverso ventilconvettori presenti in ogni ambiente, ed è collegata a 6 sonde verticali da 130 m collocate circolarmente attorno al perimetro della parte più grande del padiglione Una soluzione tecnologica entusiasticamente accolta dalla committenza buddista

Caratteristiche delle sonde geotermiche: tipo sonda: a doppia U; profondità: 130 m; materiale di cui è fatta la sonda: PE100; materiale di riempimento: sabbia silicea; fluido vettore: acqua con aggiunta di glicole etilenico 25%
1 sonda a U
2 riempimento con malta liquida
3 riempimento con sabbia
4 peso
Tutti i servizi meccanici necessari come la ventilazione e il riscaldamento/raffreddamento degli ambienti per la sala delle cerimonie (all’ultimo piano) sono installati nel soffitto del 4° piano come elementi visibili
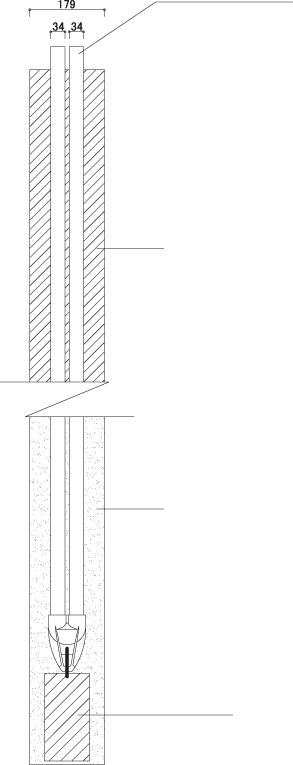
Qui sotto, la pianta del piano terra con la collocazione indicativa delle sei sonde geotermiche in relazione alla pianta del padiglione 1
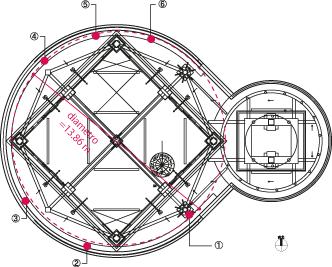

Una composizione volumetrica che si adatta all’ambiente costruito ricercando guadagni solari gratuiti e illuminazione naturale è il più recente progetto di Wain Morehead Architects, studio irlandese che in questo edificio passivo ha sfruttato a proprio vantaggio le caratteristiche sfavorevoli del lotto su cui sorge la casa, creando un modello di risparmio non solo di energia ma anche di consumo di suolo.

Un buon guadagno solare è uno dei punti cardine degli edifici a energia zero, soprattutto di quelli che devono essere riqualificati Tuttavia, quando il sito di progetto è lungo, stretto, orientato nordest-sudovest e presenta un accesso al sole insolitamente povero, è difficile raggiungere lo standard Passivhaus, ancor più se sono presenti ombreggiamenti variabili dovuti a tre abitazioni che sorgono su tre lati del lotto, a mura alte 2,4 m e a grandi e rigogliosi alberi posti a dimora a confine Infine, se l’edificio da recuperare mostra superfetazioni mal organizzate, così come spazi interni incongrui alle esigenze dei committenti, il processo progettuale si complica ulteriormente
A partire da tali premesse e al fine di valutare la convenienza economica della riqualificazione, i progettisti hanno effettuato sull’esistente studi solari approfonditi che, viste le condizioni sfavorevoli del-
l’area di progetto e gli eccessivi costi dell’intervento di recupero in standard passivo, hanno portato alla demolizione dell’abitazione per far posto a due nuovi corpi di fabbrica di due piani ciascuno, uno sul fronte principale e l’altro su quello retrostante, collegati tra di loro da un volume a un unico livello Il complesso, che si av volge attorno a una corte interna, sfrutta così appieno la disponibilità di luce diurna e di irraggiamento solare in tutti i momenti del giorno, impattando nel minor modo possibile sul vicinato Nello specifico, il fabbricato affacciato sul fronte strada ospita l’entrata, il bagno degli ospiti e il salotto al piano terra, uno studio, una piccola sala e un ripostiglio al primo piano; in quello retrostante trovano posto invece la zona notte e il vano tecnico L’edificio a un piano, pensato per unire i due volumi principali, non è solo uno spazio di circolazione ma diventa il

Grande cura è stata prestata anche alla progettazione del verde che, sul fronte principale, è pensato e messo a dimora per ombreggiare e per trarre vantaggio dall’irraggiamento solare
cuore della casa, alloggiando lungo un largo corridoio la cucina, la dispensa, la sala da pranzo e la veranda/giardino d’inverno
Grandi aperture vetrate si aprono verso l’esterno in tutta l’abitazione, permettendo allo sguardo di spaziare in ogni luogo dell’edificio – dalla zona notte al living – e sulla corte interna che diventa essa stessa un’ulteriore stanza da vivere L’illuminazione naturale nella cucina/pranzo è amplificata da finestre posizionate in alto, a sud-est, le quali inondano lo spazio con la luce del mattino e di metà mattinata Le stesse finestre – la casa è stata progettata per consentire la ventilazione naturale a effetto camino – possono essere aperte usando stantuffi al fine di espellere l’aria calda che, grazie ad aspiratori, viene qui convogliata da entrambe le due sezioni a due piani, contribuendo in tal modo a risolvere eventuali fenomeni di surri-
Progetto
Wain Morehead Architects Ltd , Cork (IE)
Struttura
Allen Barber Engineering Consultants Ltd , Cork (IE)
Appaltatore principale
Michael Twomey & Son, Crosshaven (IE)
Verde e paesaggio
John Butler Landscaping, Cork (IE)
Superficie
323 m2
Certificazioni
Passivhaus Institut Darmstadt
A1 BER Building Energy RatingIE (23,23 kWh/m2 anno)
Livello Oro in Home Performance
Index (Irish Green Building Council)
Sopra: le ampie vetrate a sud, dove è collocato l’ingresso, consentono di giovarsi dell’apporto solare gratuito
Qui accanto: la zona notte si affaccia su un piccolo giardino dove è sistemata anche un rimessa
scaldamento La forma planimetrica poco profonda, le porte scorrevoli e le altre aperture supportano a loro volta la ventilazione naturale dell’intero edificio nelle mezze stagioni
Con l’obiettivo di bilanciare il risparmio energetico, l’illuminazione naturale e i collegamenti tra gli spazi interni e il paesaggio circostante, si è dunque definito il progetto finale, anche se alcune necessarie modifiche hanno ridotto la larghezza del fabbricato retrostante della casa e cambiato la sua disposizione interna, compromettendo il guadagno solare in questa porzione dell’abitazione Tale perdita, combinata alla mancanza di compattezza dei volumi, ha comportato l’aumento dello spessore dell’isolamento dell’involucro così da incontrare gli obiettivi energetici tipici delle case passive in relazione alla domanda di energia per il riscaldamento degli spazi


Cork City Passive House è il primo edificio in livello Oro della HPI - Home Performance Index - in Irlanda L’HPI è il primo sistema nazionale di certificazione volontaria dell'Irlanda per lo sviluppo residenziale sostenibile e di qualità, creato dall'Irish Green Building Council (IGBC)
È stato inoltre “Progetto elogiato” nella categoria
Sostenibilità dei Royal Institute of Architects of Ireland Architecture Awards 2017
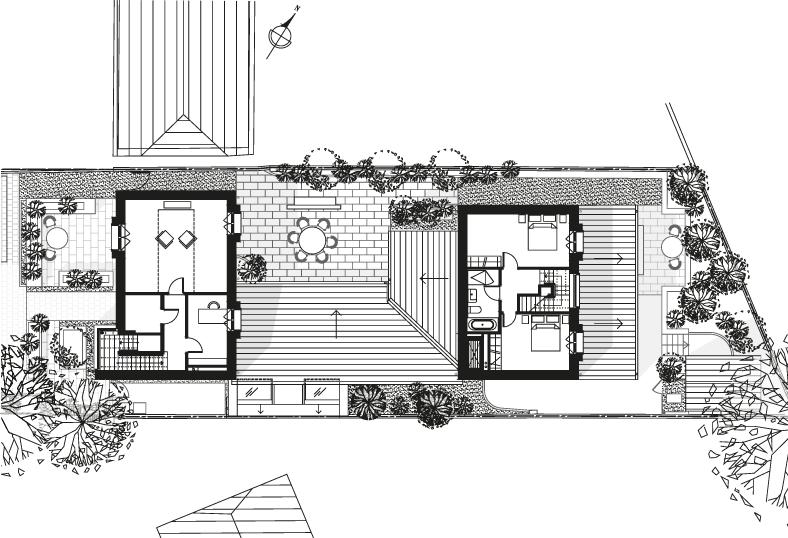
Una curiosità: i genitori dei committenti avevano vissuto e allevato i propri figli nella casa che è stata demolita Ora, quei figli hanno ricostruito la ‘loro stessa’ casa
La casa raggiunge facilmente i requisiti nZEB (near Zero Energy Buildings) futuri, con un coefficiente di prestazione energetica (EPC) di 0,143 e un coefficiente di prestazione del carbonio (CPC) di 0,145 Il massimo consentito per un nZEB è un EPC di 0,3 e un CPC di 0,35.
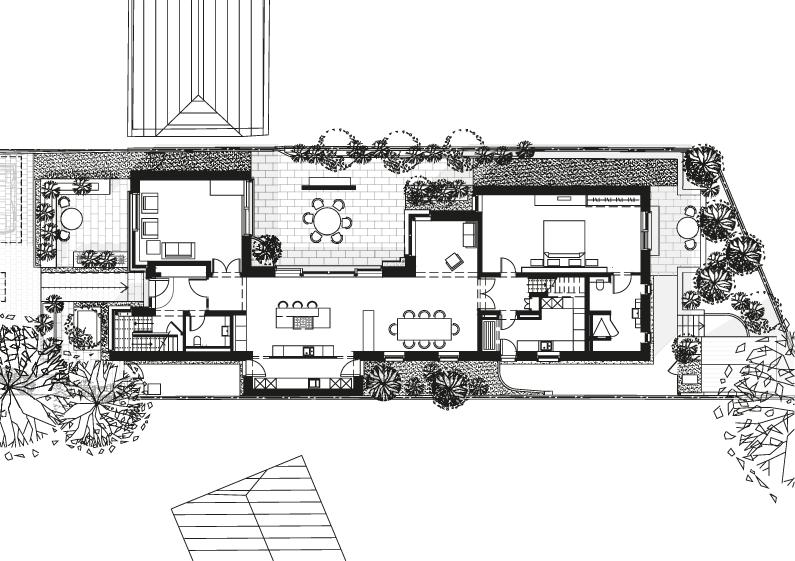
Consumo energetico annuo per riscaldamento 14 kWh/m2 anno (secondo PHPP)
Carico di calore
8 W/m2
Tenuta all’aria n50 0,6 h-1
Energia primaria non rinnovabile
66 kWh/m2 anno
Energia primaria rinnovabile
30 kWh/m2 anno (domanda), 7 kWh/m2 anno (prodotta in sito)
Surriscaldamento (PHPP)
3% (del tempo in cui la temperatura è superiore a 25 °C)


Sopra e a fianco, due immagini dello stesso ambiente, la cucina, a lavori finiti e in fase di posa delle condutture della VMC
Trasmittanza media pareti portanti esterne
U = 0,11 W/m2K
Trasmittanza media solaio contro terra
U = 0,08 W/m2K
Trasmittanza media copertura
U = 0,13 W/m2K
Trasmittanza media serramenti
Uw = 0,7 W/m2K

L’abitazione è realizzata con blocchi di calcestruzzo alleggerito con cappotto ETICS da 257 mm, posti in opera su una fondazione a zattera isolata con 200 mm di EPS Tutti i fori e i passaggi impiantistici che attraversano la struttura opaca sono stati definiti in fase progettuale e sono stati opportunamente chiusi e isolati per assicurare la tenuta dell’aria dell’involucro Le medesime operazioni sono state effettuate in corrispondenza delle connessioni tra le finestre e le pareti, i solai, i tetti e di tutte le giunzioni tra struttura esterna e tramezze interne; queste ultime sono in blocchi standard con doppio corso di blocchi termici leggeri in corrispondenza della fondazione/solaio Le coperture sono isolate con cellulosa insufflata tra le travi e, al di sopra, con un ulteriore strato coibente in fibra di legno; il tetto è rivestito da scandole di pietra blu, i cinque abbaini in lastre di zinco I solai interpiano e i corpi scala sono costituti da elementi prefabbricati in c a ; tutta la carpenteria metallica si trova all’interno dell’involucro termico ed è stata studiata attentamente per evitare la formazione di ponti termici Ricordando che nella valutazione BER (Building Energy Rating) in Irlanda al valore Ψ dei ponti termici viene aggiunto di default un valore Y pari 0,15 W/m2K, che può effettivamente raddoppiare le perdite calcolate per qualsiasi componente dato, in questo progetto sono stati analizzati 11 valori Ψ e sono stati ottimizzati i dettagli, ottenendo una riduzione del fattore Y del 77,2% fino a un accettabile 0,0342 W/m2K: questo ha ridotto il valore energetico BER per l’abitazione del 17%.
La costruzione della casa ha comportato tuttavia anche qualche complessità; a causa delle caratteristiche del lotto stretto e lungo che hanno impedito l’accesso a mezzi di sollevamento meccanici nella parte posteriore, si sono incontrate alcune difficoltà, comunque risolte, nel movimentare gli elementi prefabbricati dei solai delle scale e delle finestre, visti i pesi e le dimensioni di tali componenti. Oltre a questo, la stagione umida ha allungato l’asciugatura delle lavorazioni a umido, dilatando i tempi di cantiere, e il mantenimento della tenuta all’aria tra le parti prefabbricate e quelle realizzate in opera sono state particolarmente impegnative.
Dal punto di vista tecnologico, l’edificio è dotato di un’unità compatta che comprende una pompa di ca-
lore ad aria (esausta), una ventilazione meccanica con recupero di calore e una riserva fornita dalla pompa di calore esterna aria-acqua, la quale distribuisce il calore tramite il riscaldamento radiante solo durante i periodi più freddi in inverno La casa ha dunque una continua fonte di aria riscaldata e calda distribuita in ogni stanza che praticamente elimina polveri, allergeni aerei e muffe L’acqua calda sanitaria dell’accumulo da 180 l viene riscaldata dal calore recuperato dal sistema di VMC, mentre un secondo accumulo da 250 l di acqua pre-riscaldata è supportato dalla pompa di calore esterna solo quando la domanda di acqua calda è alta 8 pannelli fotovoltaici da 250 Wp producono annualmente 2 kW, tutte le luci sono a LED e nell’area parcheggio di fronte alla casa è stata installata una postazione per la ricarica della macchina elettrica L’acqua piovana viene recuperata, stoccata in un serbatoio in cls da 1 250 l e utilizzata per usi non potabili
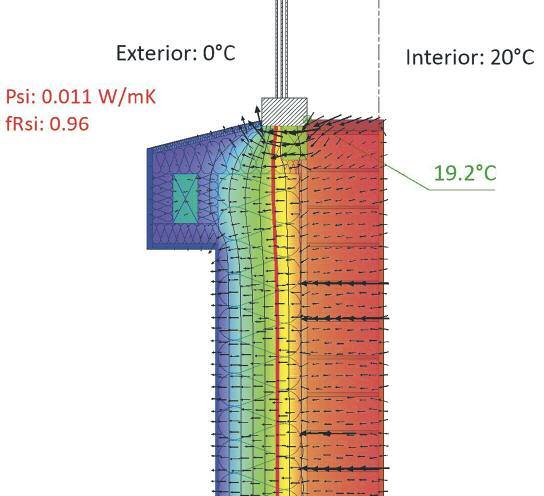
dettaglio del davanzale dell’abbaino in corrispondenza del muro esterno
Parete portante, dall’esterno:
- sistema ETICS composta da intonaco esterno autopulente e resistente alle intemperie (18 mm) e da pannelli in EPS (250 mm)
- parete in blocchi di calcestruzzo, calcestruzzo aerato autoclavato a contatto con la fondazione fondazione (215 mm)
- intonaco interno (15 mm) come strato di tenuta all’aria
collegamento tra la copertura monofalda e la parete esterna
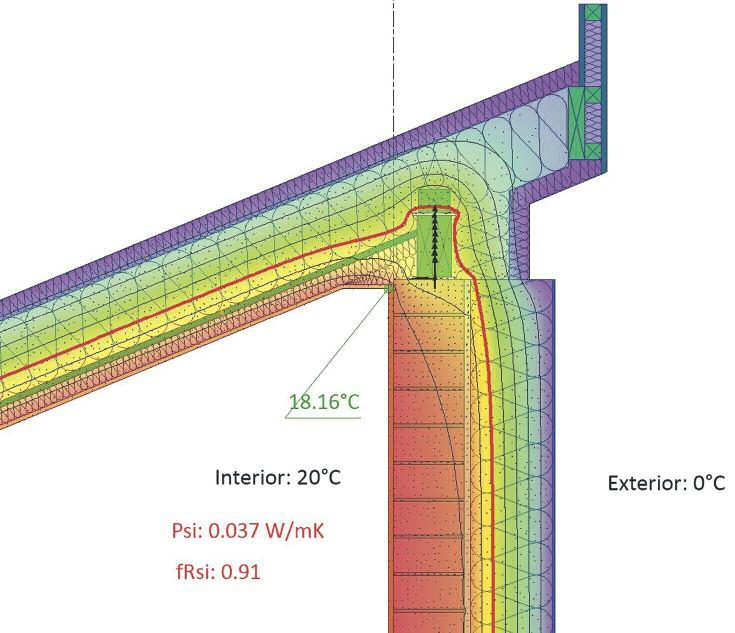

Copertura a falda, dall’esterno:
- tegole in pietra blu (500x300 mm)
- listelli (50x35 mm)
- controlistelli (50 mm)
- membrana traspirante
- pannello in fibra di legno (60 mm)
- struttura del tetto in travi (225 mm) con isolamento interposto di cellulosa
- OSB (18 mm)
- barriera al vapore
- camera per passaggio impianti (50 mm) isolata con lana di roccia
- lastra di gesso fibra e finitura
Il solaio contro terra presenta ulteriori 80 mm di coibentazione che contengono anche gli spazi per il passaggio dei tubi di ventilazione
Gli spazi secondari, quali camere o studi, sono forniti di riscaldamento radiante alimentato da una pompa di calore aria-acqua.

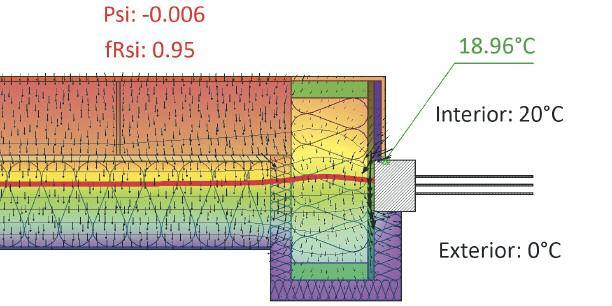
collegamento della spalletta dell’abbaino con il muro esterno
Abbaino (sezione orizzontale) con serramento, dall’esterno:
- rivestimento in zinco aggraffato
- guaina per coperture metalliche
- OSB (18 mm); listelli (50x38 mm)
- guaina da sottotetto armata
- pannello in fibra di legno (60 mm)
- OSB (18 mm)
- struttura in legno (225 mm) con interposta cellulosa
- OSB (18 mm)
- freno vapore
- controparete per passaggio impianti (20 mm)
- pannello di gesso fibra e finitura interna

Dati relativi alla cucina


Dati relativi alla camera matrimoniale
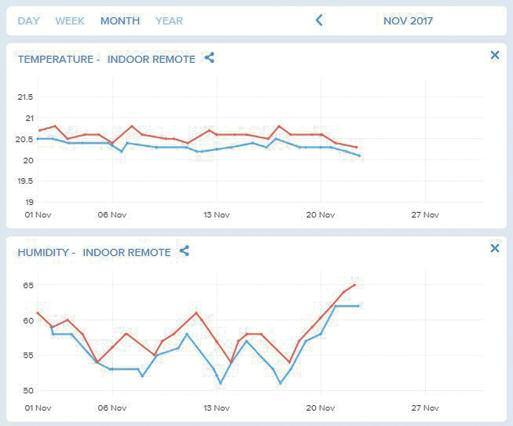
Qui sopra, i valori registrati dai sensori predisposti per il monitoraggio durante i mesi di settembre e di novembre 2017 negli ambienti della cucina (a sinistra) e della camera matrimoniale (a destra)
Qui sotto, le produzioni di energia elettrica dell’impianto FV nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 Si nota la variazione della quantità di energia prodotta – maggiore in settembre e via via a diminuire in novembre – dovuta alla minore radiazione solare

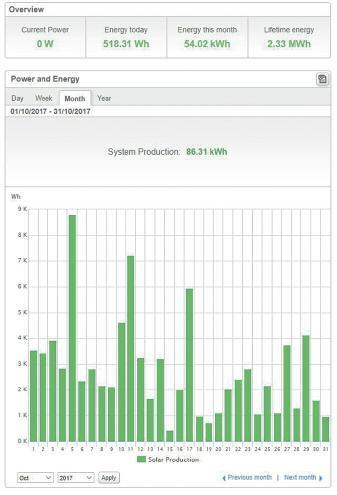
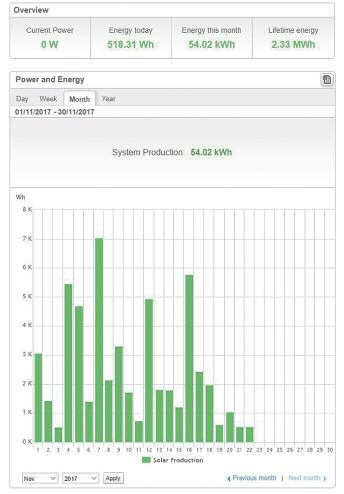
Fin dalla prima occupazione da parte del cliente, lo studio Wain Morehead Architects sta monitorando la temperatura interna, l’umidità e la CO2 in due posti della casa, come anche la domanda complessiva di energia dell’abitazione e la generazione di energia dell’impianto fotovoltaico
Anche se alcune difficoltà tecniche hanno interrotto il monitoraggio, è disponibile una serie completa di dati per il 2017 fornita da due dispositivi che sono collocati uno nella camera matrimoniale e il secondo nella sala/cucina Le letture della stazione meteorologica della cucina mostrano una maggiore, tuttavia leggera, oscillazione delle temperature rispetto a quelle della camera, a causa dei maggiori livelli di guadagno solare, delle operazioni di cottura e delle attività che generalmente si effettuano in tali aree rispetto alla camera da letto principale Questa infatti riceve molta meno energia solare ed è quindi soggetta a fluttuazioni minori nel corso della giornata Tuttavia, i dati dimostrano che l’ambiente interno si comporta coerentemente come previsto da progetto
La produzione elettrica dell’impianto fotovoltaico nel mese di settembre è di 172,17 kWh, mentre scende nel mese di ottobre a 83,61 kWh e a 54,02 kWh in novembre, a causa della diminuzione delle ore di luce utili nella stagione autunnale
Infine un dato: i costi per riscaldare la casa sono stati stimati in 224 € all’anno; il calcolo è stato effettuato con software PHPP assumendo il consumo annuo di 1 602 kWh che è stato moltiplicato per un costo dell’elettricità di 0,014 cent per kWh
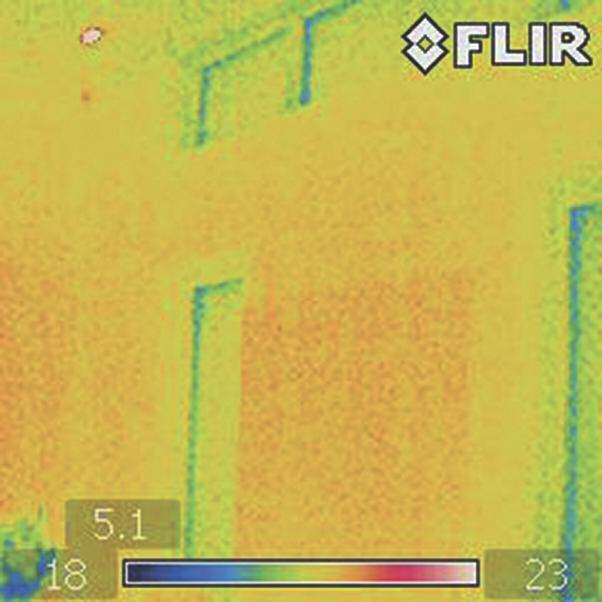


In alto, l’unità compatta di ventilazione, raffrescamento e produzione di ACS; qui sopra, la posa dei pannelli in EPS grafitato da 25 cm di spessore
A sinistra, l’immagine termografica relativa alla zona pranzo (foto sotto)



Villa unifamiliare, Rovello Porro (CO)
L’integrazione tra strategie di climatizzazione passiva e attiva è diventata l’occasione per progettare una villa sperimentale a basso consumo e basso impatto ambientale nell’alta pianura lombarda. Sono infatti l’ecosostenibilità e l’ecocompatibilità i due concetti che hanno guidato l’architetto nella realizzazione di una casa virtuosa sia dal punto di vista energetico che impiantistico.

Il fronte est dell’edificio con l’ampia vetrata della zona giorno e gli aggetti e gli sporti a sud che schermano la radiazione solare estiva
Nell’alta pianura lombarda, a metà strada tra Milano e Como, è stato realizzato un edificio a uso residenziale il cui nome riassume le linee programmatiche che stanno alla base della sua progettazione. Villa LEEH –questo il nome del fabbricato – è l’acronimo di Low Energy Experimental House, un progetto sperimentale che, pensato per raggiungere standard di ecosostenibilità e di ecocompatibilità decisamente elevati, ha riservato una grande attenzione agli aspetti bioclimatici e impiantistici e alla massima riduzione delle perdite di energia dell’involucro edilizio. Il parallelepipedo della casa, che appare quasi monolitico sul fronte nord – viste anche le poche finestre lunghe e strette e il rivestimento in marmo botticino su sottostruttura in acciaio e legno – è collocato all’interno di un lotto pressoché rettangolare, la cui disposizione lungo l’asse est-ovest favorisce i guadagni solari diretti negli ambienti interni grazie alla presenza delle aperture trasparenti a sud. I prospetti sud,
est e ovest, rivestiti con pannelli vetrati, sono interrotti da aggetti in legno e zinco-titanio i quali riflettono la radiazione solare estiva sulle pareti verticali con conseguente riduzione del carico termico e maggiore permeabilità solare invernale, quando la stessa radiazione solare è invece più orizzontale. Alla medesima funzione assolvono in egual misura il volume del primo piano in aggetto rispetto a quello sottostante e uno spazio buffer apribile in estate al piano terra. L’ottimizzazione delle risorse energetiche passive nelle varie stagioni e l’accesso al sole d’inverno vengono dunque garantiti dalla composizione volumetrica della casa e dai molteplici sistemi di schermatura e di illuminazione naturale delle zone giorno, studiati appositamente e verificati attraverso software specifici per ogni mese dell’anno. Il progetto è stato inoltre integrato da una particolare piantumazione del verde esterno che consente la correzione acustica della villa.

Progetto architettonico e direzione lavori
Angus Fiori architects, Milano
Strutture
arch Mario Visconti, Rovello Porro (CO); ing Pierpaolo Cicchiello (MB)
Impianti elettrici
Nipe Consulting S r l , Pero (MI)
Impianti meccanici
F G R , Rovello Porro (CO)
Appaltatori
LegnoCase s r l, Impresa Beltramelli s n c
Lavori
2013-2017
Superficie verde e superfici esterne
411 m2
Superficie utile
333 m2
Certificazione
Classe A+ (CENED)
A sinistra, il prospetto nord, che risulta monolitico e chiuso in virtù delle strette finestre e del rivestimento in lastre di marmo botticino
Sotto, uno scorcio del lato sud, con le vetrate al piano terra


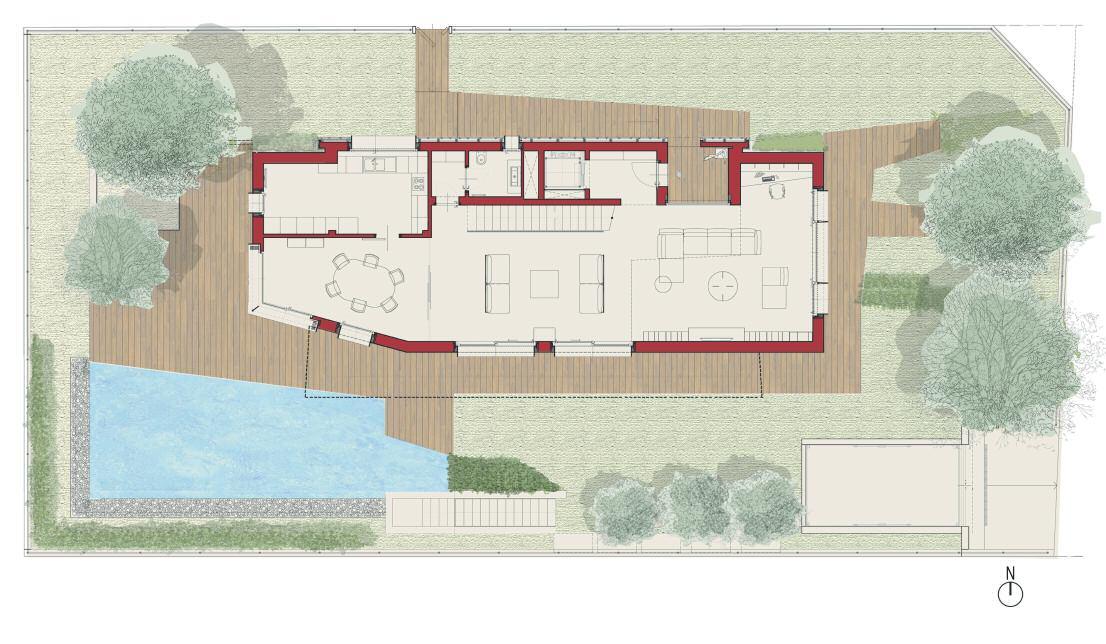
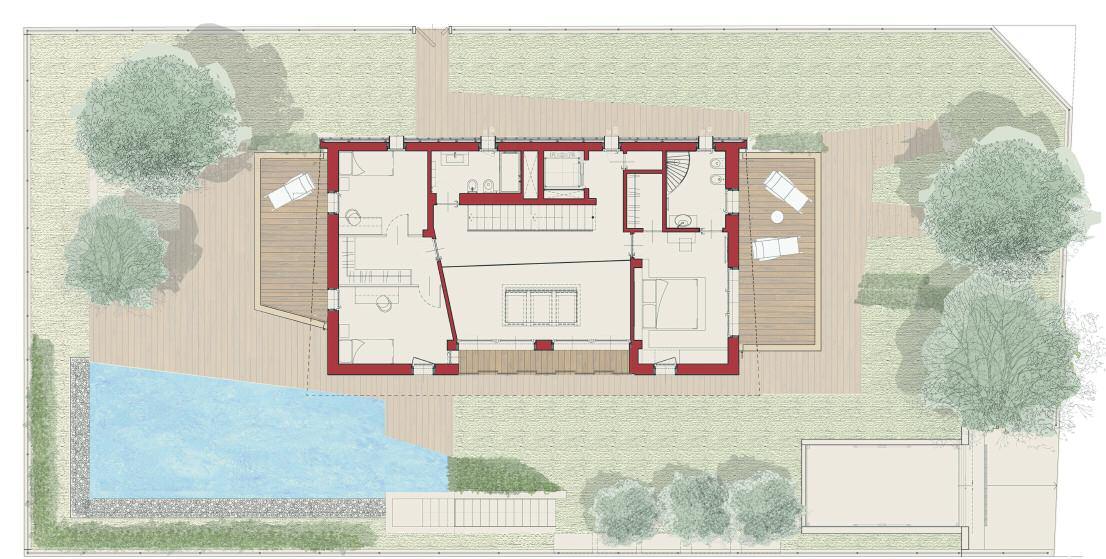
Fabbisogno per riscaldamento
12 kWh/m2 anno
Fabbisogno per ACS
3 kWh/m2 anno
Trasmittanza media pareti esterne
U = 0,12 W/m2K
Trasmittanza media solaio contro terra
U = 0,20 W/m2K
Trasmittanza media copertura
U = 0,12 W/m2K
Trasmittanza media serramenti
Uw = 0,74 W/m2K





Copertura (A), dall’estradosso:
- pavimento in gres
- sottofondo a base di calce idraulica tipo BIO-E
- doppia guaina impermeabilizzante
- massetto di pendenza in cls con rete elettrosaldata
- guaina traspirante tipo Tyvek
- isolante termoacustico in fibra di legno mineralizzata
- strato separatore e barriera al vapore
- solaio in legno con isolamento interposto in fibra di legno
- finitura interna in legno fresato montato su telaio in legno
Nella pagina a fianco, dall’alto a sinistra in senso orario isolamento del pilastro strutturale metallico; dettaglio della coibentazione della struttura in prossimità d’angolo; esecuzione dell’isolamento con fibra di legno della copertura e realizzazione dei due lucernari; posa del rivestimento in lastre di marmo sulla sottostruttura metallica che forma inoltre una camera di ventilazione; vista della struttura mista dell’edificio in metallo e legno
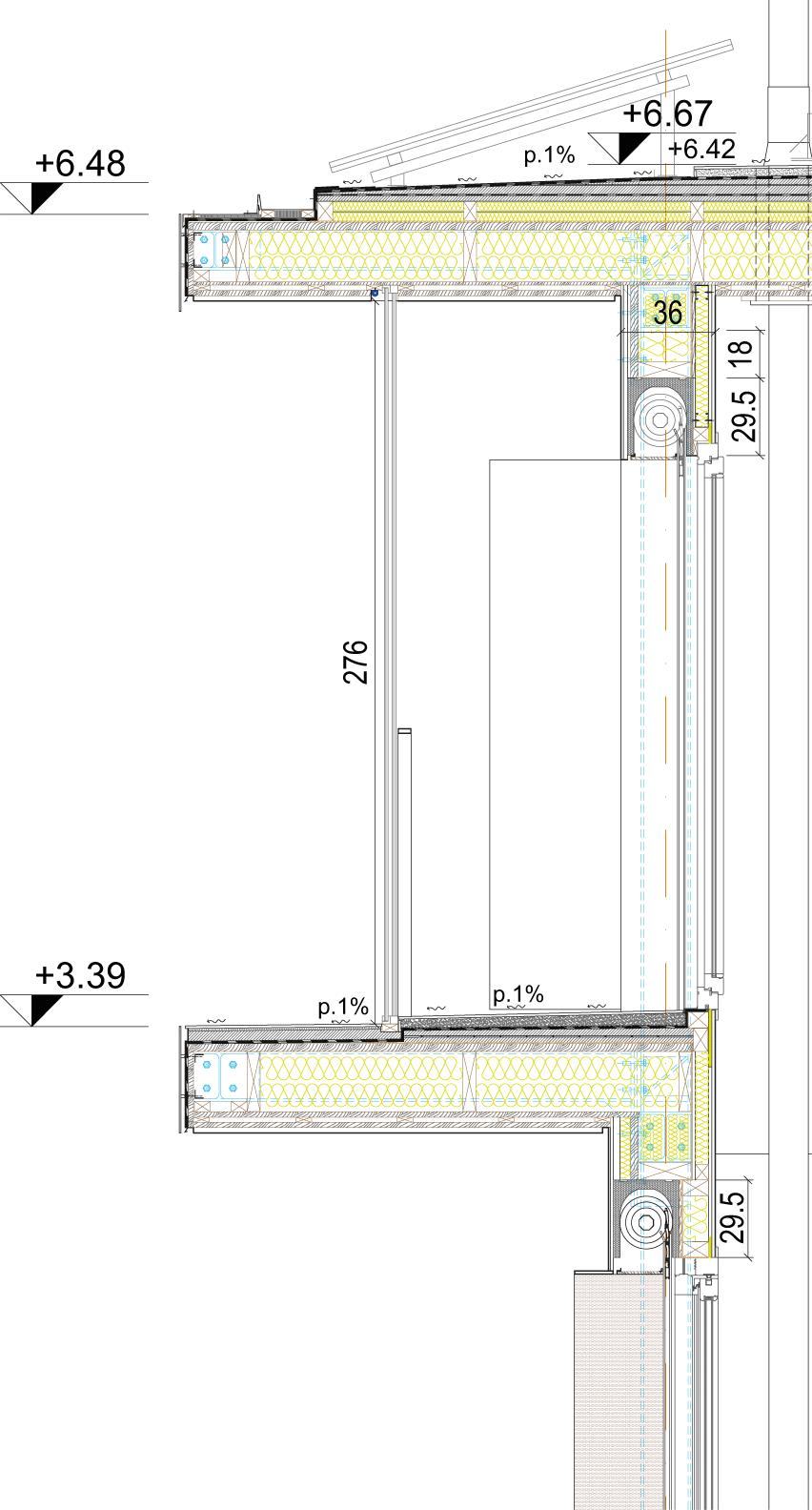
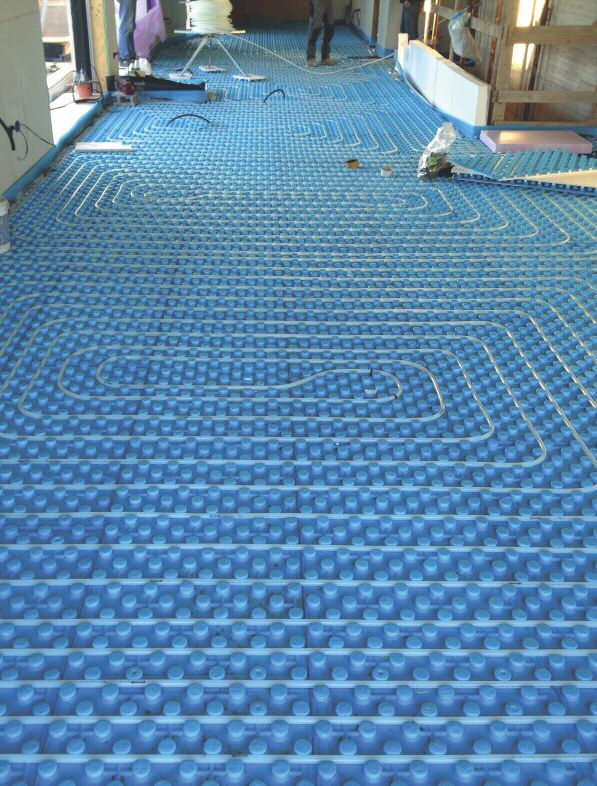
Posa del impianto di riscaldamento a pavimento su pannello bugnato

Cavedio impianti e distribuzione delle tubazioni di VMC, elettriche, idrauliche e del riscaldamento
sezione orizzontale - serramento
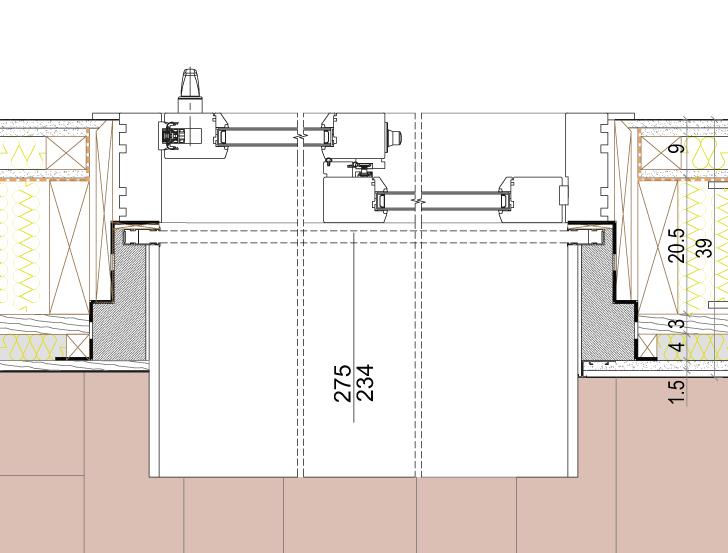
interno
esterno
Parete, dall’interno:
- parete costituita da doppia lastra in gessofibra, telaio metallico con interposto isolante termoacustico in fibra di legno e pannello in OSB
- barriera al vapore
- parete a telaio in legno con interposto isolante in fiocchi di cellulosa ad alta densità
- pannello OSB
- telaio a montanti verticali in legno con interposto isolante termoacustico in fibra di legno
- lastra portaintonaco in vetro riciclato con rete di armatura in fibra di vetro su entrambe le facce
- intonaco di finitura con leganti ai silicati
- facciata ventilata a doppio telaio
I due livelli fuori terra sono realizzati con un sistema costruttivo prefabbricato a secco, misto legno-acciaio, e con solai lignei del tipo cassonato, a eccezione del piano interrato costruito con calcestruzzo armato
Tutte le stratigrafie che costituiscono l’involucro sono state progettate e create a secco e hanno comportato la scelta di materiali ecosostenibili, quali ad esempio pannelli in fibra di vetro riciclata, lastre in gessofibra e isolanti in lana di legno La stessa propensione alla sostenibilità e all’ecologicità si ritrova anche nei componenti edilizi dell’involucro opaco e in particolare nelle finiture interne dove i pavimenti sono in doghe di rovere spazzolato, sbiancato e certificato FSC, nelle vernici e negli stucchi di origine vegetale e minerale e nel gres porcellanato composto da materiali riciclati
Villa LEEH è stata progettata per essere climatizzata sia attivamente che in modo passivo Tra le tecnologie attive sono presenti un solare termico di 6 m2 e un campo fotovoltaico di 6 kW non integrato con la rete pubblica di distribuzione dell’energia: entrambi gli impianti sono connessi con un sistema di pompe di calore e di scambiatori di calore, con la ventilazione meccanica con recupero di calore, con il sistema di accumulo di acqua calda sanitaria a sua volta completato da una termostufa alimentata a legna o a pellet.
Le strategie passive di climatizzazione sono invece messe in opera durante le stagioni intermedie e in estate. In dettaglio, nelle mezze stagioni, le due macchine di ventilazione meccanica, poste all’interrato come pure le pompe di calore e gli inverter del fotovoltaico, entrano in funzione durante le ore diurne coadiuvate dai pannelli radianti che attenuano il carico di calore degli ambienti; di notte si attua invece un raffrescamento passivo sfruttando l’effetto camino creato, grazie alle
aperture poste in facciata e in copertura e comandate elettricamente In estate invece il camino di ventilazione viene chiuso, demandando il raffrescamento alle macchine di ventilazione meccanica controllata e al circuito del pavimento radiante in ciclo freddo
Il complesso involucro-impianto così composto ha consentito di classificare l’edificio in classe A+
CENED
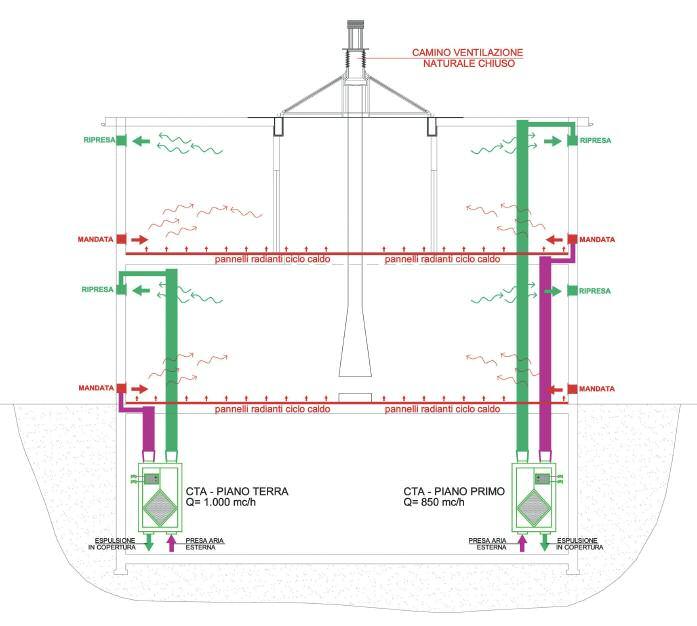
Schema funzionamento trattamento aria – ciclo invernale
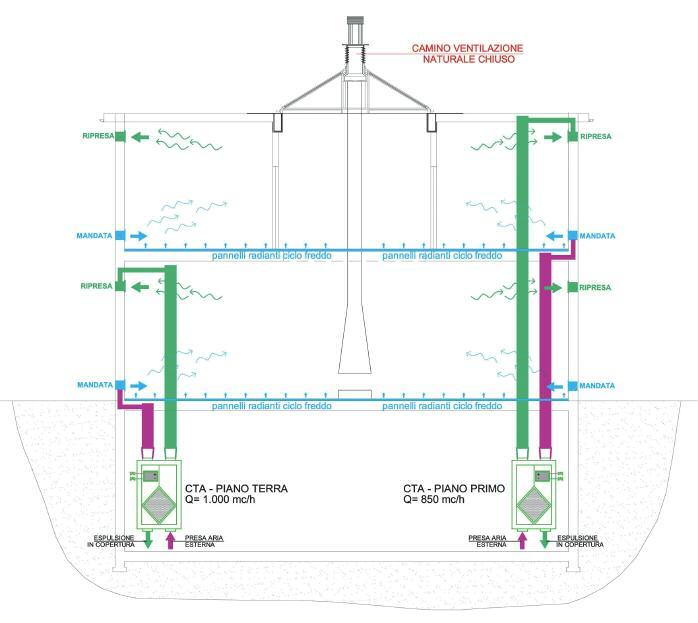
Schema funzionamento trattamento aria – ciclo estivo


Ca’ d’Oro
Bifamiliare, Udine
Frutto di un’attenta valutazione dello stato di fatto, delle problematiche connesse con le preesistenze e delle potenzialità progettuali attuabili, un edificio residenziale a Udine è stato recuperato, risanato e ampliato raggiungendo ottime prestazioni energetiche. Un eccellente esempio di progettazione integrata in città che ha consentito inoltre di mantenere anche buona parte della struttura portante originale.
Progetto architettonico, consulente energetico e DDLL
geom Paolo Paviotti, Udine
Strutture
ing Massimo Cisilino, Pasian di Prato (UD)
Impianti
p i Federico Giorgis, Udine
Appaltatore
Finedil, Paradiso di Pocenia (UD)
Lavori
luglio 2013 – novembre 2014
Superficie fondiaria
823 m2
Superficie utile
184 m2
Superficie verde
410 m2
Certificazione
CasaClima Gold; PassivHaus (richiesta)

Costruita alla metà del secolo scorso in una zona prettamente residenziale in prossimità del centro storico di Udine, una casa su due piani ha ottenuto la certificazione CasaClima Gold dopo essere stata ristrutturata completamente e ampliata, a dimostrazione che una corretta progettazione del sistema edificio-impianto genera ottimi risultati anche quando si opera sull’esistente.
Il progetto nasce dalle richieste della committenza che desiderava recuperare la struttura portante della casa in sasso e laterizio, in buone condizioni, per realizzare due unità immobiliari sovrapposte e indipendenti con un ampliamento a livello del terreno sul retro. La palazzina doveva essere inoltre pensata come un edificio a basso consumo energetico, a ridotte emissioni di sostanze inquinanti, dotato di grande

comfort abitativo – con temperature ottimali e uniformi all’interno – e prov visto di una maggiore privacy, pur non rinunciando a integrare il verde esterno con gli spazi indoor.
Per rispondere dunque alle esigenze dei proprietari è stato stimato in primis il livello di efficienza energetica conseguibile, analizzando i problemi legati alla presenza dei numerosi ponti termici, valutati con simulazioni agli elementi finiti per quantificarne l’entità, e ipotizzando soluzioni tecniche per il loro attenuamento e riduzione. Vista la possibilità di ottenere buoni risultati dalla riqualificazione del fabbricato e la disponibilità dei committenti nel condividere gli obiettivi, si è deciso di effettuare un upgrade della classe di prestazione energetica e di certificare l’edificio in standard CasaClima Gold.


Nella pagina a fianco, un’immagine della struttura portante dell’edificio, in sasso e laterizio, all’inizio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione.
Qui sopra, il fronte con la terrazza coperta che guarda verso il giardino, a sud-ovest.
A sinistra, parte del prospetto sud-est, visibile dalla strada
1 pergolato
2 soggiorno
3 cucina-pranzo
4 tettoia
5 terrazza coperta
6 ingresso
7 ripostiglio
8 studio
9 letto
10 bagno
11 giardino pensile
12 terrazza
13 angolo cottura
14 soggiorno-pranzo
15 lavanderia
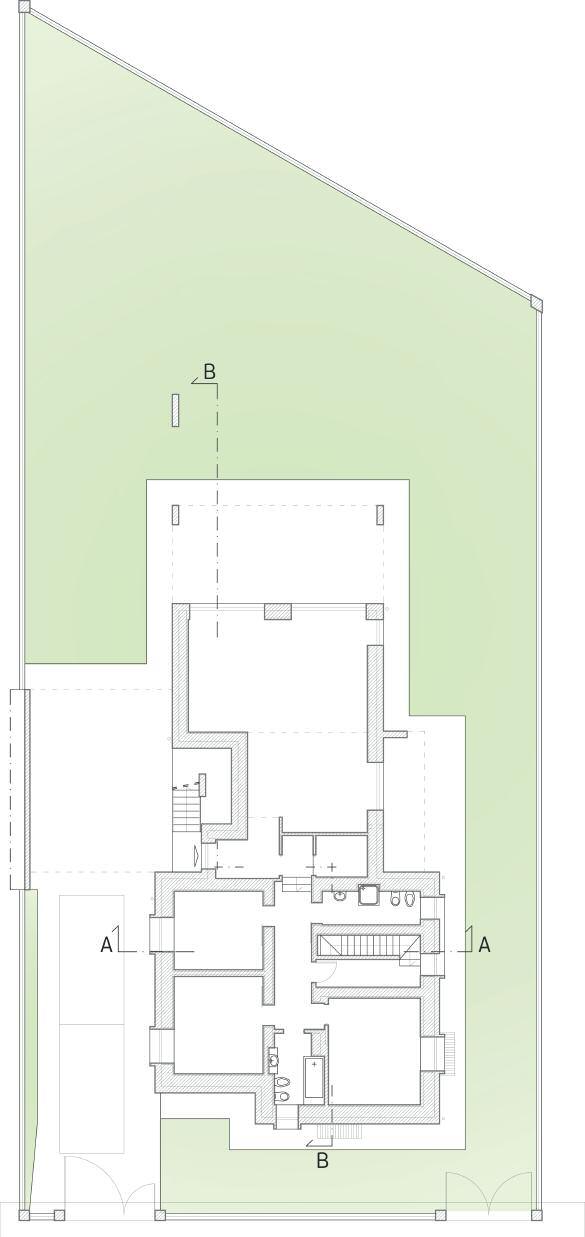
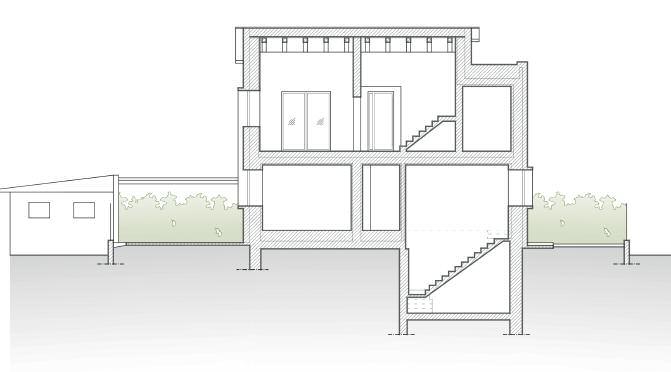
Il progettista, auditore e consulente CasaClima, ha calcolato che, nelle condizioni climatiche di Udine, con un perimetro di 42 m e una lunghezza del ponte termico di 126 m, la sola perdita per trasmissione dovuta proprio al ponte termico sarebbe stata pari a 1 233,51 kWh/anno, corrispondenti a una spesa di circa 155 €/anno con un impianto a gas metano (rendimento 80%), che si tradurrebbe in una perdita di 3 800 € in 25 anni; nella stima non si è tenuto conto dell’inflazione e dell’aumento del costo del combustibile
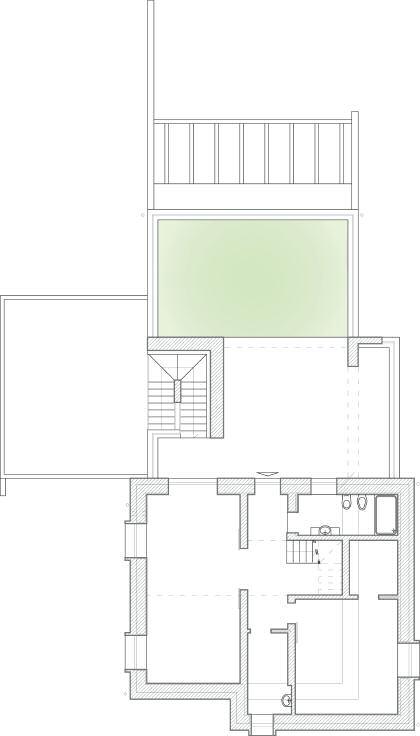
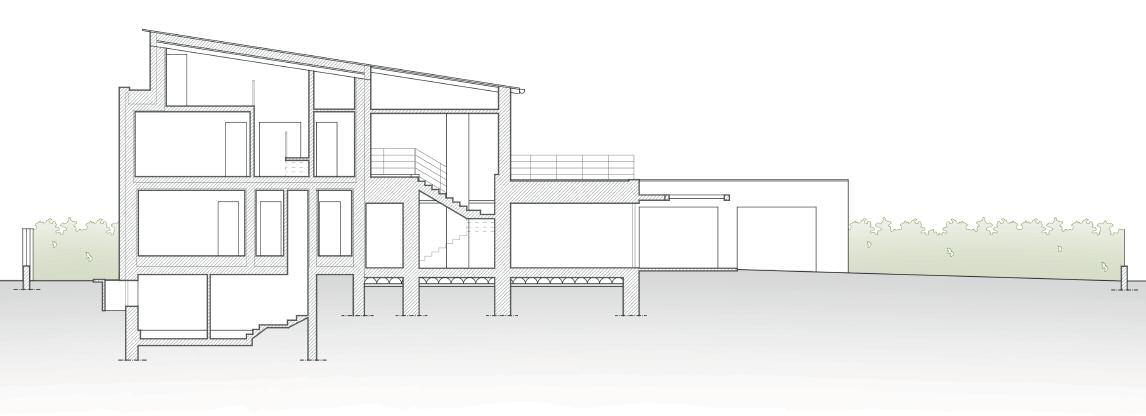
sezione longitudinale BB
Consumo energetico annuo per riscaldamento 5,49 kWh/m2 anno
Consumo energetico annuo per ACS 18,61 kWh/m2 anno
Consumo energetico annuo per raffrescamento estivo 23,87 kWh/m2 anno
Trasmittanza pareti esterne
U = 0,10 W/m2K
Trasmittanza solaio contro terra
U = 0,11 W/m2K
Trasmittanza copertura
U = 0,09 W/m2K
Trasmittanza serramenti
Uw = 0,66-0,89 W/m2K

L’abitazione esistente, disposta su due piani fuori terra e uno interrato, si presentava con una muratura portante in sasso e laterizio, una copertura a falde in legno, solai in latero-cemento e con un impianto di riscaldamento a gas metano e radiatori a parete Dopo le analisi agli elementi finiti, che hanno messo in evidenza la possibilità di ridurre i ponti termici e di avere temperature superficiali al di sopra dei 17 °C, si è provveduto a mettere in opera tutte le soluzioni progettate per migliorare e aumentare le prestazioni termiche dei nodi costruttivi disperdenti (in particolare verso il terreno e lo scantinato) e a eliminare tutti gli aggetti esterni Per garantire privacy, come richiesto, e per beneficiare degli apporti solari, le aperture sono state drasticamente ridotte sul fronte principale a nord-est, favorendo invece la realizzazione di ampie vetrate verso sud-ovest in corrispondenza dell’ampliamento, la zona giorno dell’unità abitativa al piano terra che ora si apre verso il giardino invertendo la disposizione planimetrica originaria degli spazi interni Al di sopra del nuovo volume un tetto verde, realizzato anche per favorire il deflusso graduale delle acque piovane, permette l’accesso dell’appartamento superiore a un’area verde La sola parte completamente rimossa del vecchio fabbricato è la copertura a falde, sostituita da un tetto a un’unica falda che ha consentito la creazione di una zona soppalcata nella abitazione al primo piano e che integra un impianto fotovoltaico. Con questi interventi la trasformazione della casa è stata integrale, al punto tale che oggi è impossibile riconoscere la struttura portante del vecchio edificio, recuperata e ripristinata, nella sua nuova configurazione architettonica.
Come più volte sottolineato, uno degli obiettivi primari della progettazione e successiva realizzazione di questa riqualificazione è stato rappresentato dalla riduzione dei ponti termici individuati e analizzati e le caratteristiche del vecchio edificio hanno rappresentato a volte un’opportunità di miglioramento della prestazione energetica. È il caso infatti dell’altezza utile interna del piano terra, pari a 3 m, che ha dato la possibilità di posare l’isolamento termico, i massetti e la pavimentazione senza demolire il solaio contro terra e anzi con questa soluzione è stata alzata la quota dell’estradosso del solaio, distanziando in modo
sufficientemente elevato il terreno così da assicurare anche la corretta sovrapposizione dell’isolamento esterno verso il basso per attenuare il ponte termico sui muri perimetrali L’isolamento a cappotto è stato realizzato con EPS grafitato e per ridurre ulteriormente il ponte termico delle strutture in elevazione e sulle superfici interne di entrambi gli alloggi è stato posato uno strato di isolante di 5 cm accoppiato a una doppia lastra di cartongesso, soluzione che ha inoltre permesso di far passare gli impianti senza intaccare e indebolire puntualmente la muratura portante È stato escluso dall’involucro riscaldato il piccolo disimpegno di collegamento tra l’appartamento al piano terra e l’interrato che ospita la lavanderia, i locali accessori e la centrale termica e ciò ha comportato l’adozione di particolari accorgimenti al fine di assicurare un’adeguata trasmittanza termica delle strutture in comune e la riduzione dei ponti termici corrispondenti La nuova copertura con struttura portante in legno è isolata dall’interno verso l’esterno con 10 cm di poliuretano e 20 cm di fibra di legno al fine di aumentare la massa del pacchetto tetto e prevede una microventilazione sotto manto realizzata con doppia listellatura incrociata Questa stratigrafia ha dunque determinato un adeguato sfasamento e smorzamento dell’onda termica
La stessa cura progettuale è stata riservata anche all’involucro trasparente, ottimizzando la posizione e la
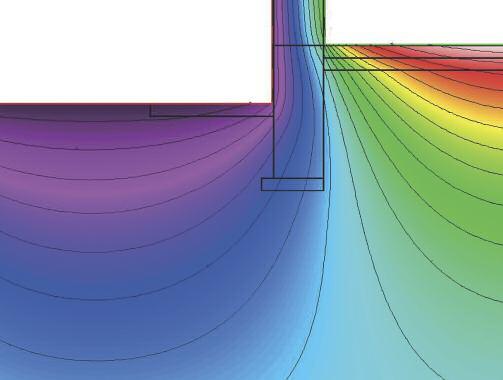
Queste due immagini rappresentano lo stesso nodo (solaio piano terra esistente verso la fondazione) prima e dopo l’intervento di riqualificazione interno ti = 20 °C 6,3 °C esterno te = -5 °C
dimensione delle aperture e la loro schermatura; a nord-est esse sono ridotte al minimo, mentre a sudovest sono state preferite ampie finestre che si affacciano sull’area verde privata retrostante Ogni aggetto fisso è stato studiato con attenzione relazionandosi con il percorso solare annuale e, per gestire al meglio gli apporti gratuiti del sole, sono state installate schermature mobili esterne ottimizzate da un sistema domotico In tutto l’edificio sono stati installati serramenti in PVC a triplo vetro con riempimento della vetrocamera in gas argon In corrispondenza di ogni apertura è stata curata la riduzione dei ponti termici e la tenuta al vento e all’aria nastrando i giunti più delicati e importanti



esterno te = -5 °C 18,2 °C
L’isolamento di uno dei lucernari/abbaini Le temperature superficiali sono indicative del netto miglioramento delle condizioni di comfort indoor, grazie al loro aumento significativo dovuto all’isolamento interno ti = 20 °C
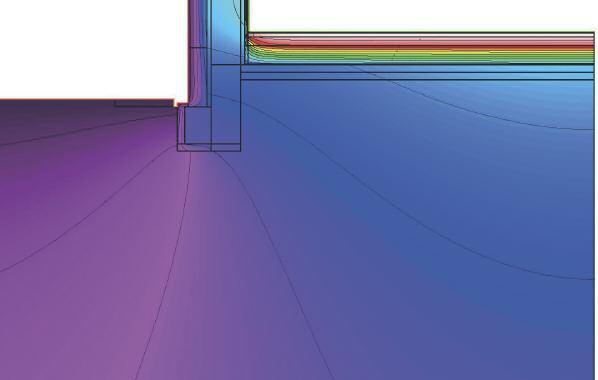
La meticolosità dimostrata nella progettazione prima –e nel controllo delle lavorazioni in cantiere poi – ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla direttiva CasaClima verificati mediante Blower Door Test; un dato per tutti: l’abitazione al primo piano, alla prova della tenuta all’aria, ha ottenuto il valore n50 di 0,39 h-1. Grazie alla minimizzazione del fabbisogno energetico, raggiunta attraverso la riqualificazione dell’involucro, non è stato installato alcun impianto di riscaldamento convenzionale mentre le cucine sono dotate di piani a induzione. Le limitate richieste per riscaldamento e raffrescamento, infatti, sono soddisfatte da un sistema di ventilazione meccanica controllata con batteria di post-riscaldamento e post-raffrescamento, alimentate da una pompa di calore elettrica che produce anche l’acqua calda. Una parte del consumo elettrico è coperta dai due impianti fotovoltaici dalla potenza complessiva di 8,5 kW che sono integrati sulla falda di copertura.


Copertura verde, dall’esterno (nuovo):
- pacchetto verde pensile (200 mm)
- telo filtrante
- strato di accumulo (25 mm)
- guaina impermeabile (5 mm)
- isolamento in XPS (300 mm)
- barriera al vapore o (5 mm)
- solaio monolitico in c a (250 mm)
- intercapedine d’aria (260 mm)
- cartongesso e finitura (12 mm)
1 EPS
2 poliuretano
3 cassonetto
4 serramento triplo vetro
5 isolamento in XPS
6 laterizio porizzato con riempimento minerale
7 vetro cellulare granulare
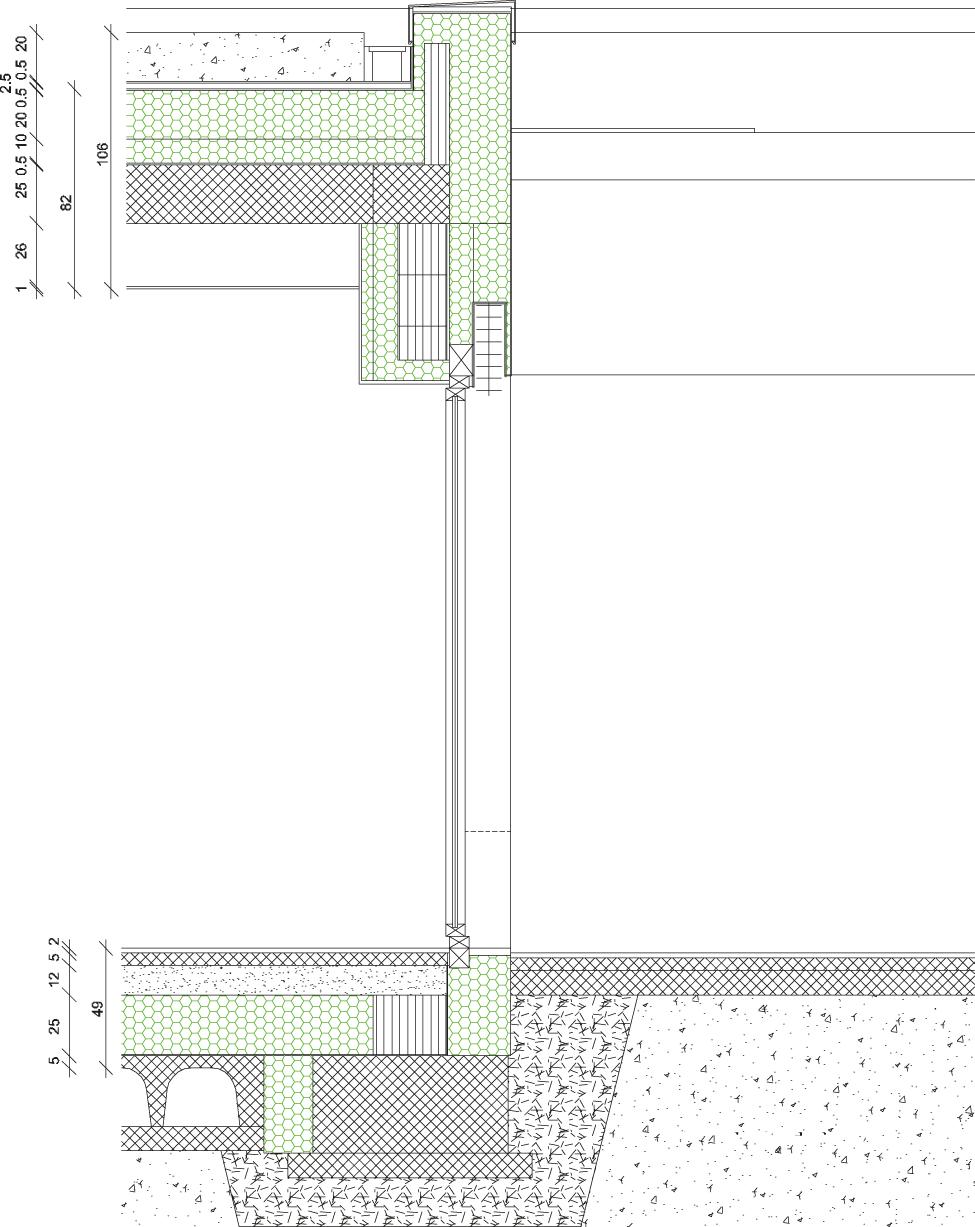
Solaio contro terra, dall’estradosso (nuovo):
- pavimento in legno (20 mm)
- massetto in cls (50 mm)
- massetto alleggerito (120 mm)
- isolamento in XPS (250 mm)
- caldana in c.a. (50 mm)
- vespaio aerato in igloo
- magrone cls (100 mm)
Solaio interpiano dall’estradosso (esistente):
- pavimento in legno (20 mm)
- massetto in cls (50 mm)
- massetto alleggerito (50 mm)
- isolamento in XPS (120 mm)
- piastrelle esistenti (10 mm)
- solaio in latero-cemento (215 mm)
- intonaco calce-cemento (1,50 mm)
- lana di roccia (50 mm)
- cartongesso e finitura (1,2 mm)
Solaio terrazzo verso vano riscaldato, dall’estradosso (esterno):
- piastrelle (10 mm)
- guaina impermeabile (5 mm)
- massetto in cls (50 mm)
- massetto alleggerito (190 mm)
- isolamento in XPS (200 mm)
- poliuretano (100 mm)
- barriera al vapore
- solaio in laterocemento (250 mm)
- intercapedine d’aria (260 mm)
- cartongesso e finitura (1,2 mm)
Parete esterna, dall’esterno (nuovo):
- rasatura e finitura (5 mm)
- isolante in EPS (250 mm)
- lastra c a (50 mm)
- laterizio (300 mm)
- lastra c.a. (50 mm)
- lana di roccia (50 mm)
- cartongesso e finitura (12 mm)
Copertura, dall’esterno (nuovo):
- manto di copertura
- listelli in abete
- listelli di ventilazione
- telo traspirante
- fibra di legno (200 mm)
- poliuretano espanso (100 mm)
- barriera al vapore
- tavolato di abete (30 mm)
- puntoni in abete (interasse 800 mm)
Nella pagina a fianco, in alto, da sinistra: i diversi strati di pannelli in fibra di legno che coibentano la copertura e, a destra, le tubazioni a pavimento degli impianti
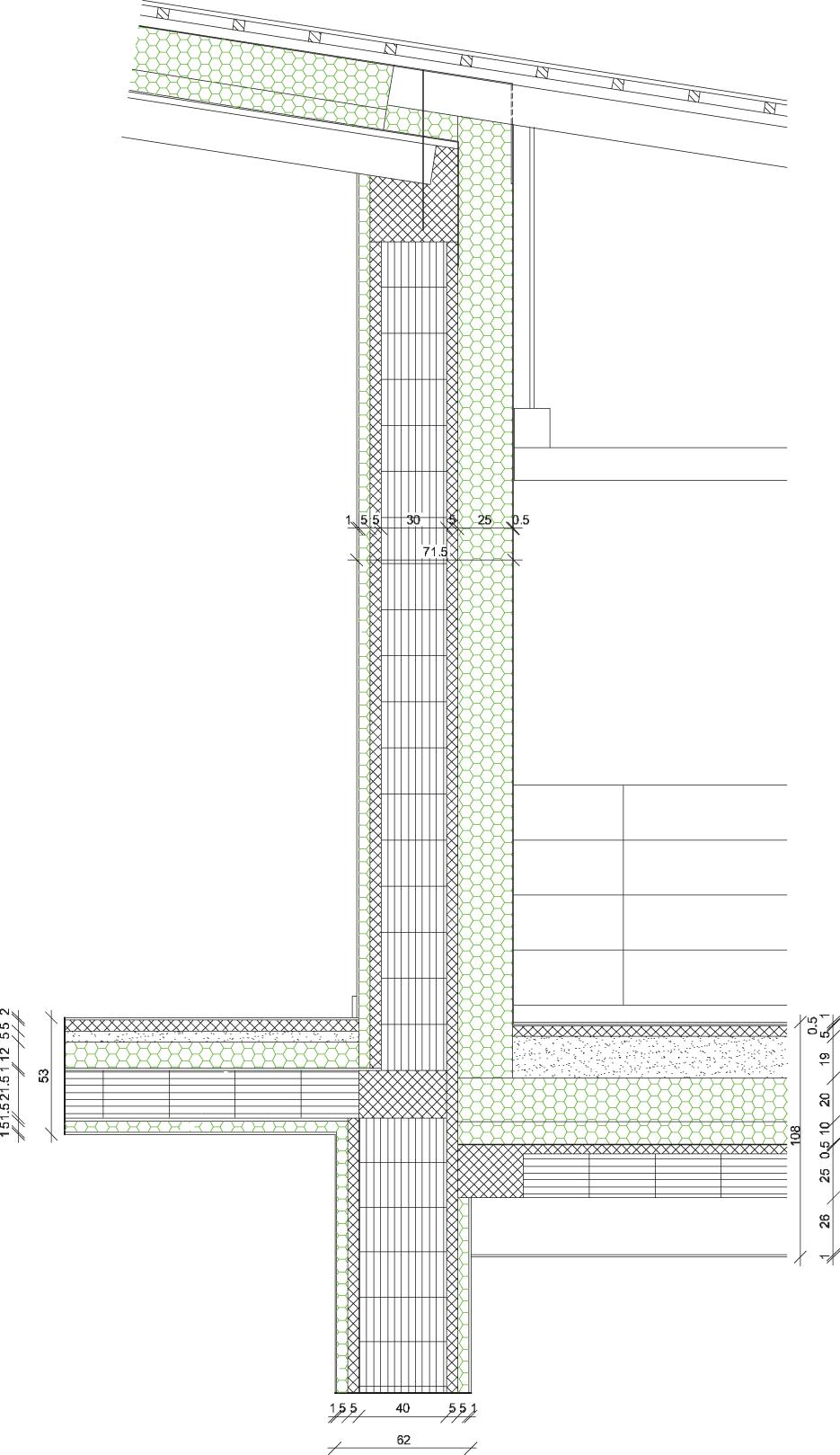
1 fibra di legno
2 trave in abete
3 cordolo in c.a.
4 tirante
Giacomo Bergonzoni
Il BIM, acronimo di Building Information Modeling, è, a tutti gli effetti, una risposta pratica alla crescente esigenza di sostenibilità: facilita i processi collaborativi fra le varie discipline, mette a disposizione strumenti per le analisi energetiche fin dalle prime fasi di progettazione e, finalmente, permette di analizzare l’edificio in tutto il suo ciclo di vita.
Il progetto della nuova Manifattura Bulgari è un esempio di come il metodo BIM può supportare la progettazione sostenibile.
La progettazione sostenibile è un tema di attualità dal 1992, quando venne lanciata l’idea dell’Agenda 21 al vertice delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro. In quegli anni si capì che l’inefficienza nel settore dell’edilizia incideva per circa il 40% sull’utilizzo di energia a livello mondiale. Inoltre, nell’edilizia era presente oltre il 50% del risparmio potenziale di energia e pertanto esso fu considerato come un settore che avrebbe potuto rispondere in modo incisivo alle sfide globali della riduzione del consumo di energia e dei cambiamenti climatici.
Aumento
La popolazione mondiale è destinata ad aumentare, di conseguenza anche le risorse pro capite andranno diminuendo. Anche la migrazione dalle campagne alle città è in costante crescita, tanto che già nel 2009 l’umanità è diventata a maggioranza urbana. Le di-
ciannove megalopoli di oggi consumano i due terzi dell’energia fossile e producono tre quarti delle emissioni di gas serra che provocano i cambiamenti climatici; si stima poi che tali megalopoli diventeranno ventisette nel 2025, incrementando notevolmente la pressione sull’ambiente naturale. Se si aggiunge che, superata la soglia dei 10 milioni di abitanti, la governabilità del territorio e la sua sicurezza diventano di difficile gestione, si capisce che la sfida dei nostri tempi, dunque, è quella di progettare e costruire nuove e differenti città, sicure, accoglienti e durevoli per l’umanità del futuro: le Smart Cities.
Perché il termine “BIM”
è sempre più utilizzato nel settore delle costruzioni?
Nel 1992 venne coniato l’acronimo “BIM”, che sta per

Building Information Modeling, ma è solo 10 anni dopo che cominciò a diffondersi per comunicare in maniera semplice e diretta un concetto già esposto negli anni ‘70 da Charles M. Eastman. Oggi si parla di BIM in tutte le principali fiere mondiali dell’edilizia, sono nati nuovi eventi specifici per la divulgazione del BIM e anche in Italia abbiamo assistito di recente al Digital&BIM, che ha sostituito l’edizione 2017 del SAIE di Bologna.
Il BIM è un framework che comprende processi e strumenti che mirano a migliorare la qualità e l’efficienza dell’ambiente costruito, rendendo praticabile una reale progettazione sostenibile che guarda l’edificio in tutto il suo ciclo di vita. Proprio per questo, il BIM si può intendere anche come una risposta pratica e attuabile alla crescente ricerca di sostenibilità del settore delle costruzioni.
Se analizziamo i trend di ricerca su google delle parole “sustainable” e “BIM” nel settore immobiliare dal
2004 ai giorni nostri, possiamo notare un’inversione di tendenza che dimostra la crescente consapevolezza del significato di sostenibilità accompagnato da un crescente interesse riguardo al Building Information Modeling.
“Sostenibilità” dell’ambiente costruito vuol dire innanzitutto risparmiare energia diventando più efficienti. Se confrontiamo l’andamento della produttività dell’industria delle costruzioni con quella manifatturiera è evidente come sia possibile migliorare sensibilmente.
L’aumento di produttività dell’industria manifatturiera è stato costante anche grazie all’introduzione delle nuove tecnologie digitali, mentre quella delle costruzioni non è riuscita a evolversi. L’introduzione del metodo BIM permette di raggiungere una mag-
giore produttività standardizzando i processi, rendendoli più simili all’industria manifatturiera Ov viamente rimarrà sempre un certo gap tra le due perché nel design del prodotto si può ottimizzare la progettazione di un prototipo per poi produrlo in serie, mentre nell’architettura ogni edificio è un prototipo
avere
La ricerca di sostenibilità ha portato al concetto di Smart City, un’idea innovativa di città che mette in relazione l’ambiente costruito con il capitale umano, intellettuale e sociale di chi le abita grazie all’impiego diffuso delle nuove tecnologie
Una “vera” Smart City si potrà avere solo quando ogni singolo edificio, esistente o da costruire, sarà virtualizzato e trasformato in uno Smart Building: un insieme di dati che possano informare l’amministrazione per la gestione e lo sviluppo dell’ambiente urbano Il BIM è l’unica via che permette di passare a una progettazione e a una gestione digitale, producendo Smart Buildings che andranno a popolare le Smart Cities del futuro
Perché la parola “sostenibilità” non si riduca a una semplice buzzword senza contenuto è necessario poterla misurare Proprio da questa istanza nascono i protocolli di sostenibilità come LEED (1992), BREEAM (1990), ESTIDAMA Pearl Rating System (2010), Envision Rating System for Infrastructure (2011) Questi sistemi di valutazione certificano un edificio a un certo livello di sostenibilità: per raggiungere i gradi più alti è necessario impostare una progettazione integrata sin dalle prime fasi e verificare che le scelte strategiche iniziali siano mantenute fino alla costruzione dell’opera, inserendo il controllo di enti terzi
i protocolli di sostenibilità
Il BIM e i protocolli di sostenibilità condividono gli stessi obiettivi: efficienza, qualità e, quindi, sostenibilità Il processo BIM agevola la collaborazione fra tutte le discipline, permettendo una progettazione integrata altrimenti difficilmente raggiungibile e ha come

L’efficienza degli edifici è una delle strade più facili da percorrere per tagliare le emissioni
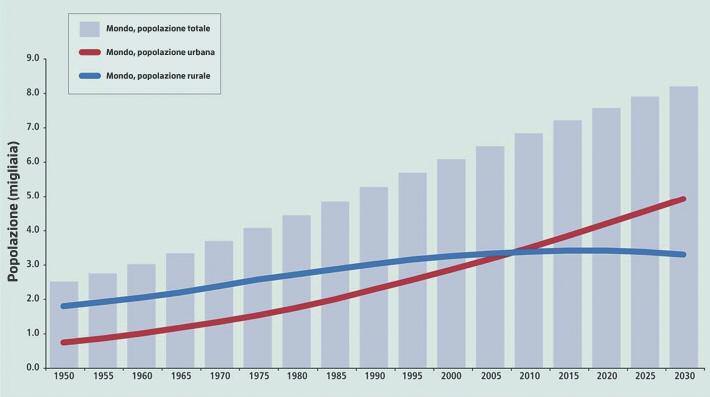
Popolazione urbana e rurale mondiale, 1950-2030 (Fonte: Department of Economic and Social Affairs, Population Division World urbanization prospects: the 2005 revision New York: United Nations, 2006)

Tendenze di ricerche su Google per “BIM” e “Sustainable” nel settore immobiliare (Fonte: Google Trends, https://trends google com/trends/explore?q=BIM,Sustainable &date=2004-10-01%202017-11-01&cat=29#TIMESERIES)
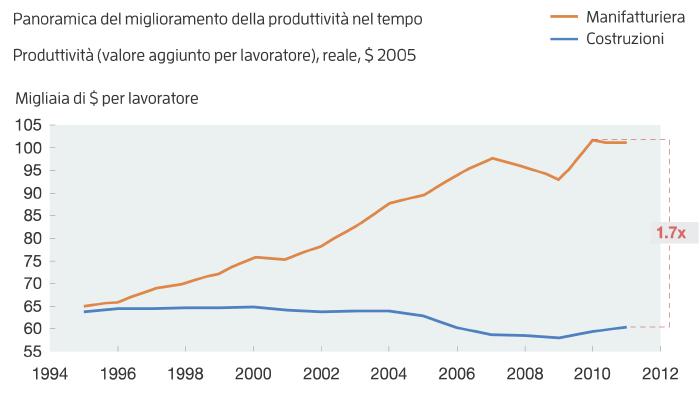
La produzione nell’industria manifatturiera è quasi raddoppiata laddove, invece, quella del mondo delle costruzioni è rimasta pressoché uguale (Fonte: Expert interviews; IHS Global Insight (Belgium, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom, United States; World Input-Output database)
prodotto un edificio virtuale che è essenzialmente un database interrogabile contenente già tutto quello che serve per valutare il livello di sostenibilità del manufatto Questo concetto l’hanno capito bene nel Regno Unito dove, già nel 2013, è nato il RegBIM Project, un software che permette il calcolo automatico della valutazione di sostenibilità secondo il protocollo BREEAM partendo da un modello BIM in formato IFC
Il BIM, quindi, può avere diverse definizioni in base al punto di vista da cui lo si guarda, ma le sue caratteristiche principali lo rendono particolarmente adatto a supportare una progettazione sostenibile: la collaborazione e l’approccio olistico
Il BIM è prima di tutto collaborazione Con l’aumentare delle complessità da affrontare nella progettazione di un edificio, non si può più pensare di affrontare questa impresa da soli ma svariati specialisti devono coordinarsi per arrivare al risultato migliore.
Grazie al BIM è possibile scambiare informazioni con gli specialisti delle analisi energetiche: questo av viene tramite dei formati di interscambio aperti standardizzati a livello internazionale, IFC e gbXML.
L’interoperabilità tra diversi software è quindi fondamentale per poter attuare delle analisi energetiche fin dall’inizio e
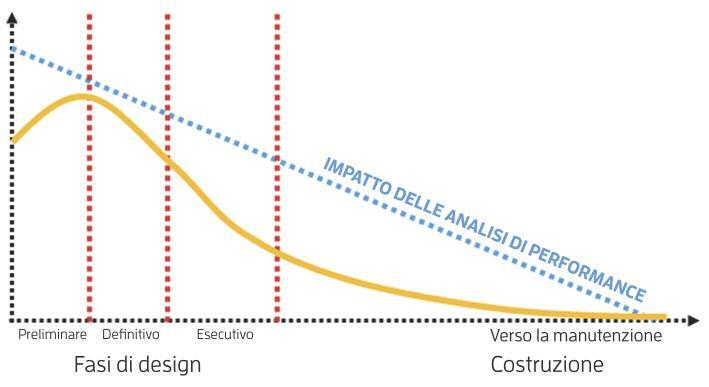
valutare le configurazioni più sostenibili proprio nella fase in cui si ha ancora la possibilità di modificare il progetto
Il BIM è dallo studio di fattibilità fino alla demolizione
L’approccio olistico del BIM è una vera rivoluzione nel mondo delle costruzioni: non si guarda più all’edificio spezzettato nelle sue fasi, ma si prende in considera-
Impatto delle analisi di performance in relazione alle fasi progettuali
(Fonte: C Vittori Antisari, tratta dal libro “La sfida del BIM” di Chiara C Rizzarda e Gabriele Gallo - 2017)
zione tutto il ciclo di vita dell’opera Con il BIM non ci si può occupare solo della progettazione o della costruzione o della gestione senza preoccuparsi di ciò che viene prima e di ciò che succederà dopo Il BIM Execution Plan è proprio quel documento che deve accompagnare tutti i progetti dove si specifica come dovranno essere strutturate le informazioni all’interno del modello digitale in modo che possano essere utilizzate nelle fasi successive del ciclo di vita dell’edifi-
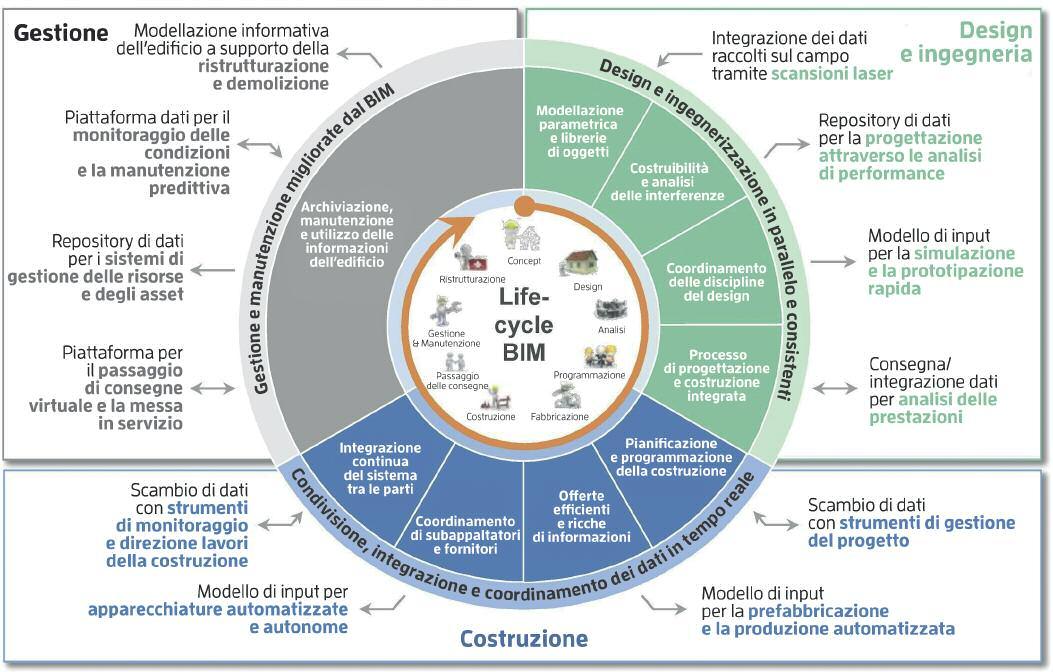
Fonte: World Economic Forum, Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology

cio (vedi immagine pagina a fianco)
La sostenibilità di un’opera si può raggiungere solamente analizzando l’edificio nel suo complesso: non è più sufficiente integrare le varie discipline specialistiche o prestare attenzione alle sole progettazione e costruzione, ma è necessario avere uno sguardo sempre puntato verso un orizzonte più ampio, cioè si mira a rendere sostenibili anche la gestione e manutenzione dell’opera.
È sicuramente interessante analizzare le sinergie fra la progettazione sostenibile e il processo BIM dal punto di vista teorico, ma può essere ancora più valorizzante scoprire come si possa applicarle a un caso reale come la nuova Manifattura Bulgari, progettata dallo studio di progettazione integrata Open Project di Bologna e illustrata nelle fotografie di queste pagine.
Il progetto riguarda la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo della Bulgari Gioielli S p a : il complesso ospita le funzioni produttive e amministrative in due edifici dai caratteri architettonici decisamente differenti. L’amministrazione è ospitata nel primo insediamento orafo di Valenza, degli inizi del XIX secolo, che è stato demolito e ricostruito per il suo valore storico-simbolico.
La proposta progettuale ne prevede l’ampliamento con un corpo interamente in cristallo, una “estrusione” contemporanea e tecnologica della sagoma originale, in cui sono ospitate le funzioni ricettive del complesso.
La produzione (e le relative funzioni di servizio) è invece ospitata all’interno di un nuovo corpo edilizio, separato e arretrato rispetto all’edificio storico, organizzato su 3 livelli, di cui uno seminterrato. Il suo assetto planimetrico è estremamente lineare, finalizzato all’ottimizzazione del processo produttivo e al contenimento dei costi di realizzazione. Si tratta di un padi-


glione quasi quadrato (circa 73x70 m) di circa 11 m di altezza, caratterizzato da una grande corte interna di quasi 600 m2 che garantisce ottimi livelli di illuminamento e ventilazione naturale, pur salvaguardando gli elevati requisiti di sicurezza richiesti dal committente
Le caratteristiche del processo produttivo e la necessità di realizzare più piani sovrapposti comportano la presenza in facciata di una serie di elementi tecnologici (condotti, canali, attrezzature) oggetto di continue modifiche e integrazioni L’effettiva impossibilità di controllare l’effetto di tali modifiche sui prospetti (a breve, ma soprattutto a lungo termine) e la volontà di garantire al committente tutta la necessaria flessibilità operativa, salvaguardando al contempo la qualità estetica del complesso, ha portato alla creazione di una “pelle architettonica” metallica, staccata di circa 6 metri dalla facciata dell’edificio.
Le soluzioni tecniche ipotizzate consentono la visione totale verso l’esterno per gli operatori, garantendo al contempo il livello di privacy e sicurezza adeguati al particolare processo produttivo.
Attuare la progettazione integrata con il metodo BIM non ha significato solamente saper utilizzare un software innovativo, ma ha avuto una ricaduta su tutto il processo progettuale.
A destra, curva di Macleamy che mostra come il processo BIM anticipi le scelte progettuali (Credit: Open Project s r l )
Qui sotto, esploso assonometrico del modello informativo federato della Manifattura Bulgari, in giallo sono evidenziate le componenti impiantistiche
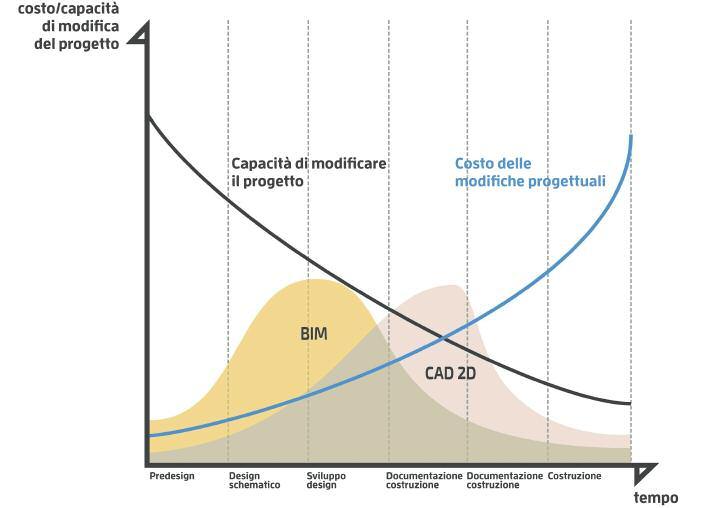
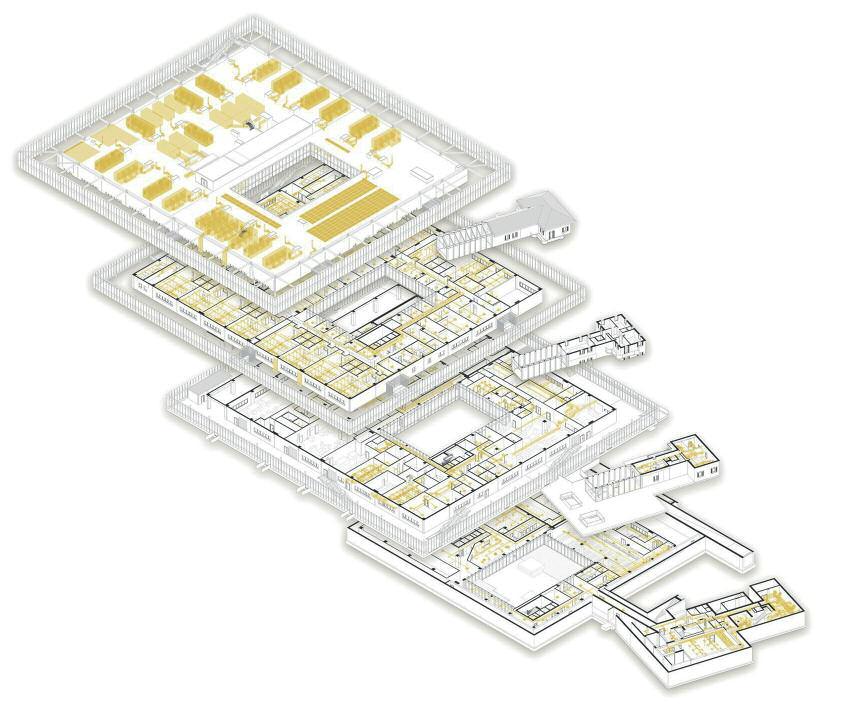
Credit:OpenProjectsrl
Modellare in 3D e attribuire set di informazioni a oggetti intelligenti ha obbligato i progettisti ad affrontare alcune questioni in un’ottica completamente nuova. Avendo piante, prospetti e sezioni inesorabilmente coordinati, è risultato obbligatorio risolvere problematiche che in un progetto tradizionale in 2D avrebbero rischiato di essere tralasciate o posticipate a una fase troppo avanzata del percorso progettuale (vedi grafico in alto, in questa pagina). Questa rivoluzione ha avuto certamente un impatto iniziale quasi scioccante, ma si è riusciti a organizzare bene il lavoro, cioè a fare in modo che le informazioni inserite
fossero ordinate e facilmente estrapolabili dal modello anche da chi non l’aveva virtualmente costruito. Grazie a ciò il ritorno sull’investimento si è dimostrato notevole.
Il vero salto di qualità nei progetti BIM si ha quando tutte le discipline vengono rappresentate in un modello unico e integrato. Per questo motivo si è deciso
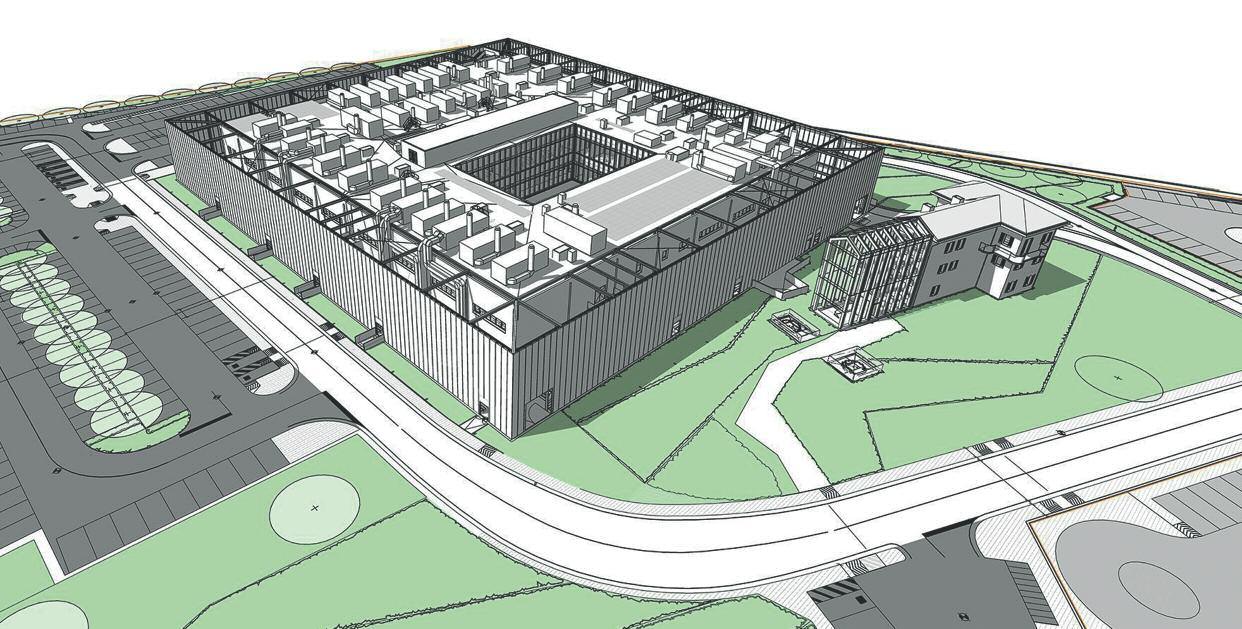
di investire e convertire in BIM anche i contributi di collaboratori esterni non ancora “BIM ready” Si è arrivati a un modello federato che ne contiene altri quattro: architettonico, strutturale in acciaio, strutturale in cemento armato e impiantistico Questo modello federato ha permesso di individuare le interferenze fra le varie discipline, analizzarle con i progettisti specialistici interessati e risolverle prima di arrivare in cantiere
Bulgari Gioielli S.p.a. ha richiesto di avere il primo edificio produttivo in Italia certificato LEED Gold. L’utilizzo del metodo BIM ha dato diversi vantaggi alla progettazione secondo gli standard LEED, ma molti sono ancora solo potenziali e oggetto di una continua ricerca che Open Project porta avanti in parallelo all’attività strettamente professionale. Il primo vantaggio è quello di creare, all’interno dell’unico file di riferimento, un set di tavole specifiche per la richiesta di certificazione LEED. Il BIM team si è quindi impegnato a creare etichette e modelli di vista speciali seguendo le richieste del LEED AP. Il modello esportato in formato gbXML è stato utile anche per l’attività di commissioning, poiché è servito come verifica del modello per l’analisi energetica.
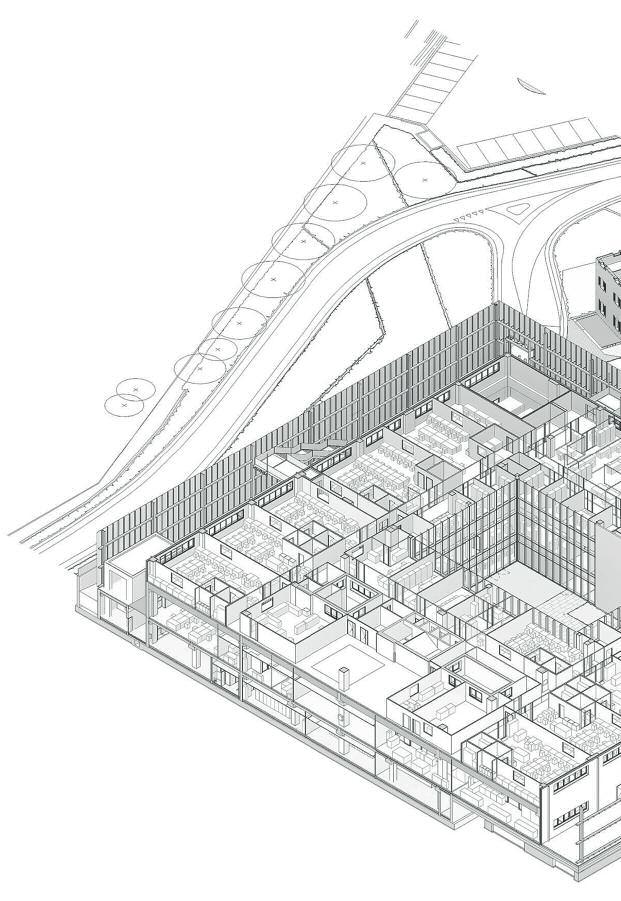
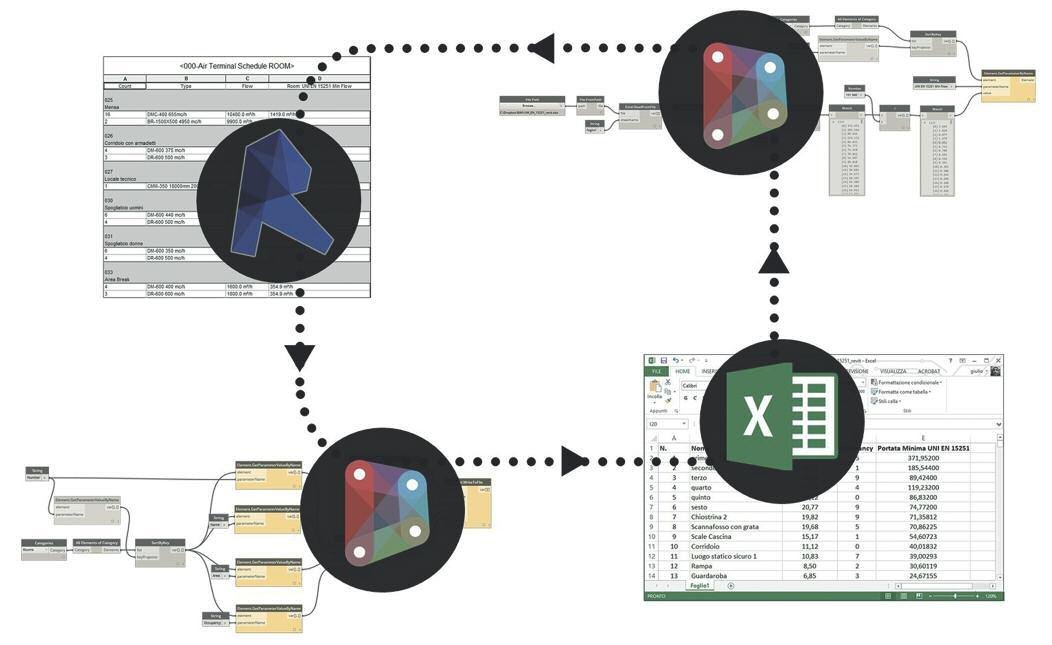
Pagina a fianco, vista prospettica del modello informativo federato
Qui sopra, workflow per la verifica automatica dei crediti LEED integrata nel processo BIM
(Credit: Open Project s r l )
Qui sotto, vista assonometrica di uno spaccato tridimensionale del modello informativo architettonico e strutturale.
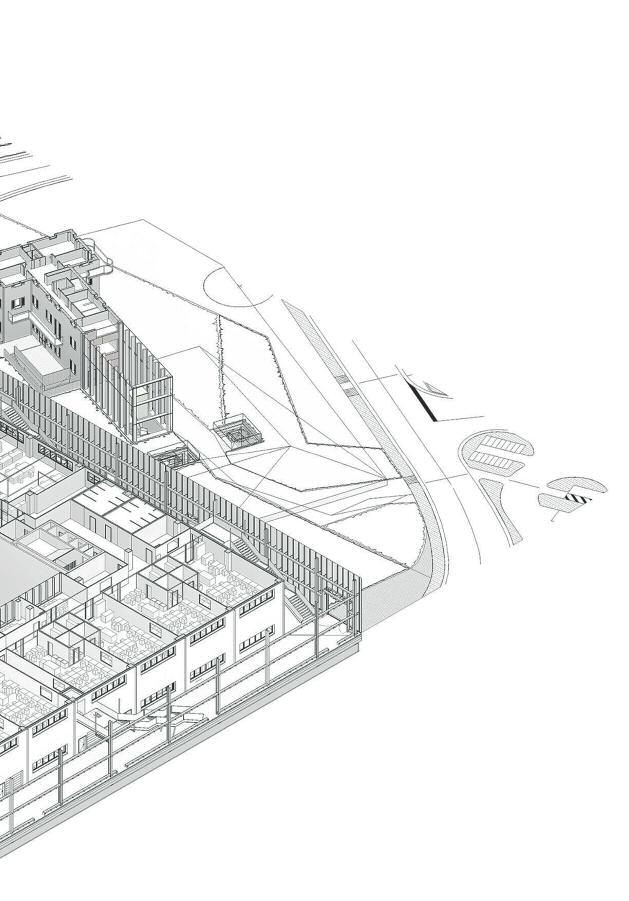
Grazie all’attività di ricerca è stato possibile automatizzare l’interoperabilità fra Revit ed Excel con il software di programmazione visuale Dynamo, operazione schematizzata nell’immagine soprastante Con questo algoritmo si è interrogata la portata delle bocchette presenti in ognuna delle circa 300 stanze dell’edificio per poi controllare che fossero stati rispettati i requisiti minimi della norma UNI EN 15251. In questo modo la verifica del credito LEED è stata monitorata durante tutto il processo progettuale.
“Le città sostenibili” di Andrea Poggio, 2013
“La sfida del BIM” di Chiara C. Rizzarda e Gabriele Gallo, 2017.
“Climate Change 2007: Synthesis Report” del IPCC Fourth Assessment Report (AR4), 2007
“Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology” del World Economic Forum, 2016.
“World urbanization prospects: the 2005 revision” del Department of Economic and Social Affairs, Population Division New York: United Nations, 2006
Giacomo Bergonzoni Laureato in Ingegneria Edile-Architettura all’Università di Bologna, è Passive House Designer certificato, BIM Manager nello studio di progettazione integrata Open Project e docente con BIM Foundation; promuove il BIM come relatore a eventi e conferenze nazionali e internazionali
Le strategie progettuali volte a realizzare l'edificio nZE si concentrano soprattutto nella ricerca di materiali e di processi eco-compatibili, spesso trascurando la sostenibilità “cognitiva” dell’edificio.
Questa lacuna deriva dalla scarsa conoscenza che in generale architetti e progettisti hanno della biofilia, il nostro legame con la Natura, legame che affonda le proprie radici nella nostra storia evolutiva.
Rita Berto, Giuseppe Barbiero

Un esempio di green architecture di grande impatto visivo ma discrepante con l’ambiente circostante Complesso residenziale privato su più livelli (Juhu, Mumbai –India) Guz Architects
Green building è un sistema di progettazione che, da un punto di vista strettamente scientifico, intende alterare il meno possibile i cicli biogeochimici di Gaia (Barbiero, 2017) L’obiettivo finale è l’edificio a “impatto zero”: il net Zero Energy Building (nZEB) Nel Nord America, nel Sud Est Asiatico e in Europa sono stati creati diversi paradigmi di pianificazione edilizia da enti certificatori come LEED®, BREEAM®, WELL Building StandardTM, Living Building ChallengeTM, BCA Green Mark, Passivhaus, Protocollo Itaca, che in modi diversi orientano la progettazione a impatto zero Tuttavia questi protocolli definiscono solo le prestazioni energetiche degli edifici, cioè quanto l’edificio è amico dell’ambiente, ma trascurano quanto l’edificio è amico della persona La progettazione sostenibile può essere di grande effetto (si veda per esempio Guz Architects’ design a Singapore o il Bosco Verticale a Milano), ma molto spesso questo tipo di progettazione è artificiale e non riflette ciò che la Natura ha realmente da offrirci (Immagine a lato). Questa idea di sostenibilità ambientale non si spinge oltre le caratteristiche fisico-estetiche dell’edificio per includere anche il benessere e la qualità della vita delle persone che lo occuperanno.
La letteratura scientifica da tempo considera il valore rigenerativo di un ambiente come il fattore più importante da prendere in considerazione nella progettazione (per una sintesi si veda Barbiero, 2011; Barbiero, 2014; Berto et al., 2015). In un ambiente rigenerativo (restorative environment) l’individuo può rilassarsi, liberare la mente da eventi emotivamente negativi, vivere un’esperienza di bellezza, controllo, libertà e usufruire di un momento importante per il processo di regolazione emozionale e del sé. Il concetto di ambiente rigenerativo è legato al concetto di stress ambientale. Lo
stress si verifica quando le richieste ambientali nei confronti degli individui superano le rispettive capacità di risposta; situazioni di stress si verificano quotidianamente compromettendo il buon funzionamento dell’individuo e provocando il verificarsi di disturbi fisiologici e/o psicologici (Baroni & Berto, 2013) Per riuscire a salvaguardare il benessere psicofisico le persone apprendono strategie di coping, cioè rimedi che consentono loro di far fronte e gestire le situazioni stressogene Una di queste strategie è l’esposizione agli ambienti naturali che oltre ad essere apprezzati per le loro qualità estetiche, lo sono anche perché promuovono il recupero e il mantenimento del benessere psicofisico La ricerca sugli ambienti rigenerativi è stata molto produttiva negli ultimi anni (per una rassegna si veda Berto, 2014) In sintesi, sappiamo che: (1) gli ambienti naturali sono percepiti come più rigenerativi degli ambienti costruiti, ma la presenza di elementi naturali aumenta la preferenza e il valore rigenerativo anche di quelli costruiti (Foto pag. 90 in alto); (2) tra la preferenza ambientale e il valore rigenerativo di un ambiente esiste una relazione diretta e indipendente dalla familiarità (grafico 1 pag. 91; Purcell, Peron & Berto, 2001): in pratica preferiamo gli ambienti che ci fanno stare bene (e viceversa); (3) un ambiente rigenerativo è percepito come tale indipendentemente dal genere o dall’età dei soggetti (Grafico 2 pag. 91; Berto, Magro & Purcell, 2004; Berto, 2007).
Perché un ambiente naturale è percepito come più rigenerativo di uno artificiale? Che cosa accade di particolare durante l’esposizione alle scene naturali da renderle rigenerative? Se si confrontano i movimenti oculari - in particolare le fissazioni, che sono ritenute un indice della quantità di attenzione necessaria per osservare una scena- relativi alla visione di scene naturali e urbane, a parità di informazione contenuta nelle scene si registrano differenze significative. Le scene

naturali sono caratterizzate dalla presenza di stimoli affascinanti, gli elementi naturali, che attraggono l’attenzione involontaria; in pratica gli ambienti naturali sono osservati senza che questo affatichi il sistema cognitivo Le scene urbane invece richiedono l’intervento dell’attenzione volontaria e del meccanismo che inibisce le distrazioni, processo che necessita sempre di uno sforzo cognitivo (Grafico 3 pag. 91; Berto, Massaccesi & Pasini, 2008). L’esposizione alle scene naturali attiva la componente parasimpatica del sistema nervoso autonomo. Questa componente non è presente nella risposta alle scene urbane che invece coinvolge il sistema nervoso simpatico. Sebbene il sistema nervoso simpatico consenta agli esseri umani di rispondere rapidamente con uno stato di attivazione dell’organismo a situazioni potenzialmente minacciose e/o stressogene, di fatto provoca uno stato di affaticamento e diverse alterazioni nelle risposte endocrine e cardiovascolari, con effetti negativi per la salute (Baroni, Berto, 2013). Al contrario, l’esposizione alla Natura e l’attivazione del sistema nervoso parasimpatico promuovono cambiamenti positivi sia a livello fisiologico, come ad esempio la diminuzione della frequenza cardiaca, della tensione muscolare, della conduttanza

della pelle e della pressione arteriosa (Stress Recovery Theory; Ulrich, 1981) sia a livello psicologico, con un miglioramento del tono dell’umore, della sensibilità percettiva e dell’attenzione involontaria (Attention Restoration Theory; Kaplan, 1995).
La ricerca sugli ambienti rigenerativi tuttavia non assume che l’ambiente naturale sia l’unica fonte di esperienza rigenerativa, e nemmeno che tutti gli ambienti artificiali siano privi di un potenziale rigenerativo.
Nella pagina a fianco, in alto, un esempio di come gli elementi naturali possono essere integrati in un contesto residenziale urbano che si affaccia su una strada aumentando il valore estetico della costruzione e il legame con il mondo naturale dei residenti (Scottsdale, AZ -USA)
In basso, un esempio di come elementi naturali reali e artificiali possono essere integrati in un ambiente interno a uso commerciale aumentandone il valore estetico e la percezione di rigenerazione dei visitatori
Interno del centro commerciale “The Palazzo” (Las Vegas, NV -USA)
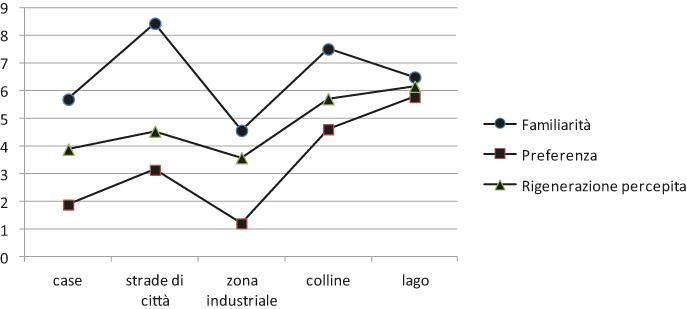
In questa pagina, dall’alto:
Grafico 1: andamento dei punteggi di familiarità, preferenza e rigenerazione percepita per 5 diverse categorie ambientali (Fonte: adattato da Berto, 1998)
Grafico 2: andamento dei punteggi di rigenerazione percepita di adolescenti, giovani adulti e anziani per 5 diverse categorie ambientali (Fonte: adattato da Berto, 2007)
Grafico 3: confronto fra il numero medio di fissazioni (rilevate ogni 40 ms per un intervallo di osservazione di 15 s) per le scene naturali e costruite, misurate per le 12 sezioni di un’immagine (sezione 1: in alto a sinistra, sezione 12: in basso a destra) Le differenze tra le sezioni 5-10 e 12 sono significative (p > .001). (Fonte: adattato da Berto, Massaccesi e Pasini, 2008)
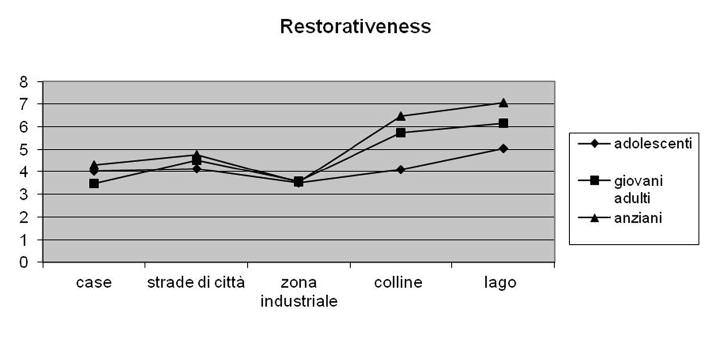
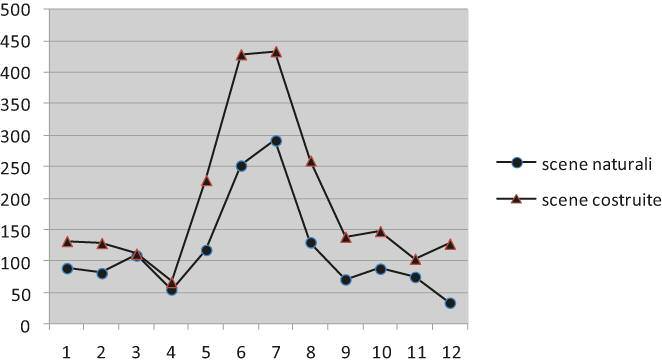
Anche le scene urbane possono essere fonte di rigenerazione perché la rigenerazione non è una questione soltanto di contenuto (naturale) ma anche di processo (Berto et al., 2010); riguarda cioè l’attivazione dell’attenzione involontaria e del sistema nervoso parasimpatico. Le soluzioni artificiali possono quindi surrogare la mancanza di Natura. È necessario però, adottare una rigorosa progettazione centrata sul bisogno di rigenerazione della persona (foto al centro).
Esistono diversi modelli di progettazione “rigenerativa”. Il più noto e diffuso è la “progettazione biofilica” (biophilic design), talvolta chiamata anche architettura biofilica o progettazione ecologica o rigenerativa. La progettazione biofilica può essere un modo per aggiungere alla sostenibilità ambientale, orientata all’ambiente esterno, la sostenibilità cognitiva (Berto, 2011; Berto et al., 2015), invitando il progettista a considerare il legame Uomo-Natura e rispondere in que-
1 L’approccio ecologico alla progettazione riguarda l’integrazione nell’ambiente naturale
2 I nostri sistemi e le nostre forme costruite devono imitare i processi, la struttura e le funzioni della Natura, così come i suoi ecosistemi
3 Il processo di design che imita gli ecosistemi è l’Ecomimesi Questa è la premessa fondamentale del design ecologico
4 C’è grande disinformazione su che cos’è il design ecologico Non dobbiamo essere né confusi né sedotti dalla tecnologia
5 Una convinzione errata ampiamente diffusa è che se un edificio ottiene un punteggio alto su un sistema di valutazione energetica, allora va tutto bene
6 Gli ecosistemi nella biosfera sono unità sistemiche costituite da elementi viventi e non viventi che agiscono come un insieme
1
sto modo alle esigenze di rigenerazione della persona
Questo è il contributo che l’ecologia e la psicologia ambientale possono offrire: aiutare i progettisti a creare ambienti rigenerativi Ci sono troppi edifici con “un deficit di Natura” e la progettazione biofilica serve a colmare il divario tra esseri umani e Natura, utilizzando le conoscenze che abbiamo in biologia evoluzionistica, ecologia e psicologia ambientale come basi per la progettazione (Barbiero, Berto, Callegari, 2016)
Perché la progettazione biofilica può essere un buon modello di progettazione “rigenerativa”? Dal punto di vista della biologia evoluzionistica, la biofilia è l’istintiva attrazione che le persone manifestano per la Natura (Barbiero, 2012). Essa consiste di un insieme di regole di apprendimento innate che si sono evolute nella specie umana per permettere una corretta relazione con la Natura. Dal punto di vista della psicologia ambientale è noto che l’esperienza con la Natura, reale o riprodotta, ha effetti rigenerativi psicologici e fisiologici (Berto, 2014; Barbiero & Berto, 2016). La progettazione biofilica sfrutta l’istintiva biofilia umana per realizzare una progettazione “cognitivamente sostenibile” (Berto, 2011) e può essere applicata a tutti i livelli, creando ambienti interni o esterni, edifici pubblici o privati, paesaggi o intere città. Gli edifici nZE possono essere l’occasione ideale per progettare rispettando anche la biofilia umana. Implementare la progettazione biofilica negli nZEB può essere particolarmente

complesso, perché richiede di allargare la visione della sostenibilità e soprattutto una serie di azioni inter-disciplinari coordinate Ma ne vale sicuramente la pena perché inserire la Natura nella progettazione non è una questione estetica, ma riguarda la qualità della vita delle persone
Il famoso architetto malese Ken Yeang (2008), uno dei pionieri nell’architettura biofilica, ha offerto una serie di principi da seguire per progettare “con la Natura” (tab. e foto qui sopra). I principi di Yeang sono densi di significato, anche se possono sembrare un poco “astratti” a chi si sta av vicinando alla progettazione biofilica. Altrettanto astratta può apparire la proposta di Cramer e Browning (2008) che invece offrono una cornice concettuale alla progettazione biofilica, proponendo tre categorie per definire gli edifici biofilici. Più recentemente, Ryan e collaboratori (2014) hanno sviluppato da queste tre categorie una lista di 14 modelli di progettazione biofilica (tab. 2 pag. 93). Questa lista sebbene sia più “concreta” e offra un ampio spettro di applicazioni, non risolve ancora lo scarto tra teoria e pratica. Siamo consapevoli che la progettazione biofilica non è una formula, ma riteniamo che fra gli
Categoria concettuale
Natura nello spazio
Analogie con la Natura
Modelli di progettazione biofilica
Contatto visivo con la Natura
Contatto non-visivo con la Natura
Stimolazione sensoriale non-ritmica
Variabilità termica e del flusso dell’aria
Presenza dell’acqua
Illuminazione naturale e diffusa
Legame con I sistemi naturali
Forme e strutture biomorfiche
Scelta di materiali naturali
Complessità e ordine
Natura nello spazio
Prospettiva
Rifugio
Mistero
Rischio/pericolo
strumenti e le opzioni a disposizione del progettista potrebbe essere utile uno strumento specificamente pensato per guidarlo e assisterlo in maniera concreta e affidabile nella progettazione biofilica: il Biophilic Quality Index (BQI)
Alla luce della nostra esperienza nell’ambito della ricerca sulla relazione Uomo-Ambiente (Barbiero, Berto, 2016) e dopo un’attenta analisi degli effetti negativi di ambienti scarsamente rigenerativi sulle risposte fisiologiche, psicologiche, affettive e comportamentali dell’individuo (Berto, Pasini, Barbiero, 2015; Berto, Barbiero 2017), abbiamo messo a punto il Biophilic Quality Index (BQI), con l’obiettivo di aiutare architetti e progettisti ad affrontare concretamente la progettazione biofilica.
Il BQI trae ispirazione dall’ipotesi della biofilia di Edward O. Wilson (1984) e dalle sue verifiche sperimentali (Barbiero, 2012; Berto, Pasini, Barbiero, 2015), dai principi del biophilic design (Joye, 2007; Reed, 2007; Kellert, 2008), dalle ricerche condotte dallo studio di consulenza statunitense Terrapin Bright Green (Ryan et al., 2014), e dalle numerose ricerche condotte nell’ambito degli ambienti rigenerativi (restorative environments; Ulrich, 1983; Kaplan, 1995; Berto, 2005; Berto et al., 2015).
Il BQI consente di valutare quanto un edificio è biofilico e può essere utilizzato sia come linea-guida da seguire nel caso di un edificio nuovo da costruire, sia come lista di controllo per un edificio già esistente, dove il punteggio finale (dato da un valore percentuale) rappresenta anche il margine di miglioramento Il BQI stabilisce robusti parametri quantitativi (piuttosto che qualitativi) e misura efficacemente i benefici rigenerativi offerti dalla progettazione biofilica
Lo strumento è composto da cinque sezioni diverse che consentono di valutare l’edificio nel suo contesto (per es nel caso di un edificio pubblico) e ogni singolo spazio all’interno dell’edificio (tab 3 pag 94); ogni sezione presenta una lista di caratteristiche ambientali la cui presenza/assenza deve essere valutata al fine di poter etichettare un edificio come “biofilico”
In pratica, ogni caratteristica delle cinque sezioni viene valutata su una scala Likert a 10 punti, si ottiene così un punteggio parziale relativo a una singola sezione e il punteggio totale finale è dato dalla media dei punteggi parziali Il punteggio finale viene poi convertito in un valore percentuale che rappresenta quanto un edificio è biofilico, per es 30%, di conseguenza c’è un margine di miglioramento del 70% Se l’edificio è valutato da due esperti indipendenti, il punteggio finale corrisponde alla media dei loro punteggi totali Di fatto, biofilico può essere un intero edificio o uno o più spazi appositamente progettati per favorire un’esperienza rigenerativa in coloro che ci vivono o ci lavorano Il BQI permette anche di valutare il potere rigenerativo dell’edificio inserito nel paesaggio urbano (Berto, et al, 2015).
Ogni spazio all’interno dell’edificio biofilico deve essere specificamente pensato per sostenere il benessere psicofisico della persona e favorire il senso di here-ness, cioè di essere tutt’uno con il luogo, e nel caso di un edificio pubblico anche di there-ness, cioè di stabilire un legame forte con il luogo che presenta caratteristiche significative per la persona.
Per questo motivo il BQI consente di valutare il grado di separazione dalle distrazioni, il livello di stimolazione ambientale (Foto pag. 94), la coerenza e la complessità degli spazi, la funzionalità, l’opportunità di contatto visivo con la Natura (Foto pag. 95) e la presenza di forme e strutture biomorfiche (Foto pag.95), tutte caratteristiche che devono essere valutate attentamente in un edificio per essere definito biofilico.
Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3A
Sezione 3B
Sezione 4
Sezione 5
L’edificio nel paesaggio urbano (6 sotto-sezioni)
Per es sotto-sezione “facciata”:
• novità
• trasparenza
• I singoli spazi all’interno dell’edificio (8 sotto-sezioni)
Per es sotto-sezione “chiusura”:
• posizione e orientamento strategico dell’edificio o dei singoli spazi confini fisici
• Opportunità di contatto visivo con la Natura (3 sotto-sezioni)
Per es sotto-sezione “piante/ecosistemi nell’ambiente interno”
Se è presente un giardino/un terrazzo/uno scoperto (3 sotto-sezioni)
Per es sotto-sezione “alberi”
Contatto non visivo con la Natura (1 sotto-sezione)
Sotto-sezione: “forme e strutture biomorfiche e materiali naturali”
Sostenibilità (2 sotto-sezioni)
Per es sotto-sezione “design”
Tabella 3 Le sezioni e alcuni esempi delle sotto-sezioni del Biophilic Quality Index di Berto e Barbiero
L’architetto è il professionista che progetta l’ambiente costruito La molteplicità di funzioni degli ambienti costruiti è tale che l’architetto deve ricorrere spesso a diversi consulenti specialisti Per la progettazione di nZEB l’architetto necessita della consulenza di ingegneri e di fisici edili i quali offrono soluzioni per ottimizzare i consumi energetici dell’edificio, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di Nature-friendliness Oggi è possibile estendere questa prospettiva anche alla sostenibilità cognitiva dell’ambiente costruito, mediante l’uso di uno progettazione biofilica scientificamente fondata. In questo caso l’architetto può avvalersi della consulenza di psicologi ambientali e di biologi ed ecologi con esperienza di ambienti rigenerativi sviluppati sulla persona e il suo passato biologico/ecologico/psicologico. Lo strumento da noi messo a punto, il Biophilic Quality Index, si è rivelato valido e affidabile sul campo e può aiutare gli architetti non solo a tradurre la teoria in pratica ma anche a fare confronti tra edifici con diversi livelli di rigenerazione percepita da parte delle persone. Poiché è possibile valutare quantitativamente la qualità biofilica di un ambiente o di un edificio, il Biophilic Quality Index si candida come strumento per gli enti certificatori che hanno già inserito il biophilic design nei loro protocolli di certificazione, i.e. WELL® e LBC® i quali, al momento, hanno a disposizione solo strumenti qualitativi ed empirici, privi cioè di una teoria e di uno strumento di misura quantitativo. Il Biophilic Quality Index può risolvere questo limite e
dare dignità scientifica alla progettazione biofilica
Nota
“Biophilic Quality Index (BQI)” è un prodotto registrato presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) con il n° 2017000273.
Bibliografia
Barbiero, G (2011) Biophilia and Gaia: two hypotheses for an affective ecology. Journal of Biourbanism, 1: 11-27. Disponibile online: http://journalofbiourbanism org/2013/01/20/biophilia-and-gaiatwo-hypotheses-for-an-affective -ecology/
Barbiero, G (2012) Ecologia Affettiva per la Sostenibilità Una risposta. Culture della Sostenibilità, 10, 126-139.
Barbiero, G (2017) Ecologia affettiva Come trarre benessere fisico e mentale dal contatto con la Natura Mondadori, Milano
Barbiero, G , & Berto, R (2016) Introduzione alla Biofilia La relazione con la Natura tra genetica e psicologia. Carocci. Roma.
Barbiero, G , Berto, R , & Callegari, G (2016) Biophilic design to address human needs for Nature in daily artificial environments Atti del 1° congresso congiunto della Società Italiana di Ecologia, unione zoological italiana, società italiana di biogeografia, Università di MilanoBicocca, 30 Agosto-2 Settembre 2016, Milano

Baroni, M R , & Berto, R (2013) Stress ambientale Cause e strategie di intervento. Carocci, Roma.
Berto, R (1998) Rapporti tra restorativeness dei luoghi e preferenza espresso Tesi di laurea, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova A a 1997-1998
Berto, R. (2005). Exposure to restorative environments helps restore attentional capacity Journal of Environmental Psychology, 25, 249-259
Berto, R (2007) Assessing the restorative value of the environment: A study on the elderly in comparison with young adults and adolescents. International Journal of Psychology, 42(5), 331-341.
Berto, R (2011) The attentional vantage offered by perceiving fascinating patterns in the environment In J A Daniels (ed ), Advances in Environmental Research, vol 6, 4th quarter Nova Science Publishers, New York, pp. 503-516.
Berto, R (2014) The role of Nature in coping with psycho-physiological stress A literature review of restorativeness Advances in Environmental Psychology, 4, 394–409 DOI: 10 3390/bs4040394
Berto, R., & Barbiero, G. (2017) How the psychological benefits associated with exposure to Nature can affect pro-environmental behavior The Scientific Pages of Cognitive Science, 1, 16-20
Berto, R , Barbiero, G , Pasini, M & Unema, P (2015) Biophilic design triggers fascination and enhances psychological restoration in the urban environment Journal of Biourbanism, 1, 26-35
Berto, R , Baroni, M R , Zainaghi, A , & Bettella, S (2010) An exploratory study of the effect of high and low fascination environments on attentional fatigue. Journal of environmental psychology, 30(4), 494-500.
Berto, R , Magro, T , & Purcell, A T (2004) La percezione della restorativeness in un gruppo di adolescenti In G Carrus, F Fornara, C Plaino, M Scopelliti (a cura di), La psicologia ambientale in Italia Secondo incontro nazionale Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e della socializzazione DC-ROM
Berto, R , Massaccesi, S , & Pasini, M (2008) Do eye movements measured across high and low fascination photographs differ? Addressing Kaplan’s fascination hypothesis Journal of Environmental Psychology, 28, 185-191
Berto, R , Pasini, M , & Barbiero, G (2015) How does psychological restoration work in children? An exploratory study Journal of Child and Adolescent Behaviour, 3, 1-9 Disponibile on line: http://dx doi org/10 4172/2375-4494 10002000
Cramer, J S , & Browning, W D (2008) Transforming building practices through biophilic design In S F Kellert, J H Heerwagen, & M L Mador (Eds ), Biophilic Design Wiley, Hoboken, NJ, pp 335-346
Hernandez, B , Hidalgo, C , Berto, R , & Peron, E (2011) The role of familiarity on the restorative value of a place: Research on a Spanish sample. IAPS Bulletin, special issue on environmental cognition in memory of Mimma Peron, 18, 22-24

Joye, Y (2007) Architectural lessons from environmental psychology: The case of biophilic architecture. Review of General Psychology, 11(4), 305-328
Kaplan, S (1995) The restorative benefits of Nature: Towards an integrative framework Journal of Environmental Psychology, 15, 169-182
Kellert, S.R. (2008). Dimensions, elements, attributes of biophilic design In S F Kellert, J H Heerwagen, & M L Mador (Eds ), Biophilic Design Wiley, Hoboken, NJ, pp 3-19
Purcell, T A , Peron, E , & Berto, R (2001) Why do preferences differ between scene types? Environment and Behavior, 33(1), 93-106.
Reed, B (2007) Shifting from “sustainability” to regeneration Building Research & Information Taylor & Francis
Ryan, C , Browning, W D , Clancy, J O , Andrews, S L , & Kallianpurkar, N.B. (2014). Biophilic design patterns. Emerging Nature-based parameters for health and well-being in the built environment International Journal of Architectural Research, 8(2), 62-76
Ulrich, R S (1981) Natural versus urban scenes Some psychological effects. Environment and Behavior, 13, 523-556.
Ulrich, R S (1983) Aesthetic and affective response to natural environment In Altman I , Wohlwill J F (eds ), Behavior and The Natural Environment, Plenum, New York, pp 85-125
Wilson, E.O. (1984). Biophilia. Harvard University Press, Cambridge. Yeang, K (2008) Ecoskyscrapers and ecomimesis: New tall building typologies, CTBUH 8th World Congress
Rita Berto, psicologa ambientale, e Giuseppe Barbiero, biologo, lavorano insieme al Laboratorio di Ecologia Affettiva dell’Università della Valle d’Aosta Hanno pubblicato Introduzione alla biofilia La relazione con la Natura tra genetica e psicologia (Carocci, 2016) e svolgono attività di consulenza per la progettazione biofilica
Per contatti: rita berto@hotmail it
Nella pagina a fianco, in basso: esempio di luce naturale e diffusa, di legame con i sistemi naturali e di stimolazione sensoriale non ritmica in ambiente interno Soffitto della hall del resort Aria (Las Vegas, NV -USA) Qui sotto a sinistra, esempio di contatto visivo con la Natura e legame con i sistemi naturali in un ambiente interno, ristorante Schuhbeck all’interno dell’aeroporto di Monaco di Baviera (D) La presenza di elementi naturali favorisce il benessere dei viaggiatori e consente loro di vivere una “micro” esperienza rigenerativa dalla fatica del viaggio Qui sotto, esempio di struttura biomorfica, una delle pareti del ristorante di pesce “Fin”all’interno dell’Hotel Bellagio (Las Vegas, NV -USA)